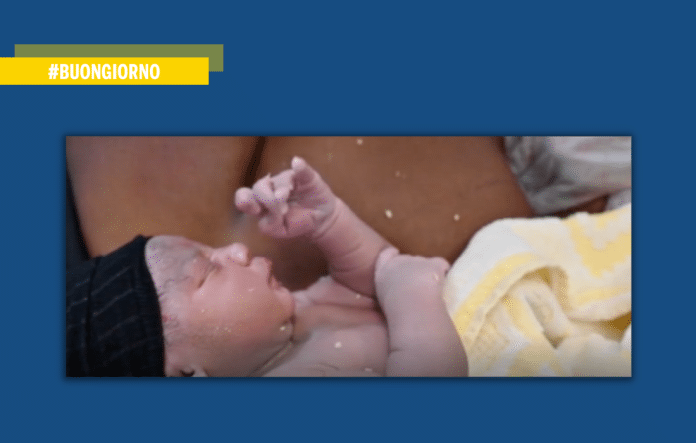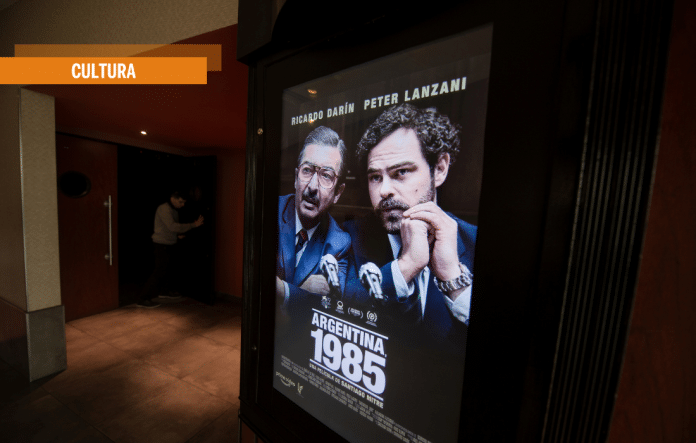Mentre assistiamo allo psicodramma che si svolge in casa Pd, non possiamo non rattristarci di fronte allo spettacolo altrettanto mesto che ha luogo fuori da quella casa, per i suoi toni beckettiani se non alla Ionesco. Personaggi muti recitano a soggetto, afoni. Nessuno ode, perché non si profferisce verbo. La vicenda Soumahoro, poi, nel mostrarne la superficialità, li ha solo ammutoliti oltre ogni ritegno. La classe dirigente che mancò, questo sarà il responso degli storici nello studiare dov’è finita la sinistra, solo un secolo dopo quella partenogenesi catartica che era stata spinta dal mito propulsivo della rivoluzione bolscevica. Perché il fatto è che la sinistra – nelle forme che ha assunto dopo l’89 – si è pericolosamente avvicinata al baratro della sua estinzione.
La sinistra in Italia
Ventuno anni fa, nel 2001, Ds e Margherita – che si fonderanno poi nel Pd – raccolsero, rispettivamente, 6,15 e 5,39 milioni di voti (il 31,2%), mentre Rifondazione comunista e Comunisti italiani ne ottennero 1,87 milioni e 620mila (6,7%). Cinque anni dopo, l’Ulivo di Ds e Margherita ne prenderà 11,9 (il 31,3%) e Rc e Ci, separatamente 3,1 (l’8,16%). Se aggiungiamo i socialisti, la lista di Di Pietro e i Verdi, che nel complesso ne raccolsero 2,65 milioni (il 7%), alla sinistra andarono 17,7 milioni di consensi (la coalizione, con un’alleanza di ben tredici liste raccolse 19 milioni di voti e la maggioranza, d’un soffio). Dopo di allora, il declino. Il Pd, con l’esordio con Veltroni, è sceso dai 12 e passa milioni di voti (33,2%) del 2008, agli 8,65 milioni del 2013 (25,43%), ai 6,16 del 2018 (18,8%) fino ai 5,36 milioni del 2022 (19.1%). Alla sinistra del Pd, le varie reincarnazioni di partiti e liste sono passate, nel complesso, dal milione e mezzo di voti del 2008 (il 4,1%) al milione di Sel, in coalizione col Pd (3,3%), più gli 850mila delle altre liste (2,6%) nel 2013. Nel 2018, un’uguale divisione ha portato 1,11 milioni a LeU (3,4%) e 500mila voti alle altre (1,52%), laddove nel 2022 l’Alleanza SI+V ha raccolto poco più di un milione di voti (3.6%), Unione popolare 403mila (1.43%), mentre le altre liste, però solo in parte riconducibili alla sinistra, hanno preso 906mila voti (3.23%). In ventun anni, quindi, la sinistra, nelle sue varie articolazioni, è passata da un consenso di 17,7 milioni di voti a poco più di 7 milioni, con un crollo che comincia solo dopo il 2006. Aggiungiamoci pure il M5s, presente solo nelle ultime tre tornate, e il totale raggiunge oggi gli 11,4 milioni. Se è principalmente il Pd che ha visto dimezzare i suoi consensi, anche il resto del vario arcipelago non ha certo brillato, riducendo il suo bacino di ben due terzi. E l’appeal dei 5 Stelle, che raccolse il malumore sociale degli anni dell’austerity nel 2013, confermato poi cinque anni dopo, si è notevolmente ridimensionato.
La sinistra, è evidente, ha perso il favore di una buona fetta del suo elettorato, provocando una «delusione» che si è riflessa nell’aumento dell’astensione. L’affluenza, infatti, è scesa dall’83,6% del 2006 (era stata l’81,3% nel 2001) all’80,5% del 2008, passando poi al 75,2% del 2013, al 72,9% del 2019 fino al 63,8% del 2022. In sostanza, è aumentata la disillusione democratica, con un’astensione che ha ormai superato un terzo degli elettori.
Il Paese dei divari
Nello stesso arco di tempo, però, la situazione economica e sociale del Paese è andata peggiorando. Non solo il Pil ha smesso di crescere, non tornando più ai livelli del 2007, in termini reali, ma lo stato complessivo dell’economia non ha fatto che divenire via via più fosco. Le disuguaglianze di reddito sono rimaste alte (tra le maggiori in Europa occidentale), la mobilità sociale si è fermata, l’occupazione è debolmente aumentata (meno che altrove), ma solo grazie al lavoro precario, la disoccupazione è rimasta alta (più che altrove), soprattutto nelle fasi cicliche, la povertà affligge ormai un quarto delle famiglie, anche tra i lavoratori (come nei Paesi europei meno avanzati). I divari territoriali, poi, sono andati peggiorando, con un Mezzogiorno che si allontana vieppiù dal Centro-nord, la migrazione interna e verso l’estero in aumento, la popolazione residente in calo continuato (più al Sud che al Centro-nord), la natalità in continua frenata, non compensata dall’immigrazione, minima. I salari e gli stipendi sono altresì fermi se non in calo, in termini reali, soprattutto per le categorie meno qualificate. Anche la struttura sociale è andata ingessandosi, sfarinandosi vieppiù tra le fasce più deboli. Forse la classe operaia non esiste più, come una certa vulgata ama dire, eppure gli operai e assimilati rappresentano ancora il 34,2% degli occupati (nel 2021), esattamente come dieci anni prima. E, però, sono meno garantiti, più nei settori dei servizi che nel manifatturiero. La crescita del reddito, quando vi è stata, si è accompagnata ad un aumento della disuguaglianza, beneficiando di più le famiglie con i livelli reddituali medio-alti. A rimanere indietro sono stati soprattutto i giovani, colpiti in misura crescente dal rischio di povertà. La crescita del reddito del quinto della popolazione con introiti più bassi è stata sempre più contenuta di quella registrata negli altri quinti. In sostanza, i meno abbienti sono divenuti via via relativamente più poveri dei più benestanti, perché più precari, meno protetti. Tuttavia, sarebbe sbagliato ritenere che ciò è accaduto solo perché il Paese ha attraversato due crisi – quella economica e quella indotta dalla pandemia – sopravvivendo, perché il suo corpo sociale ne ha sofferto in modo non equo: un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro al mese, un italiano su quattro è in condizione di povertà, l’occupazione è sempre più precaria, il divario di reddito e territoriale è aumentato. Il «cuore» dell’economia e della società più «tutelato» si è ristretto e si è allargata l’area attorno, quella periferica e marginale, ma non per questo meno funzionale ad essa. C’è qualcosa di distorto e di profondamente iniquo se il sistema va evolvendosi verso una società nuovamente «classista» e, in definitiva, sbagliata. Di cui la politica dovrebbe occuparsi e che ha, invece, trascurato, anzi contribuendovi.
La sinistra verso il baratro
Con la «globalizzazione», il capitalismo è entrato in una nuova era, favorita dalla tecnologia e dalla geo-politica. Il modello neo-liberista, riaffermatosi negli anni Ottanta contro il neo-keynesismo in crisi, ha però colto le sinistre impreparate, ritenendo queste che il capitalismo sostenuto dalla democrazia liberale che garantiva welfare e una promessa di emancipazione per le masse come si era sviluppato nel dopoguerra avrebbe continuato ad evolversi lungo quei binari. Ma la certezza della crescita per tutti, corretta dalla redistribuzione, si è presto rivelata un’illusione, una volta che le praterie del mondo «limitless» e «borderless» si sono aperte al capitalismo globalizzato. Perché sono stati il lavoro e i suoi prestatori a pagarne il prezzo, a favore del capitale.
E i nodi sono venuti al pettine. Il capitalismo predatorio produce sfruttamento e si fonda sulle disuguaglianze. Affidarsi al mercato, anche nella gestione dei beni pubblici, genera sperequazioni. Nel mercato globale, il lavoro non è tutelato e se non è lo Stato, o le istituzioni sovranazionali, ad intervenire, la piramide sociale non farà che farsi più alta e stretta. La sinistra, abbandonata definitivamente la prospettiva di una trasformazione del «sistema», si è limitata a difendere quel sistema così come lo aveva prefigurato nei decenni addietro: ma esso è cambiato e, con esso, la struttura sociale, con la «disarticolazione» del lavoro e la iper-frammentazione del suo mercato. In questa dinamica, la sinistra ha finito per rappresentare vieppiù gli interessi delle classi medie e medio-basse tutelate, del lavoro dipendente e impiegatizio, strutturato, non riuscendo più a raccogliere quelli delle classi basse e «periferiche». Che si sono così allontanate.
Ciò è apparso, in modo plastico, nel 2013: dopo una legislatura all’insegna del rigorismo neo-liberista europeo, sposato dal Pd, il crollo dei consensi è stato immediato, tutto a vantaggio della proposta «egalitaria» portata avanti dai 5 Stelle. La legislatura seguente non ha inciso per nulla sul quadro sociale ed economico e nel 2018 il Pd ha pagato un prezzo ancora maggiore. E nel frattempo la disaffezione democratica dei ceti popolari non ha fatto che aumentare. Come hanno confermato le ultime elezioni, nelle quali a destra ha chiamato a raccolta i suoi elettori di sempre, mentre la sinistra ne ha persi, per lo più tra gli astenuti. Tanto quella raccolta attorno al Pd, quanto l’altra, che non ha saputo articolare una convincente proposta alternativa.
In termini gramsciani, si potrebbe dire che il «blocco sociale» della sinistra non esiste più. O meglio, non ne esiste più una rappresentazione politica. Le classi popolari sono lì che attendono, che domandano rappresentanza. Un nuovo classismo ha cominciato a farsi strada, nuovi steccati sono stati eretti, fino a disgregare il tessuto sociale che aveva fornito la linfa democratica alla «società del benessere». Che ha cominciato ad essere prerogativa di maggioranze via via più ridotte. Con i poveri alle frontiere e nelle periferie.
Erano anni che si diceva che le disuguaglianze non trattate, che la mobilità sociale ridotta avrebbero portato allo sfaldamento del tessuto democratico. Erano anni che si gridava che l’Europa «sociale» era rimasto un mito sfoderato solo per nascondere quella del libero mercato, che l’illusione della «crescita per tutti» non avrebbe retto. E così è stato. Riflettendosi nei risultati elettorali.
I partiti della sinistra si sono via via sfarinati, chi dietro bandiere lise, chi dietro nuovi miti modernisti, «interclassisti», oltre le classi perché «le classi non ci sono più». Così, elezione dopo elezione, le classi popolari hanno cercato altrove, appellandosi a chi faceva loro gola, strumentalmente. Per ritirarsi, pian piano, nella disillusione.
Questa è la responsabilità storica: aver fatto svanire l’illusione democratica che uno Stato equo avrebbe provveduto ai più, prendendo da chi ne ha per dare a chi non aveva avuto le stesse opportunità. Storica perché segna un’epoca. Già nel 2013 era apparso chiaro: attenzione, chi si appella a istanze egalitarie troverà consenso, per quanto strumentale. Niente, da sinistra non è venuto alcun ripensamento, da tutta la sinistra. E si è giunti al 2018 senza aver riflettuto per un solo momento sugli errori. E si è continuato, fino a finire nel baratro quattro anni dopo.
La coazione continua. Ci fosse uno solo di quella classe dirigente che affermi di voler ripensare tutto. Sta forse avvenendo una discussione su quale società, quale sistema di relazioni economiche e sociali, quale modello si vuole? Nel Pd si parla di nulla, nuove persone per un partito senza progetto. Fuori dal Pd si coltivano orticelli identitari. Altri ora sventolano la bandiera «progressista», guardando all’oggi, piccoli cabotaggi per restare a galla senza cambiare nulla. Le ragioni delle iniquità restano, vittime del capitalismo globalizzato restiamo tutti, subendolo come se non ci fosse nulla da fare. Non «ce lo dice l’Europa», è la mancanza del coraggio del pensiero, il problema.
L’autore: Pier Giorgio Ardeni è professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo all’Università di Bologna. È stato candidato per Unione popolare in Emilia Romagna
Nella foto: l’assemblea nazionale del Pd, 19 novembre 2022