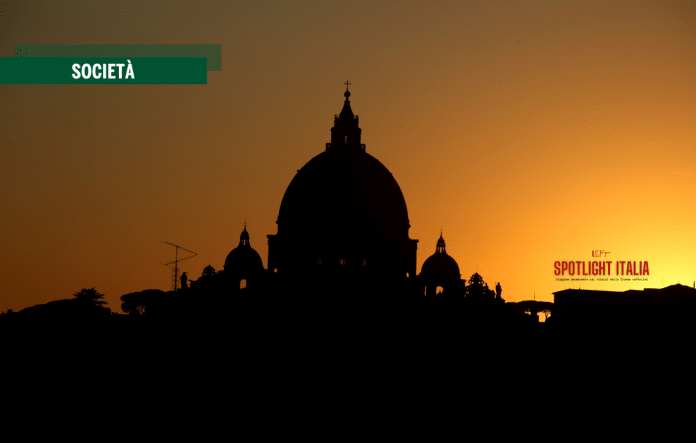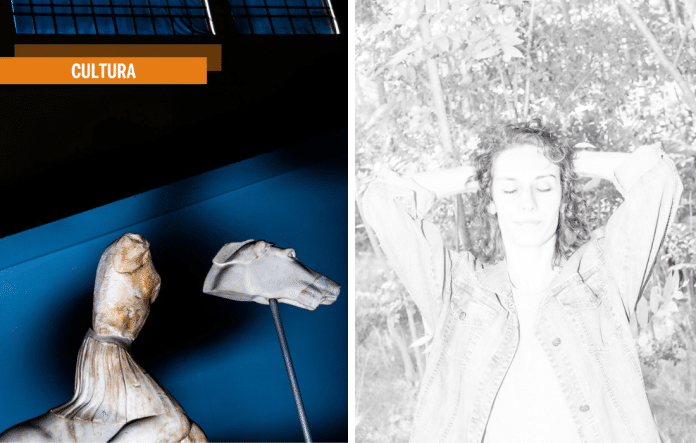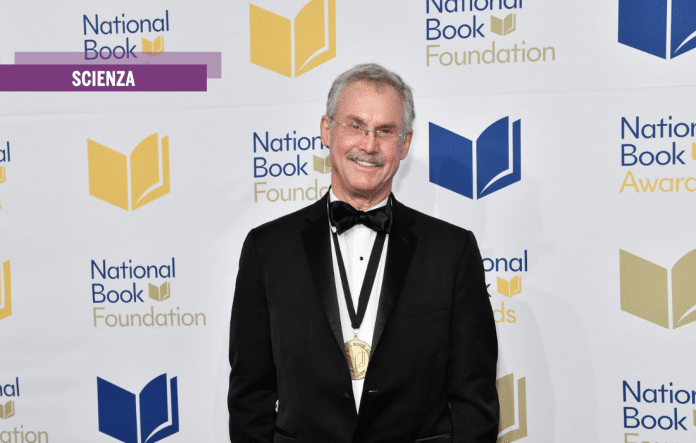«Mio padre ha sostenuto economicamente me e i miei figli fino alla sua morte. Quando ho ottenuto l’eredità, ho costruito una casa per me e i miei figli e mi sono comprata un’auto» racconta Naela Ali Faheem Abu Jiba, una donna di 40 anni proveniente dalla Striscia di Gaza. «Un giorno mi trovavo in un salone di bellezza e ho sentito una cliente discutere con il marito al telefono sulla necessità di avere un’auto. In quell’occasione mi è venuta l’idea di creare un servizio di trasporto per le donne». Così Naela ha iniziato a lavorare come tassista. Un settore, quello dei trasporti, dominato dagli uomini e un’idea, quella di Naela, rivoluzionaria, per i Territori palestinesi occupati ed in particolare per la Striscia di Gaza.
La tassista offre un servizio utile ed efficiente per le donne palestinesi, che, grazie a lei, si sentono più sicure nei loro spostamenti. In una società patriarcale che limita la libertà di movimento delle donne, muoversi in autonomia e sicurezza diminuisce la dipendenza dai maschi di famiglia e le solleva dalla pressione sociale e dai pregiudizi legati al fatto che una donna salga su un taxi guidato da un uomo. Naela è una pioniera, e non è l’unica.
Rimah Jihad Atallah Al-Behissi, una ventenne di Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza, lavora nel campo dell’energia solare, altro settore tipicamente dominato ovunque dagli uomini. Scegliendo questa professione, Rimah ha dovuto superare gli ostacoli che le donne palestinesi devono sistematicamente affrontare quando cercano di accedere al mercato del lavoro, così come gli stereotipi di genere che hanno confinato le donne palestinesi in pochi settori, in particolare quello della cura (istruzione, sanità, assistenza sociale e lavoro domestico).
La partecipazione femminile al mondo del lavoro è ancora molto bassa ed il divario occupazionale tra i generi è estremamente ampio. Secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese (Pcbs), nel 2020 solo il 16% di tutte le donne in età lavorativa nei Territori palestinesi occupati lavorava, rispetto al 65% degli uomini. Tra la popolazione femminile, in Palestina si rileva un alto livello di scolarizzazione. Questo non va però ad influire positivamente sull’occupazione: il tasso di disoccupazione, che per le donne è del 40%, sale infatti al 69% se si considerano le giovani laureate. Il dato scioccante è che, per quanto riguarda le donne palestinesi, più queste sono istruite e più alto è il tasso di disoccupazione. In altre parole, un titolo universitario non aumenta la probabilità di ottenere un lavoro e ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, sebbene il 61% degli studenti iscritti agli istituti di istruzione superiore siano donne, il tasso di disoccupazione femminile continua ad essere molto più alto di quello maschile.
Anche Babel Ahmed Qdeih ha studiato e alla fine ha deciso di aprire un proprio negozio, dove fornisce alle donne di Gaza servizi di programmazione e manutenzione dei telefoni. «Sto cercando di conciliare il lavoro e i doveri familiari», ammette. Nei Territori palestinesi occupati, l’80% degli uomini e il 60% delle donne ritiene che «il ruolo più importante delle donne è quello domestico», mentre il 75% degli uomini e il 51% delle donne afferma che per le donne è più importante sposarsi che avere una carriera. Questi atteggiamenti influenzano le aspirazioni delle donne e la definizione delle loro priorità. Il risultato, tra l’altro, è che il 94,8% delle donne sono occupate nel lavoro domestico e di cura, rispetto al 42,5% degli uomini. Nella Striscia di Gaza, le donne disoccupate spendono in media 12 ore al giorno per l’assistenza non retribuita e il lavoro domestico. Questo rende particolarmente difficile per loro lavorare fuori casa.
Avviare attività in proprio risulta difficile perché l’accesso al credito e ad altre risorse essenziali per l’avvio di un’attività sono in mano agli uomini, che amministrano anche i beni delle famiglie. «I principali ostacoli che ho affrontato provengono dalla mia famiglia e dalla società. La mia famiglia voleva che lasciassi il mio lavoro: non voleva che il nome della famiglia fosse legato al mio lavoro come tassista», racconta ancora Naela.
Oltre a questo, l’occupazione militare israeliana limita ulteriormente l’accesso delle donne al lavoro e alle opportunità di sviluppo in generale. Insieme alla presenza dei coloni e il blocco nella Striscia di Gaza, l’economia locale è in sempre maggiore crisi, le opportunità di lavoro si riducono e le donne sono le prime a essere tagliate fuori. «I principali ostacoli che ho incontrato sono stati la mancanza di risorse disponibili e la difficoltà a ottenere una formazione pratica, dato che sono una ragazza e tutti gli specialisti in questo campo sono uomini», afferma Babel, la “donna elettrica”.
Babel, Naela e Rimah rappresentano la caparbia e determinazione di molte giovani palestinesi, che nonostante la situazione economica di Gaza e il contesto sociale e familiare non si arrendono e costruiscono semi di futuro. Affrontando e superando discriminazioni multiple, combattono ogni giorno per liberarsi del fardello delle aspettative sociali, seguendo le proprie passioni e aspirazioni. Delle vere e proprie rivoluzionarie che affrontano critiche e pressioni, soprattutto da parte della loro comunità, eppure decidono di continuare a sfidare i pregiudizi attraverso il loro lavoro. Come dice Naela, la tassista, «Il mio lavoro non è vergognoso, anche se non è convenzionale per la società palestinese. Sarebbe sbagliato non continuare. Devo affrontare le difficoltà e assumermi le responsabilità per l’emancipazione economica e morale di altre donne».
Interviste raccolte nell’ambito del progetto Cospe “Gender Equality in the Economic Sphere: Our Right, Our Priority” in Palestina