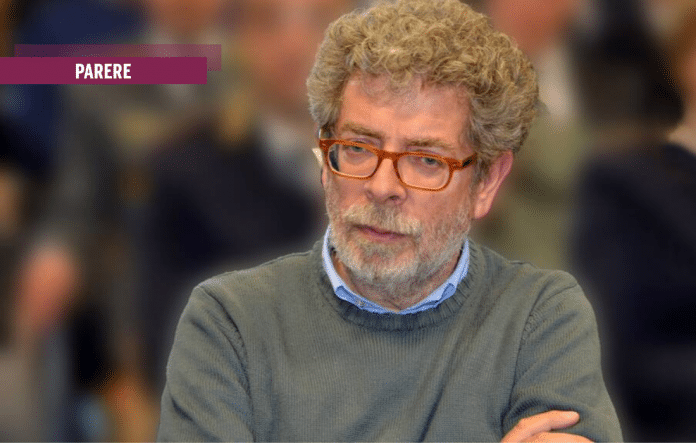«A 174 anni dal manifesto del comunismo di Marx, in Europa si aggira un altro spettro, quello dell’ambientalismo nella sua forma degenerata». Parola di Nicola Procaccini, uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni, responsabile nazionale del dipartimento Ambiente ed energia di Fratelli d’Italia, europarlamentare – attualmente indagato con le accuse di turbativa d’asta e induzione indebita a dare o promettere utilità, nell’ambito dell’inchiesta sulle concessioni demaniali a Terracina, la sua città natale.
Lo scorso 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, Procaccini ha presentato il “Manifesto dell’ecologia conservatrice”, ribadendo in questa occasione l’importanza dell’attenzione all’ambiente e del territorio da parte della destra italiana. Ma attenzione a non farsi illusioni, perché questa forma di rispetto non dovrà condurre «alla mortificazione delle attività economiche ma a un giusto equilibrio con i temi legati all’emergenza ecologica». Soprattutto, ci tiene a precisare il big di FdI, la Fiamma rifugge le posizioni ideologiche tipiche «di un certo ambientalismo di sinistra».
Servirebbe ricordare a Procaccini che spesso, a Bruxelles e Strasburgo, i gruppi della destra sovranista che siedono tra i banchi dell’europarlamento – di cui fanno parte anche il suo stesso partito e la Lega salviniana – hanno quasi sempre cassato le proposte per attuare le politiche ambientali ed energetiche contro il riscaldamento globale. E la loro eventuale vittoria alle elezioni del 25 settembre – molto probabile, secondo tutti i sondaggi – potrebbe mettere seriamente a rischio la lotta contro il cambiamento climatico.
Tuttavia, la strada per tener fede agli impegni europei di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra al 2030 passa quasi sicuramente per un esecutivo a trazione sovranista, elezioni permettendo. La grande favorita a sostituire Mario Draghi a Palazzo Chigi sembra essere proprio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che guida una coalizione di cui fanno parte anche la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi.
Ma che ne pensa la leader della destra italiana della questione climatica? Nel suo intervento alla conferenza programmatica di FdI dello scorso aprile, Giorgia Meloni non spende una parola contro la crisi climatica, e non perde tempo a incalzare Mario Draghi a chiedere all’Ue la revisione del Pnrr e dei suoi obiettivi ambientali e climatici definiti «irraggiungibili», figli di una strategia «poco intelligente» che sembra «scritta da Greta Thunberg». E riguardo ai combustibili fossili? Abbandonarli è “velleitario” secondo l’ex ministra della Gioventù.
Ma attenzione: non è che ai patrioti non interessi il tema, tutt’altro. Ma la sostenibilità ambientale può e deve essere coniugata con la sostenibilità economica al netto della “cieca ideologia green” che tutto blocca e impedisce.
Facendo riferimento alla mobilità elettrica, la leader di FdI chiede al suo uditorio se «vogliamo combattere l’inquinamento legandoci mani e piedi ai Paesi più inquinanti al mondo», ovvero la Cina da cui importiamo auto elettriche. Ovviamente non ci pensa nemmeno a far balenare l’idea di spronare gli imprenditori italiani a rinnovare la filiera automotive nazionale per renderla al passo con le sfide del XXI secolo. E sembra non saperne niente dei colossali investimenti europei sulle batterie e la mobilità elettrica.
All’interno del piano contro il cambiamento climatico, chiamato “Fit for 55”, che prevede la riduzione del 15% delle emissioni inquinanti dal mondo dei trasporti e dell’automobile entro il 2025, lo scorso 8 giugno il parlamento Ue ha approvato la proposta della Commissione Europea di vietare la produzione e la vendita di auto con motori termici a partire dal 2035.
Il testo è stato approvato con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astenuti. Tra gli oppositori i gruppi di estrema destra Identità e Democrazia (Id), di cui fa parte la Lega di Salvini (insieme ai francesi del Rassemblement National di Marine Le Pen, gli austriaci del Partito della Libertà e ai tedeschi di Alternative für Deutschland) e Conservatori e riformisti europei, di cui fa parte Fratelli d’Italia. A cassare la proposta sono stati anche alcuni membri del più moderato Partito popolare europeo, in primis gli italiani di Forza Italia.
Molto esemplificativo, in questo caso, è il discorso pronunciato in sede di discussione dall’eurodeputato leghista Paolo Borchia: il Commissario al green deal Frans Timmermans è definito “surreale”, mentre in realtà l’ambizione climatica maschererebbe «grossi interessi economici e un’overdose di ideologia». E le politiche green servirebbero non ai cittadini europei, ma alla Cina per «sferrare il colpo di grazia all’industria europea». Gli fa eco la compagnia di partito Isabella Tovaglieri: dopotutto, in questo momento «è davvero rischioso sacrificare le economie europee sull’altare dell’utopia ecologista della svolta verde».
La destra italiana ha dato il meglio di sé anche lo scorso 22 giugno, in occasione del voto per la riforma del mercato di carbonio e l’introduzione di un nuovo Fondo sociale per il clima, approvato grazie al sostegno dei principali gruppi parlamentari ma ovviamente osteggiato da Meloni, Salvini e dai loro omologhi europei. Per l’eurodeputata Silvia Baldassarre (Lega), le misure per il clima sarebbero una sorta di «autolesionismo politico» per l’Ue, mentre il Fit for 55 %, un pacchetto «che porterà a un aumento di tasse e bollette pur di rincorrere il solito idolo green a tutti i costi». Invece, per Raffaele Fitto (FdI) le posizioni pro-clima dello schieramento progressista sarebbero puro «furore ideologico».
È proprio sui grandi interessi economici e fonti inquinanti, che si vede, anche in sede di voto europeo, quanto sia ambientalista la destra italiana. Quando una parte del Parlamento europeo (socialisti, verdi e sinistra) hanno provato a fermare la “tassonomia” della Commissione Europea – che bollava come green gli investimenti in nucleare e gas – i gruppi di Meloni e Salvini si sono, ovviamente opposti.
In poche parole, la destra è contraria a qualsiasi intervento politico volto a incidere su una trasformazione del nostro sistema economico improntata alla transizione energetica ed ecologica. E, se il deputato leghista Claudio Borghi sostiene di voler «buttare a mare» il Green Deal europeo, Giorgia Meloni afferma che «l’ecologismo non si impone dall’alto» ma che bisogna cominciare a «difendere il proprio giardino». L’idea è che nessuna iniziativa dall’alto debba mettere a repentaglio le iniziative economiche predatorie dell’uomo.
All’ambientalismo di sinistra, incentrato sulla lotta contro la crisi climatica e i combustibili fossili, Meloni e soci contrappongono l’ecologismo del pensatore ultraconservatore britannico Roger Scruton (deceduto nel 2020), alfiere di un ambientalismo mistico che riprende l’antica triade di Dio, Patria e Famiglia, dove alla questione ambientale non viene data un’accezione globale, ma territoriale e identitaria, un concetto di protezione della natura reazionario, avulso dalle moderne politiche sulla riduzione delle emissioni e di contrasto al cambiamento climatico.
Il prossimo 25 settembre toccherà al popolo italiano scegliere tra il “globalismo ecologista” che si contrappone al negazionismo climatico opportunatamente mascherato da ambientalismo: da una parte c’è chi chiede la transizione ecologica, la riduzione delle emissioni, lo stop all’uso delle fonti fossili. Dall’altra quelli come Procaccini, secondo cui «davvero un certo ambientalismo pensa sia più importante difendere un cucciolo di foca rispetto al cucciolo custodito nel grembo di una donna?».
Elettori italiani, a voi la scelta.
Nella foto: Giorgia Meloni all’Assemblea dell’associazione industriali di Cremona, 6 ottobre 2020





 Parliamo ancora di “prezzi da pagare”: il segretario generale della Nato Stoltemberg ha dichiarato che questo inverno l’Europa pagherà un prezzo molto duro per il sostegno all’Ucraina. Chi pagherà davvero questo prezzo? Per ottenere quali risultati? Letta cinque mesi fa diceva che le sanzioni avrebbero piegato il governo russo in pochi giorni…
Parliamo ancora di “prezzi da pagare”: il segretario generale della Nato Stoltemberg ha dichiarato che questo inverno l’Europa pagherà un prezzo molto duro per il sostegno all’Ucraina. Chi pagherà davvero questo prezzo? Per ottenere quali risultati? Letta cinque mesi fa diceva che le sanzioni avrebbero piegato il governo russo in pochi giorni…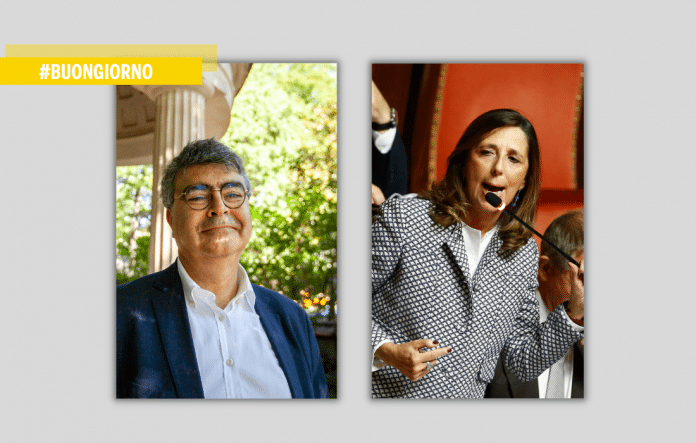

 Il trio nasce quindi con questa concezione dell’esperienza musicale, ovvero quella di costituire un’ identità nuova che fosse però l’integrazione e lo sviluppo delle idee di ciascuno dei componenti?
Il trio nasce quindi con questa concezione dell’esperienza musicale, ovvero quella di costituire un’ identità nuova che fosse però l’integrazione e lo sviluppo delle idee di ciascuno dei componenti?