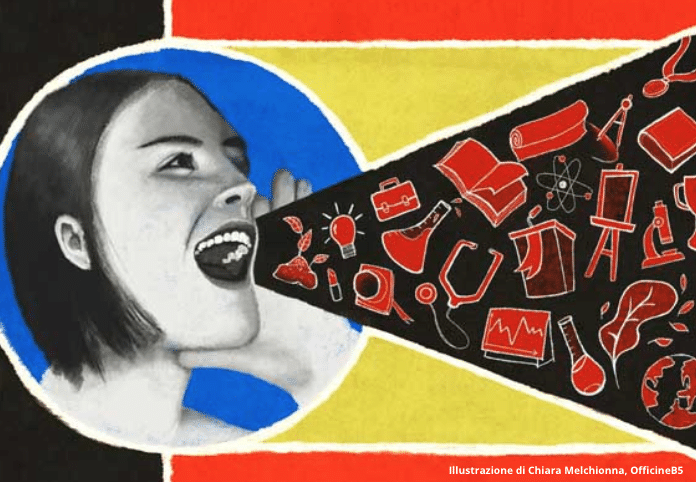Il 22 agosto 2014 le Abuelas di Plaza de Mayo annunciarono il ritrovamento della nipote di Alicia Zubasnabar de la Cuadra, la prima presidente dell’associazione, morta nel giugno del 2008 senza poter abbracciare la ragazza. È la centoquindicesima nipote ritrovata. Si chiama Ana Libertad ed è una cittadina dei Paesi Bassi, avendo sposato un uomo olandese, ma la sua storia è legata a doppio filo con l’Italia. Gran parte della sua famiglia di origine vive a Milano dopo un esilio forzato dall’Argentina nel 1977, l’anno della sua nascita.
Dalla sua vicenda, che chiama in causa anche l’attuale pontefice, Jorge Mario Bergoglio, all’epoca capo dei gesuiti argentini, prende le mosse il libro “Figli rubati. L’Italia, la Chiesa e i desaparecidos” di Federico Tulli (L’Asino d’oro ed.).
Ecco un brano del primo capitolo che pubblichiamo in occasione del 45esimo anniversario del golpe civico-militare argentino (24 marzo 1976-2021)
In cerca di Ana Libertad
*-*
Verso le ore 21 del 23 febbraio 1977, undici mesi dopo quel 24 marzo in cui una giunta militare aveva preso il potere in Argentina, scatenando quella ‘guerra sporca’ che fece conoscere al mondo il fenomeno dei desaparecidos, un commando di uomini armati e in divisa attaccò improvvisamente con gas e lacrimogeni uno studio dentistico a La Plata, una tranquilla cittadina a circa 60 chilometri da Buenos Aires, al cui interno si stava svolgendo una riunione tra attivisti del Partito comunista marxista leninista (Pcml). L’azione militare durò pochi minuti; secondo la testimonianza di alcuni vicini si concluse con la cattura di sei persone costrette a uscire dall’appartamento per via dell’aria irrespirabile. Héctor Carlos Baratti, Elena de la Cuadra, Eduardo Roberto Bonín, Pedro Campano, Norma Estela Campano de Serra e Humberto Luis Fraccarolli Molina vennero caricati a forza su delle camionette, incappucciati e portati via velocemente verso il V Commissariato cittadino.
In un giorno imprecisato di luglio dello stesso anno, Alicia (Licha) Zubasnabar de la Cuadra trovò un biglietto sotto la porta dell’appartamento in cui viveva a La Plata: «16/6 la signora ha avuto una bambina, non si sa dove sia la bambina, i genitori stanno bene, de la Cuadra» scriveva un anonimo confermando così ad Alicia e al marito Roberto che la loro figlia Elena, rapita al quinto mese di gravidanza e di cui non avevano più avuto notizie, aveva partorito. La famiglia di Roberto e Alicia de la Cuadra era stata già duramente colpita dalla repressione. Il 2 settembre 1976, Roberto José, fratello di Elena e anch’egli membro del Pcml, era stato rapito in casa dei genitori. Sempre nel 1977 era stata la volta del marito di Estelita, sorella di Elena e Roberto José, Gustavo Fraire, e del cognato, Juan Raúl Bourg, e della moglie, Alicia Rodríguez Saenz. L’arresto di Gustavo costrinse Estelita a un esilio rocambolesco verso l’Italia dove viveva un altro fratello, Luis Eduardo: passò attraverso il Brasile dove entrò con suo padre, fingendo di essere una coppia di turisti. Poco dopo dovettero fuggire dall’Argentina anche l’altra sorella Soledad e il marito Carlos Horacio Bourg, fratello di Juan Raúl.
Due giorni dopo il rapimento di Elena i suoi genitori cominciarono a cercarla e presentarono immediatamente una richiesta di habeas corpus all’autorità giudiziaria senza alcun esito. Non ebbero fortuna nemmeno su intercessione della Chiesa cattolica locale. Il loro colloquio con il vicario militare Emilio Teodoro Grasselli, che gli confermò l’arresto di Elena, fu descritto nel 2011 da Estelita de la Cuadra nel corso del processo contro il Piano sistematico di appropriazione dei bambini, leggendo alcuni appunti presi dal fratello Roberto durante l’incontro. Grasselli «dice che Elenita sta bene e che si trova vicino La Plata», lesse la sorella Estelita davanti ai giudici. «Dopo di che il vicario militare consigliò di interrompere le ricerche e di tornare alcuni giorni dopo. Forse avrebbe potuto aiutarli ad avere ulteriori notizie».
Ma quello di Grasselli era solo un modo per liberarsi in fretta di due persone disperate. Figura ambigua, il prelato per anni era stato fedele segretario di quel cardinale Antonio Caggiano che nel 1961 aveva firmato la prefazione di un libro di Jean Ousset, leader del gruppo della Cité catholique e teorizzatore della violenza cristiana contro i pericoli del marxismo leninismo.
Secondo molte testimonianze, compresa quella di Estelita de la Cuadra, monsignor Grasselli aveva creato un ufficio nella cappella Stella Maris a Buenos Aires in cui riceveva i familiari dei desaparecidos. Accanto ai nomi dei morti aveva segnato delle croci, e molto probabilmente Elena era ancora viva quando il vicario parlò con Roberto e Alicia; ma da lui non seppero più nulla. Grasselli si adoperò anche per far fuggire all’estero molti ricercati e loro parenti; ma il fatto che procurasse dei biglietti aerei intestati al conto corrente della marina militare, unito alle informazioni sulla sorte dei desaparecidos, faceva pensare a un suo stretto legame con i loro assassini e torturatori. Un doppio registro molto diffuso tra le autorità ecclesiastiche argentine. E non era un caso che la Stella Maris fosse attigua al quartier generale della marina; proprio dove peraltro si trovava l’ufficio dell’ammiraglio Emilio Massera, uno dei capi della giunta. «Monsignor Grasselli», chiosa Estelita, «era uno che si divertiva a dare false piste ai familiari, pronunciando frasi del tipo: ‘Signora, corra a casa ché suo figlio è là che l’aspetta’. Cosa che poi non era vera».
Il 28 ottobre 1977, mentre Alicia Zubasnabar de la Cuadra sfilava con le prime madri di desaparecidos in Plaza de Mayo a Buenos Aires davanti alla Casa Rosada, sede del palazzo presidenziale, suo marito fu ricevuto da padre Jorge Mario Bergoglio, all’epoca provinciale dei gesuiti argentini. Poco tempo prima avevano ricevuto da Luis Velasco, un sopravvissuto del V Commissariato di La Plata (fratello del ct della nazionale italiana di pallavolo pluricampione del mondo, Julio Velasco), la conferma che il 16 giugno Elena aveva partorito una bimba: Ana Libertad.
«Ana era il nome che avevano scelto Elena ed Héctor in ricordo di Ana Villareal de Santucho, una militante fucilata durante il massacro di Trelew nel 1972» mi racconta Hilario Bourg, figlio di Soledad de la Cuadra e Carlos Horacio Bourg, il fratello di Juan Raúl, «poi durante la prigionia decisero per Ana Libertad. Il futuro papa» prosegue il cugino di Ana che quando arrivò a Milano con i genitori nel 1977 aveva 3 anni «ascoltò la storia che Roberto gli voleva raccontare, sollecitato dal superiore generale della Compagnia di Gesù, padre Pedro Arrupe. In poche righe Bergoglio liquidò la questione affidandola al vescovo ausiliario di La Plata, Mario Picchi». «L’ho incontrato su speciale richiesta di padre Arrupe», scrisse il gesuita a Picchi. «Le spiegherà di che cosa si tratta e gradirei che facesse tutto quanto le è possibile», concluse. Per monsignor Picchi fu alquanto semplice avere notizie che in quel momento migliaia di genitori disperati cercavano senza fortuna.
L’informazione decisiva gli arrivò dal colonnello Reynaldo Tabernero, vice del capo della polizia di Buenos Aires, Ramón Camps. Tabernero, morto prima di arrivare a processo, confermò a Picchi la nascita della bambina e che Ana Libertad era stata data a una coppia che non poteva avere figli. Riguardo a Roberto José, Elena ed Héctor si limitò a dire laconicamente che «non sarebbero tornati indietro».
Roberto José de la Cuadra era nato l’8 giugno 1952. Quarto di cinque fratelli, aveva studiato alla Albert Thomas Industrial School e poi lavorato con il padre in una piccola impresa. Qui fu segnalato per aver protestato contro l’aumento dell’orario di lavoro e per le cattive condizioni lavorative. Tanto bastò per essere sequestrato: scomparve il 2 settembre 1976, a 24 anni, e non è mai più stato ritrovato. Sua sorella Elena aveva 20 anni e faceva l’assistente sociale. Il suo compagno, Héctor Carlos Baratti, era un operaio tessile di 25 anni alla Ducilo de Berazategui, una delle più antiche fabbriche del paese. Di Elena non si è mai saputo più nulla: è una delle circa 30.000 persone attualmente scomparse vittime della repressione in Argentina.
Nel dicembre del 2009, il Centro di antropologia forense argentina ha identificato il corpo di Héctor: giaceva sepolto come N.N. in una fossa comune del cimitero Lavalle a La Plata scoperta oltre dieci anni prima. Secondo i medici legali il padre di Ana Libertad era stato gettato in mare da un volo della morte; la data dell’omicidio è ignota. L’ultima sua notizia in vita è stata fornita nel 1979 da Cecilia Vázquez de Lutzky; la donna, rapita il 19 luglio 1978 e tornata in libertà il 17 maggio 1979, in una dichiarazione ad Amnesty International affermò di aver condiviso la prigionia con Baratti nell’ottobre del 1978 all’VIII Comando di polizia provinciale a La Plata. Successivamente questa testimonianza è stata confermata da un altro ex desaparecido, Juan Frega, durante il primo storico ‘processo alle giunte militari’ del 1985.
Quanto a Bergoglio, una volta incaricato il vescovo ausiliario si disinteressò per sempre della sorte dei tre desaparecidos: madre, padre e figlia. È lui stesso ad ammetterlo sotto giuramento nel 2011, quando testimoniò a Buenos Aires al processo sul Piano sistematico di appropriazione dei bambini. È di nuovo Estelita de la Cuadra a raccontare: «Gli avvocati delle Nonne di Plaza de Mayo e il procuratore federale Martin Niklison ne fecero richiesta e il giudice María del Carmen Roqueta, presidente del tribunale, dovette trasmettere una richiesta scritta, privilegio di dignitari ecclesiastici, che il cardinale Bergoglio decise di accogliere». Costui giurò di dire la verità «su Dio e il Santo Vangelo» e ricordò che padre Arrupe gli raccomandava di ascoltare quelli che chiedevano aiuto «nella ricerca dei loro cari». Ma la sua memoria a un certo punto si inceppò: «Non ricordo i dettagli del colloquio» con de la Cuadra; «non ricordo che mi abbia detto che sua figlia era incinta»; «non ricordo di aver avuto conoscenza di incontri che lo stesso avrebbe avuto con monsignor Picchi» affermò sotto giuramento.
Dopo di che Bergoglio disse di non aver segnalato la denuncia ad alcuna autorità e ammise di non aver fatto nulla per aiutare la famiglia de la Cuadra. Infine, come aveva già fatto l’8 novembre 2010 nella deposizione giurata durante il maxi processo Esma (tortura, sequestro e omicidio di migliaia di persone alla Escuela superior de mecánica de la armada), ribadì di aver saputo dell’esistenza delle Nonne – e di conseguenza della loro attività di ricerca dei nipoti rubati – solo durante il processo alle giunte del 1985, non dimenticando di lodarle: «Hanno fatto e continuano a fare un lavoro immane».
Secondo Estelita, Bergoglio ha mentito: «La questione della gravidanza di Elena era nota sia a lui che a padre Arrupe. Lo stesso mese di giugno in cui nacque Ana, mia sorella Soledad andò in esilio con il marito in Italia. Qui viveva già un altro di noi cinque fratelli, Luis Eduardo. Papà le disse di provare a contattare don Pedro Arrupe che era la più alta autorità dei gesuiti di tutto il mondo. Arrupe aveva con i de la Cuadra un rapporto di lunga data. I miei fratelli chiesero immediatamente un colloquio e dopo un paio di giorni partirono per Roma. Il potente gesuita viene così a sapere del rapimento di Roberto e di Elena e che lei era incinta. Quindi accetta di parlare con il capo dei gesuiti in Argentina, che altri non era che Jorge Mario Bergoglio, per informarlo della situazione e tentare di aiutarli. Arriviamo così all’ottobre del 1977, quando mio padre viene finalmente ricevuto da Bergoglio a San Miguel, dove si trova il quartier generale dei gesuiti. Al termine dell’incontro Bergoglio dette a mio padre la lettera per monsignor Mario Picchi, il quale tra l’altro era il vice di monsignor Plaza, il confessore di Ramón Camps, capo della repressione a La Plata. Con la lettera del gesuita in mano, papà incontrò Picchi il quale disse: ‘Va bene, vedrò Tabernero’».
Due mesi dopo un agente dell’intelligence, Enrique Rospide, confermò a Picchi quanto già detto da Tabernero: dopo aver ribadito che la nipote dei de la Cuadra era stata data a una «buona famiglia», gli disse che dovevano smettere di cercare i familiari scomparsi. La versione di Estelita trova riscontro in numerose interviste rilasciate negli anni da María Isabel Chorobik de Mariani detta Chicha, una delle fondatrici – il 21 novembre 1977 – delle Nonne di Plaza de Mayo insieme a Licha de la Cuadra e altre dieci madri di desaparecidos. Chicha Mariani ha spesso ricordato che i de la Cuadra si rivolsero ai gesuiti di La Plata perché nel passato la famiglia aveva fatto all’ordine importanti donazioni. Peraltro, lo stesso giorno in cui Roberto portò la lettera di Bergoglio a Picchi, Chicha si trovava nella sede dell’episcopato per un appuntamento con lo stesso monsignore.
Era lì per chiedere notizie di Clara Anahí, la sua nipote rapita a tre mesi di vita il 24 novembre 1976. Ecco come andò: quel giorno una imponente operazione militare con carri armati, lanciagranate ed elicotteri distrusse una piccola stamperia clandestina a La Plata in cui la guerriglia peronista pubblicava il ciclostile “Evita Montonera”.
Durante l’assalto morirono tutti e cinque gli occupanti. Tra questi c’era Diana Teruggi, nata a La Plata il 3 dicembre 1950, nuora di Chicha e figlia di Mario Teruggi, di origine piemontese, e di Kewpie Dawson, cittadina Usa. Alcuni testimoni li informarono che un uomo in uniforme prese con sé Clara Anahí, uscita non si sa come illesa dall’attacco, e da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Alcuni mesi dopo fu ucciso anche il compagno di Diana, Daniel Mariani, figlio di Chicha. Oggi lei ha 93 anni e continua a cercare la nipote: «Non ho il diritto di morire finché non l’ho ritrovata ». Nel 1989 si è separata dalle Nonne e ha creato una Fondazione la cui attività e il cui gigantesco archivio sono stati determinanti nella ricerca di tanti altri bambini rubati e nei processi contro i loro rapitori. Di quel giorno all’episcopato ricorda: «Roberto de la Cuadra mi parlò pieno di speranza della lettera che portava con sé e della ricerca della piccola nipote».
*-*
L’immagine dell’articolo è tratta dalla mostra Ausencias di Gustavo Germano – Qui altre immagini: link alla mostra
Il 24 marzo 2021 alle ore 12 Ausencias sarà inaugurata in diretta Youtube Italia/Argentina Un evento organizzato dall’ambasciata della Repubblica Argentina in collaborazione con l’associazione 24Marzo onlus e Chiesa valdese