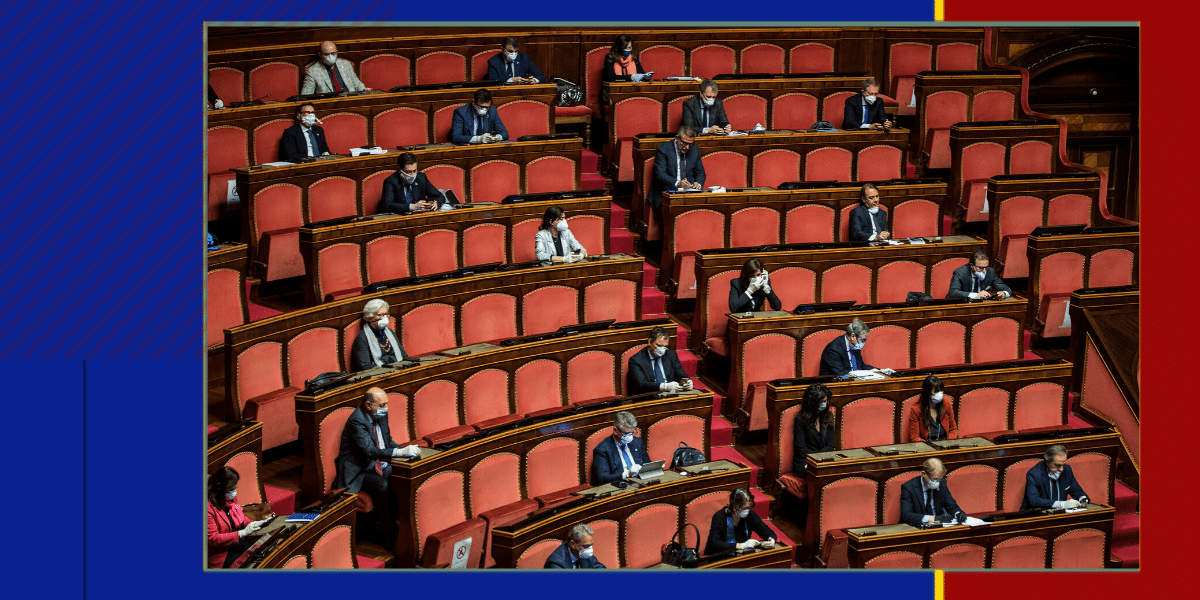Aggrappati ad un grafico, alla linea che segna il picco, alla curva. La nostra vita quotidiana legata ad un grafico.
Questa volta si tratta del grafico dei contagiati da coronavirus, dei deceduti.
Stavolta non si tratta del grafico del PIL, della curva dell’andamento della Borsa, dei Titoli, che si vogliono sempre in crescita, sempre in alto, alla ricerca di un costante picco. Ci si accorge ora che ci sono cose più importanti, basilari: la vita.
Ci accorgiamo ora come l’andamento il grafico dei contagiati non è demandato alle sole Autorità, al Governo, ai medici, agli infermieri, ma dipende anche da noi, anzi, principalmente da noi, dai nostri comportamenti, dalle nostre scelte. Ci accorgiamo che i nostri comportamenti hanno riflesso sulla collettività, sull’umanità intera, sul suo modo di vivere.
Viceversa si pensa che gli altri grafici dipendano solo dagli agenti di Borsa, dai colossi industriali e finanziari, e non anche dalle nostre scelte.
Invece anche in quel caso siamo noi che in qualche misura ne determiniamo l’andamento e l’importanza, scegliendo di vivere in questo mondo, accettando questo sistema, questo modello di sviluppo e di società basato sullo sfruttamento continuo dell’uomo sull’uomo e dell’uomo sulla natura.
Continuiamo a pensare che le nostre scelte non influiscano. Eppure, come per il grafico dei contagiati, anche per il grafico del PIL dovremmo imparare che noi abbiamo una parte importante nel gioco.
Perché questi grafici indicano l’andamento della ricchezza prodotta (non completamente, ma per semplificare), ma niente dicono sulla distribuzione di tale ricchezza.
Perché se è direttamente vero che una curva declinante dei contagi, significa direttamente che tutti ci avviciniamo a tirare un sospiro di sollievo, che tutti ne beneficeremo, una curva sempre in salita del PIL non ci dice affatto che stiamo meglio, che siamo più ricchi, ma solo che è aumentata la ricchezza prodotta, che però rimane sempre più nelle mani di pochi.

Quello che paradossalmente c’è in abbondanza è il danaro. La ricchezza che il pianeta produce non è mai stata così alta. Questa ricchezza però non è a disposizione dell’umanità, dell’uomo che la produce, ma concentrata in poche mani: 26 persone, solo 26 persone, posseggono la ricchezza pari a quella di 3.8 miliardi di esseri umani. 26 persone eguagliano la metà del pianeta.
Siamo al paradosso, apparente, di un pianeta che produce ricchezze enormi, le più grandi mai viste, e al contempo che soffre per mancanza di acqua, salute, cibo, lavoro, in cui sono sempre maggiori le diseguaglianze, l’assenza di tutele, lo sfruttamento.
Diciamo ora, nell’emergenza drammatica dettata dal virus, che nulla sarà come prima, che avremo imparato la lezione. Ma non è così, non è affatto scontato che sia così. E non solo in ambito nazionale.
Vediamo, anche in questa emergenza, come i paesi ricchi europei (di una comunità cioè di cui facciamo parte a pieno titolo) continuano ad anteporre i propri egoistici interessi al bene collettivo, a rifiutare politiche e azioni comuni che non siano penalizzanti per i Paesi in difficoltà. È lo stesso che si fece con la Grecia: anziché aiutare un membro della famiglia europea, si posero condizioni capestro. Ora si vuole continuare. Ci si accorge ora, in certi ambienti a suo tempo ignavi, di quanto fu sbagliato accettare a suo tempo quelle scelte, che provocarono ulteriore povertà alla Grecia. Ci si accorge che la connivenza o, nel migliore dei casi, il silenzio, era ugualmente colpevole. Prima o poi siamo tutti Grecia. Ma se una comunità non è solidale, come può definirsi comunità?
Allora, nel dopo crisi, pensiamoci, perché ora siamo tutti in preda all’ansia da chiusura forzata, soffrendo davanti a televisori, con i cellulari in mano, con la play station, con il lavoro agile, lo smart working, con le lezioni telematiche, e chiediamo aiuto. Ma ricordiamolo però come abbiamo aiutato quei paesi che continuano a non avere la play station, o lo smart working, anzi che non hanno proprio gli ospedali: sempre imponendo condizioni di ricatto o sottomissione, le stesse che oggi per noi rifiutiamo.
Perché allora ci commuoviamo per le donazioni generosamente elargite (doverosamente direi) da questo o quel colosso, beandoci di queste forme di elemosina, di altruismo caritatevole, quando è, nel migliore dei casi, solo una parziale restituzione (appunto solitaria, volontaria, compassionevole) della ricchezza così mal distribuita e nella norma sottratta alla comunità.
Appare invece sempre più necessario e vitale che chi detiene queste enormi ricchezze partecipi organicamente al bene collettivo, e non questi sia lasciato alla benevolenza di “singole sensibilità”.
Bisognerà quindi, già ora e nel dopo crisi più fortemente, porre con maggior insistenza il tema dell’introduzione di una patrimoniale sui grandi capitali e di una riforma fiscale con caratteri più marcatamente progressivi (altro che flat tax). Idee non nuove ma sempre spacciate dai detrattori come dettate da invidia sociale di vetero-comunisti.
Intendiamoci, non si tratta di volontà “punitiva”, ma la sottolineatura della necessità di una distribuzione più equa delle risorse, in termini di denaro, di occupazione, di condizioni di lavoro, e di restituzione di spazi di vita, quelli che oggi ci accorgiamo siano fondamentali nel vivere quotidiano, nell’esistenza dell’uomo.
Da più parti, ad esempio, si grida alle scarse risorse messe in campo per affrontare la crisi economica e sociale dovute al virus. E certamente bisognerà fare di più e di meglio (pur considerando che l’Italia sta affrontando per prima al mondo, senza alcuna esperienza pregressa, una crisi imprevista, e che fa la parte da un lato di cavia e dell’altro di apripista, dovendosi inventare, da sola, strumenti e misure, non avendo alcun modello di riferimento, ma dovendolo in qualche modo inventarselo).
Ma la distribuzione diseguale della ricchezza (e con essa l’evasione e l’elusione fiscale), non è la causa prima della scarsità di risorse per gli Stati? Tassare chi ha di più per tassare chi ha di meno, non sarebbe una conseguenza logica?
E allora, sarà importante capire, quando si ripartirà, come si vorrà affrontare l’inevitabile crisi economica, con quali visioni, quali progetti? Mungendo i soliti noti o finalmente prendendo il denaro dove c’è? Come si finanzierà la Sanità Pubblica, che ora si scopre Cenerentola? E l’Istruzione, e i servizi, ecc? Mettere mano, quindi, alla fiscalità, introdurre una Patrimoniale, e farlo immaginando un nuovo e diverso modello di sviluppo, da centrare non più sullo sfruttamento dell’uomo e della terra.
Ecco quindi che non basta guardare ai grafici, ma in qualche modo si deve provare a cambiarli e soprattutto ad inventarne di nuovi.
Fittante Lionello
Cofondatore associazione politico-culturale #perimolti.
Aderente Movimento Politico èViva