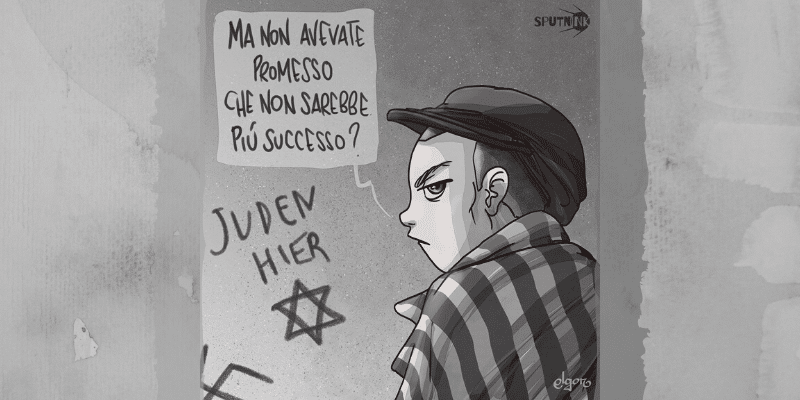Non bisogna più aspettare, non c’è più tempo. Bisogna reagire a questi sonniferi che ci propinano in continuazione. E le possibilità, grazie alla nostra storia, ci sono. La mia è cominciata molti anni fa, nella Resistenza al nazifascismo. Mi sono anche opposta a Palmiro Togliatti. La sua responsabilità nella sconfitta della sinistra è stata non solo grandissima ma anche consapevole. Cioè lui sapeva che bisognava fermare qualcosa, e che solo fermando quel qualcosa, che poi era il pensiero e l’operato di Gramsci, c’era la possibilità di portare avanti “riforme”, al fondo, reazionarie, anti umane, che andavano contro le prospettive per il futuro. Faceva parte della sua politica cercare di controllare il pensiero degli altri. Era una cosa tremenda perché era difficile da combattere, molto difficile.
Quell’impostazione togliattiana in qualche modo ha reso possibile l’arrivo del renzismo. Gli ha aperto la porta, o meglio, è stato fatto un lavoro di sterramento per appianare la strada. Il risultato è che in questi anni ci siamo trovati un Matteo Renzi presidente del Consiglio e ad avere a che fare con il suo modo di fare politica.
Togliatti, ripeto, è stato deleterio per la sinistra perché non aiutava a pensare, a formarsi un pensiero critico autonomo. Non solo, addirittura chi lo faceva, passava per anti democratico. Ma se si blocca il pensiero, la possibilità di approfondire e di criticare, si impedisce qualsiasi forma di opposizione non solo concretamente ma soprattutto mentale. Questo allora era il problema vero. Oggi potrebbe sembrare un fenomeno di poca importanza invece così si fermava la ricerca e la speranza.
Quell’impostazione ti portava a pensare che a di là dell’esistente non si potesse andare, provocando un atteggiamento di rassegnazione. Insomma, era come se dicesse “State tranquilli, c’è chi pensa a voi, voi fatevi il più possibile gli affari vostri e lasciateci il campo libero”. Esattamente il contrario di quanto sosteneva Gramsci. La stessa dimensione di rassegnazione si ritrova oggi, quando si sente dire “speriamo che passi questa legge, speriamo che arrivi Renzi…”.
Se la storia della sinistra è andata così è anche perché c’è stata l’alleanza con la religione cattolica. È stata una cosa brutta e diseducativa, le conseguenze si vedono anche oggi, con questo papa che viene visto come uno che fa le lotte, un papa bravo. Ma non esistono papi bravi. Il papa è papa. Con Togliatti quindi è stata sancita anche la vittoria della religione senza che ce ne rendessimo conto. Allora come oggi pensare che la Chiesa possa essere alleata in una battaglia per l’emancipazione umana era il colmo, eppure la gente ci ha creduto.
Non capisco come Enrico Berlinguer che aveva una famiglia cattolica alle spalle, non ci pensasse: è una contraddizione in termini. Come faceva a non preoccuparsi? La religione riguarda il pensiero e il modo di affrontare i problemi della società. Ripeto, questa alleanza, blocca qualsiasi pensiero oltre a togliere qualsiasi consapevolezza, per cui uno che tenta di opporsi arriva a pensare di essere lui a sbagliare.
Ma oggi come uscirne? È questo il problema. Per noi che abbiamo vissuto la storia e la ricerca dell’Analisi collettiva e della teoria di Massimo Fagioli il giudizio su quello che è stato è chiaro. Ma non basta.
Il pericolo adesso è costituito da quelli che io chiamo falsi democratici, che agli occhi di molti non appaiono come tali. Il messaggio che passa è che non c’è da lottare per il cambiamento, c’è da fare un’operazione per acquietare le cose, per non creare sconquassi, perché in fondo, pensano, si può sopravvivere abbastanza bene! Questo atteggiamento ha fatto comodo a molti perché altrimenti si sarebbe trattato di riconoscere non solo gli sbagli ma le rinunce che sono state fatte. Renzi, insomma, ha fatto comodo a molti. E ci si abitua a tutto, alla notizia della fabbrica che chiude, alle trattative in corso, tanto la vita continua… Ma che facciamo, aspettiamo Godot?
Noi della sinistra, intendo noi che abbiamo una storia alle spalle e abbiamo realizzato dei cambiamenti epocali pensiamo che l’uomo e la donna abbiano la possibilità di cambiare. Cosa possiamo fare? Coinvolgere i giovani insieme anche a noi anziani. La nostra storia ha bisogno di iniezioni non solo di energia ma di coraggio, di fiducia, di certezza. E quindi di forza. Ci vuole un pensiero nuovo, ma non è un fatto miracoloso. È qualcosa che non nominiamo e poi domani, forse, accade. Bisogna avere i piedi per terra e pensare ai cambiamenti che vogliamo e che si possono e si devono fare.
La sinistra deve ricominciare a interessarsi ad alcune questioni fondamentali. La prima è la scuola. È un terreno pronto, ideale, e lo posso dire dopo tanti anni di lavoro. Certo, per il cambiamento le lotte devono essere fatte in tutte le sedi, ma la scuola è fondamentale. Perché quelli che una persona passa tra i banchi sono anni cruciali. Non solo. È come se la scuola adesso aspettasse idee. Se non rispondiamo ci prendiamo una grande responsabilità perché i giovani sono quelli che ci rimetterebbero di più.
Dobbiamo pensare alle nuove generazioni e a che cosa gli possiamo lasciare. Per farlo dobbiamo partire dalla realtà e dalle sue contraddizioni per poi trovare le soluzioni. Cercheranno di dirci che tutto è difficile, perché si tratta di cose complesse, ma quante cose complesse abbiamo visto nella storia dell’umanità e nelle storie individuali? Le abbiamo affrontate sempre, basta che ci sia una consapevolezza di operare umanamente e concretamente, rifiutando ciò che è disumano, è la paura che blocca.
Centrale è anche la questione delle donne, sembriamo emancipate, ma non è vero del tutto. Certo, molte cose sono cambiate, ma il rapporto tra l’uomo e la donna ancora oggi è un rapporto monco, chi ci rimette e rimane emarginata è sempre lei. Qui non si tratta di ripetere le battaglie femministe. Si tratta di lasciare agli esseri umani la possibilità di vivere in quanto uomo o donna, ognuno con la propria identità, qualsiasi sia il lavoro che fanno. Bisogna fare uno sforzo per trovare la strada e i sistemi per modificare la società con pieno rispetto della realtà umana.
Ora non si tratta più di fare battaglie epocali specialmente per noi donne, ma di acquistare una propria identità, imparando a saper fare dei rifiuti. A vedere bene, infine, questo è un momento molto bello perché c’è tutto da costruire e le possibilità ci sono. Oggi, c’è già una realtà in cui ci sono tanti segnali, tanti fermenti, fatti sociali che sono avvenuti. Dobbiamo solo muoverci subito ognuno per sé stesso e collettivamente.
da Left n. 22 del 3 giugno 2017








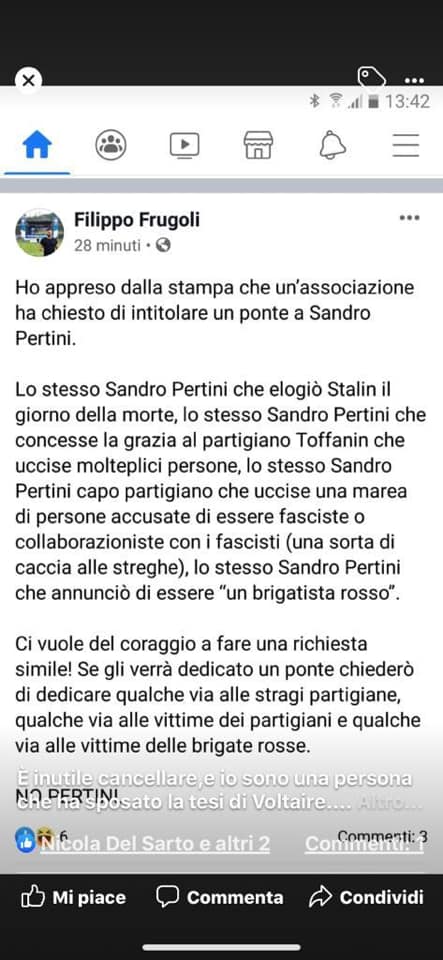 A quel tempo invece, non era ancora nato il
A quel tempo invece, non era ancora nato il