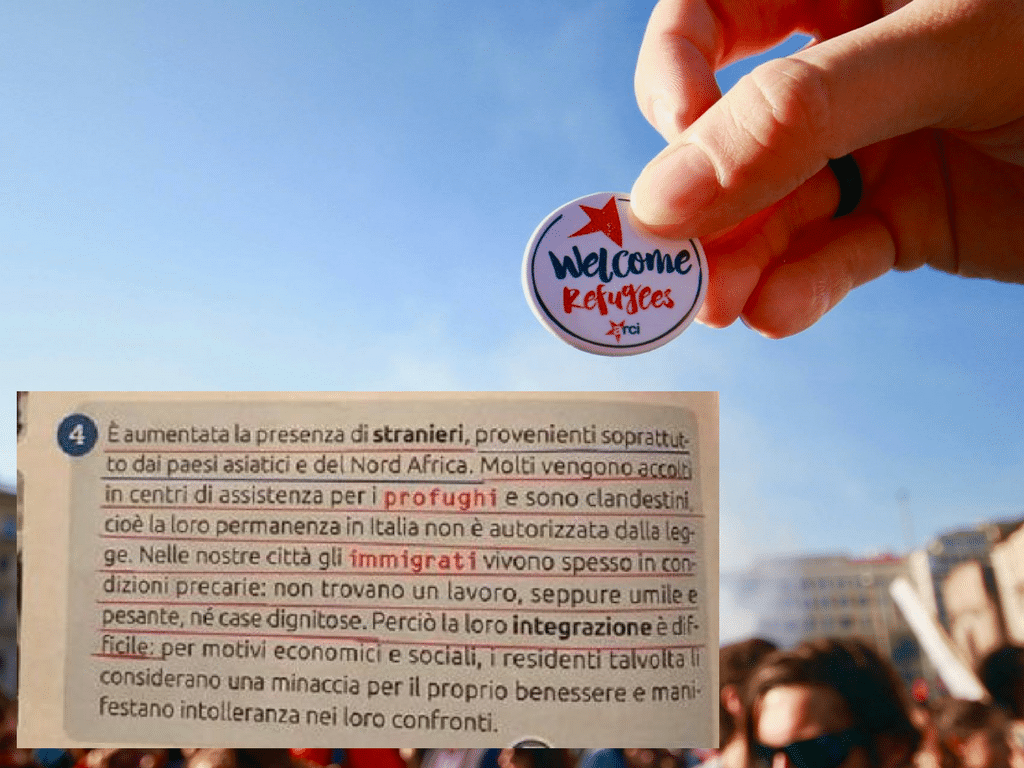Antropologa impegnata e sempre disponibile ad intervenire nel dibattito pubblico, contro il razzismo e per una società più giusta e democratica, Amalia Signorelli è stata allieva diretta di Ernesto de Martino. La ricordiamo riproponendo l’intervista di Left in cui parlava del suo grande maestro
È una appassionata ricognizione critica del pensiero De Martino, che ne restituisce tutta la viva attualità, il saggio di Amalia Signorelli pubblicato dall’Asino d’oro edizioni con il titolo “Ernesto de Martino, teoria antropologica e metodologia della ricerca“. Un libro affascinante anche per il modo in cui la riflessione teorica si intreccia con memorie giovanili della studiosa che, giovanissima, partecipò alla spedizione nel Salento alla ricerca del tarantismo pugliese. Pagina dopo pagina, fra vita vissuta, ricerca sul campo e approfondimento metodologico.
Riemerge così l’immagine di Ernesto de Martino (1908-1965) solitario ed esigente professore all’Università di Roma, accanto a quella della studentessa di buona famiglia che, lasciata da parte ogni pruderie borghese, appena laureata, prese parte alla spedizione in Salento andando alla ricerca di quel tarantismo pugliese da cui sarebbe nato un classico dell’etnografia come “La terra del rimorso“. Lo choc dell’incontro con realtà e culture molto diverse dalla propria, il coraggio di mettere in discussione se stessi nel rapporto con l’altro e di superare pregiudizi che non si sospettava nemmeno di avere. Tutto questo faceva parte di un modo di pensare che lasciò un segno profondo in Amalia Signorelli che poi applicò questo metodo ad ambiti di studio differenti, dalle migrazioni, alla condizione femminile alle culture urbane. Riconoscendo che l’incontro con quell’appartato docente era stato uno dei più fertili per la sua formazione.
Professoressa Signorelli in che modo la Weltanschauung di De Martino ha influenzato il suo lavoro di ricerca?
Almeno con tre concetti fondamentali. Il primo è metodologico, è l’etnocentrismo critico, cioè l’idea rivoluzionaria ancora oggi, che l’antropologo non deve usare la propria cultura come metro per misurare quella altrui, ma viceversa usare quella altrui per misurare la propria. Il secondo è piuttosto un postulato: l’origine e la destinazione integralmente umana dei beni culturali, di tutti i beni culturali, dalla ricetta degli spaghetti alla carbonara alla fisica dei quanti. Infine, il terzo è un concetto-obbiettivo: la produzione di un nuovo umanesimo, che Ernesto de Martino chiama «umanesimo etnologico». Agli antipodi di ogni etnicismo o esotismo di moda, l’umanesimo etnologico vuol essere una concezione e una pratica del mondo in cui l’altro da noi è vissuto come un’opportunità per diventare tutti più umani, non come una minaccia alla nostra fragile identità.
Nell’introduzione alla nuova edizione de La terra de rimorso edita da Il Saggiatore, Clara Gallini dice di aver appreso da Amalia Signorelli la ricerca sul campo, riguardo al tarantismo. Quanto è stata importante quella esperienza?
Oggi, a distanza di tanti anni, posso dire che mi ha cambiato la vita. L’influenza di Ernesto de Martino ha dato nome e orizzonte storico a un allora confuso coacervo di ideali, convinzioni, aspirazioni che avevo in testa. Gli debbo la scoperta, all’epoca della mia tesi di laurea, dello sfruttamento degli esseri umani da parte di altri esseri umani e il mio diventare di conseguenza, come ora si usa dire, di sinistra. Collocazione sempre più difficile, oggi: ma so per certo che dopo aver vissuto tra le contadine e i contadini meridionali negli anni Cinquanta del secolo scorso, non potrò accettare mai dominio, sfruttamento e alienazione come fatti ovvi o quanto meno inevitabili.
Concetti come egemonia e subalternità divennero allora ben concreti?
La ricerca sul tarantismo mi fece conoscere esseri umani che si pensano nei termini imposti da coloro che li dominano ed esseri umani che si pensano invece in rapporto ai propri interessi e desideri. Me lo fece capire Concettina, la sorella della famosa Maria di Nardò, tarantata per eccellenza, quando mi chiese «la medicina per non comprare bambini», cioè la pillola anticoncezionale. E, guarda caso, Concettina non pativa del morso dell’orrido ragno, non aveva un passato irrisolto che non passa. Voleva un futuro in cui l’eros non le fosse precluso dalla paura delle gravidanze a ripetizione.
L’etnocentrismo critico di De Martino oggi aiuta a comprendere l’immigrazione fuori dai luoghi comuni razzisti?
Ritengo di sì. De Martino non suggerisce mai che si debba rinunciare alla propria cultura per comprendere empaticamente quella altrui. Molte persone di buona volontà “si sforzano” di compiere questa azione, in genere con poco successo. L’etnocentrismo critico è, come dicevo, una postura intellettuale prima ancora che morale: un confronto sistematico in cui si capovolgono continuamente i termini: non sei tu che sei diverso da me, sono io che sono diverso da te; non sei tu che mandi un cattivo odore, sono io che per te mando cattivo odore e dunque anche tu lo mandi per me ma non per tutti gli esseri umani. Non è facile, ci vuole una specie di allenamento intellettuale, anche quotidiano.
L’etnocentrismo critico è stato accusato di favorire il relativismo. C’è questo rischio?
Al contrario, non si tratta di pensare che tutto vale tutto, che non c’è meglio e peggio: se trovo nella tua cultura qualcosa che mi piace più dell’equivalente previsto dalla mia, lo posso adottare, anzi posso chiederti se lo posso adottare. E’ questo il solo possibile processo di integrazione culturale a basso tasso conflittuale. La vera difficoltà non è il relativismo, ma la mancanza, da tutte le parti, di capacità di riflessione critica.
De Martino si era interessato ad Heidegger ma poi ne prese le distanze criticandolo. Certo nihilismo postmoderno non gli sarebbe piaciuto?
Penso proprio che Ernesto de Martino fosse lontanissimo da qualsiasi forma di nihilismo. Ma anche da qualsiasi rinuncia o abdicazione sul piano intellettuale. Gli oggetti della ricerca demartiniana, il mondo magico e i poteri magici, il lutto, la trance e la possessione, il malocchio sono tutti al di fuori del perimetro della razionalità, ma lui li studiava (e ci insegnava a studiarli) utilizzando gli strumenti della razionalità. Con una differenza sostanziale rispetto alle razionalissime (e sterili) condanne delle superstizioni, ma anche rispetto al decostruzionismo esasperato che consente la pratica solo dell’empatia o dell’antipatia: per Ernesto de Martino anche ciò che non è razionale è nella storia, è storico, cioè è un bene culturale di origine e destinazione integralmente umana. Dunque un filo rosso, per quanto sottile, che colleghi i singoli accadimenti della storia umana, sarà possibile rintracciarlo, poiché sono tutti accadimenti umani. Ma ove non si riuscisse a rintracciare questo filo rosso, bisognerà costruirlo e costruirlo credibile: non perché abbiamo bisogno di belle favole consolatorie, ma perché solo noi , noi esseri umani, costruiamo il senso del nostro esistere nel mondo.
«Si dice che per fare il bene occorre credere in Dio ma siamo giunti ad un punto che lo faremo ugualmente il bene senza farlo per Dio ma per gli uomini oppure sarà sempre troppo tardi per tornare al vecchio Dio» scriveva De Martino. Serve un’etica laica?
Sono convinta di sì. Per Ernesto de Martino l’ethos veramente umano è l’ethos del trascendimento cioè il dovere di andare oltre, trascendere ogni situazione data, e di trascenderla orientati da valori. È una concezione dell’etica che non pretende risultati per l’eternità. Richiama semplicemente ogni individuo alla sua responsabilità per tutto ciò che accade ma anche alla soddisfazione non di ‘fare del bene’, ma di fare bene; onestamente, secondo la propria concezione di bene. E infine, ma forse soprattutto, richiama al dovere di non rassegnarsi, di non rinunciare, appunto al diritto e al dovere di andare oltre.