Il “non mollare” al femminile è ben rappresentato dal personaggio di Ada Rossi, una donna moderna (benché nata nel 1899), laica e con una fisionomia politica tenace e resistente. Nella biografia di cui Antonella Braga e Rodolfo Vittori sono autori per la collana di genere “Novecentodonne” dell’editore Unicopli di Milano, diretta da Luisa Steiner, la figura forte e autonoma di questa donna emerge con tutta la sua vitalità. Left li ha intervistati.
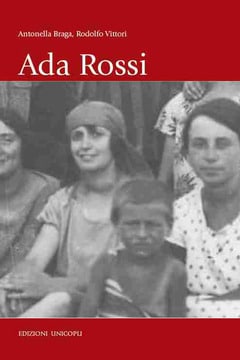 Com’è nata l’idea di scrivere il libro Ada Rossi e quale era il suo profilo?
Com’è nata l’idea di scrivere il libro Ada Rossi e quale era il suo profilo?
Entrambi siamo studiosi di Ernesto Rossi e abbiamo conosciuto Ada (che già da nubile si chiamava Rossi, scherzi del nome!) attraverso le sue lettere al marito. Con un atto di coraggiosa solidarietà, Ada aveva scelto di sposarlo in carcere nel 1931, dopo che Ernesto era già stato condannato a vent’anni per la sua opposizione al regime fascista nelle file di Giustizia e Libertà. Dopo il matrimonio, fu allontanata dalla scuola pubblica, in cui insegnava matematica; dovette mantenersi con lezioni private sino a 42 ore settimanali per mantenere se stessa e il marito in carcere; fu schedata e strettamente controllata dalla polizia e, infine, inviata al confino nel 1942, prima a Forino, in provincia di Avellino, e poi a Melfi e Maratea.
Dalle sue lettere e dalle testimonianze emerge il profilo di una donna indipendente, controcorrente, capace di scelte difficili, sostenute con una coerenza morale mai venuta meno. Fu un soggetto attivo che non visse di luce riflessa ed ebbe un ruolo tutt’altro che marginale, svolgendo importanti compiti di propaganda, collegamento e formazione politica dei giovani anche in assenza di Ernesto. Mentre dava lezioni private di matematica a Bergamo negli anni Trenta, dava anche lezioni di antifascismo a giovani poi divenuti protagonisti della Resistenza bergamasca. Ci è dunque sembrato che la sua figura di militante e di educatrice meritasse di essere studiata per se stessa, non solo come “consorte” del più noto marito.
Come scrivete nel libro, nelle vene di Ada scorreva il sangue di mezz’Europa. Quali erano le sue origini e quale fu la sua formazione?
Sentimentalmente legata alla sua terra d’origine (l’Emilia), Ada appartenne da subito a una patria più grande. Il bisnonno paterno era stato un ufficiale polacco giunto con le armate napoleoniche nel Granducato di Parma. Lì si era stabilito con la moglie svizzero-tedesca. Tra gli avi materni, c’era anche una francese, la bella Henriette, forse figlia naturale di un Asburgo. Il nonno paterno aveva partecipato alla Seconda guerra di indipendenza, mentre quello materno era stato un matematico e un socialista rivoluzionario. Il padre, Carlo, benché ufficiale di carriera, nutriva ideali repubblicani e la madre, Concetta Montanari, aveva seguito studi regolari fino a conseguire la maturità classica, titolo ancora poco frequente tra le ragazze. Ada crebbe quindi in un contesto famigliare aperto, in cui circolavano memorie giacobine e risorgimentali, principi repubblicani e socialisti, ideali mazziniani e garibaldini, insieme a posizioni agnostiche e anticlericali. Questi valori ispirarono le sue future scelte di vita e la predisposero alla militanza antifascista nelle file di Giustizia e Libertà, del Movimento Federalista europeo, del Partito d’Azione e, infine, del Partito radicale.
Come si svilupparono le sue scelte di vita?
A determinare il suo destino fu l’esperienza della guerra. Come accade ai giovani nati nel 1899, che furono tra gli ultimi a essere chiamati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, anche la vita di Ada – “ragazza del ’99” – fu segnata dalla guerra, per ben tre volte nel corso della sua vita. Nel 1912 il padre Carlo morì di tifo al suo rientro dalla guerra di Libia. Ada, allora tredicenne, ne soffrì moltissimo. Nel 1917, appena uscita dal collegio col diploma di maestra, vide la sofferenza dei reduci, dei mutilati e dei profughi di Caporetto. Ne fu inorridita e per sempre vaccinata contro la retorica nazionalista e bellicista. Di fronte al nascente fascismo – che di lì a vent’anni avrebbe trascinato l’Italia in nuovo devastante conflitto – compì da subito una decisa scelta di campo. Aborriva i metodi violenti degli squadristi, che nel 1921 avevano ucciso un suo compagno di studi all’università di Pavia, dove Ada si laureò in matematica nel 1924. La sua scelta antifascista fu quindi compiuta prima di incontrare Ernesto Rossi nel 1928 a Bergamo, dove entrambi insegnavano all’Istituto tecnico “Vittorio Emanuele”.
Affetti e lotta politica in Ada Rossi sono due sfere distinte?
Ada Rossi fu una militante politica nel più autentico senso del termine, in quanto fece della contraddizione fra fatti e valori una questione personale, esponendosi in prima persona, a costo di gravi sacrifici e rischi. Quest’impegno totalizzante cancellava le barriere fra vita privata e vita pubblica, coinvolgendo l’ambito degli affetti. Sposando un uomo condannato a vent’anni di galera, Ada sacrificò la sua giovinezza imponendosi un destino di solitudine per lunghi anni a venire. Per stargli vicino, accettò anche di non avere figli. Eppure, come accadde a molte donne della sua generazione, fu un “animale politico” quasi senza saperlo, vivendo la propria militanza come naturale conseguenza di un impulso etico, ineludibile, e come prosecuzione dei compiti di “cura” tradizionalmente assegnati alle donne, senza alcuna pretesa di protagonismo.
Un particolare abbastanza noto nella sua vita ricca di storia è quello del Manifesto di Ventotene. Nel libro raccontate che Ada Rossi nel 1941 temperò le matite con cui Ernesto Rossi ricopiò il Manifesto su carta leggera e con una calligrafia minuscola. Poi con Ursula Hirschmann riuscirono a portarlo fuori dall’isola di confino.
Nel novembre 1939, per effetto di un’amnistia, Rossi fu scarcerato e inviato nell’isola di Ventotene, dove fu confinato sino al luglio 1943. Ada si recava a trovarlo appena il lavoro glielo consentiva, ma il viaggio da Bergamo era lungo e costoso. Durante le sue visite sull’isola, conobbe l’ex comunista Altiero Spinelli e il socialista Eugenio Colorni, con cui Rossi aveva stretto un sodalizio intellettuale da cui scaturì il Manifesto per un’Europa libera e unita, più noto come Manifesto di Ventotene. Conobbe anche le sorelle di Spinelli, Gigliola e Fiorella, e la moglie di Colorni, l’ebrea tedesca Ursula Hirschmann, fuggita dalla Germania per la sua militanza socialista, che risiedeva per lunghi periodi nell’isola con le piccole figlie.
Quando Ernesto le lesse una prima bozza del Manifesto nell’inverno 1940-1941, le piacque molto in quanto vi ritrovò alcuni temi su cui avevano già discusso tra loro nelle lettere degli anni del carcere: l’orrore per la guerra, il volto demoniaco del nazionalismo, la critica al dogma della sovranità assoluta degli Stati nazionali, il progetto per un’Europa federale, insieme ai principi per una riforma della società in senso liberal-socialista. Con Ursula Hirschmann, Ada portò clandestinamente il testo fuori dall’isola e si occupò di farlo battere a macchina a Bergamo. Il Manifestò federalista iniziò così a essere diffuso tra gli antifascisti sul continente.
L’adesione di Ada al progetto federalista non fu mai più messa in discussione in quanto si basava su un radicato convincimento. La federazione europea le sembrava la premessa necessaria per ripristinare in modo duraturo la pace e la democrazia. Partecipò quindi alla nascita del Movimento federalista europeo (Milano,1943), contribuì col marito alla propaganda sul piano internazionale negli anni dell’esilio svizzero (1943-1945) e negli anni dell’avvio del processo di integrazione europea (1947-1954).
Quando nel 1954, dopo il fallimento del trattato della Ced (Comunità europea di difesa), Ernesto perse fiducia nella possibilità di realizzare a breve la federazione europea su basi costituenti, Ada si mostrò meno pessimista sul futuro del processo d’integrazione, che di lì a poco sarebbe ripartito – sebbene in un’ottica funzionalista e non costituente – con i Trattati di Roma del 1957. L’unità europea le sembrava un esito necessario, quasi “naturale” della storia, che prima o poi doveva giungere. Diceva che era nei fatti, bastava solo “volerla” molto e continuare a “non mollare”.
Dopo la morte di Ernesto (1967), avrebbe innestato questa sua fede europeista all’interno del nuovo Partito Radicale, fondato da Marco Pannella, cui aderì ritrovandovi alcune battaglie condivise col marito (laicità, diritti civili e liberalismo radicale venato di istanze sociali).
Nell’analisi storica che avete condotto che idea vi siete fatti rispetto a questa sua particolare capacità di “resistenza” rispetto a tutto ciò che attraversò durante la sua vita?
Fedele al volontarismo di matrice risorgimentale, Ada mantenne per tutta la sua lunga vita (morì nel 1993 a quasi novantaquattro anni) un’incrollabile fede che il mondo potesse essere migliorato dalla volontà e dall’impegno comune delle persone. Nei momenti più difficili, sapeva comunicare serenità, costanza e fiducia, soprattutto ai giovani. Sino agli ultimi anni, non fece mancare le sue critiche ai limiti del processo di integrazione europea inaugurato secondo la logica funzionalista dell’“Europa a pezzettini” e non secondo la prospettiva costituente cara ai federalisti. Spesso amava ripetere che la Repubblica nata dalla Resistenza, pur con tutti i suoi limiti (e il suo carattere clericale da «Repubblichetta del Sacro Cuore», come sentenziava ironicamente Ernesto Rossi), era pur sempre la «nostra Repubblica» e bisognava difenderla per fare in modo che diventasse sempre più democratica. E modestamente concludeva: «Bisogna sempre renderla migliore, lottare per questo, piuttosto che andare a casa a far girare i pollici; almeno io sono di questo parere». Le sue parole semplici, ma lucide e appassionate, e il suo esempio di militante non sono stati dimenticati e hanno lasciato eredità d’affetti in molti di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Merita dunque di essere annoverata fra le madri della nostra Repubblica e della futura Europa unita.






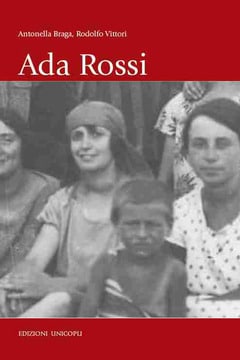 Com’è nata l’idea di scrivere il libro
Com’è nata l’idea di scrivere il libro 






