Solo 2.800 aziende agricole iscritte dal 2015, su un totale di circa 1.600.000 imprese (censite dall’Istat) e almeno 100mila realtà potenzialmente interessate. Sono questi i numeri – impietosi – dell’arma che avrebbe dovuto promuovere l’agricoltura virtuosa e sconfiggere il caporalato. Si chiama “Rete del lavoro agricolo di qualità”: fortemente promossa da governo e sindacati, è nata precisamente due anni fa. Per capire di che si tratta, bisogna ripartire da lì.
La Rete che non c’è
Estate 2015. Paola Clemente, bracciante pugliese, è da poco morta di fatica ad Andria, dove raccoglieva l’uva per 12 ore al giorno, in cambio di una trentina di euro. La vicenda, definita subito come un caso di sfruttamento, turba l’opinione pubblica e fa correre il governo ai ripari. Ecco che la Rete, contenuta nel provvedimento “Campolibero” del 2014, diviene operativa. Con lo scopo dichiarato di stilare una lista di aziende “caporalato free”. Non più solo repressione, dunque, ma un intervento propositivo, per mettere al bando chi sfrutta il lavoro e rimodellare la filiera agroalimentare. Tanto che il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, all’indomani degli arresti del caso Clemente a febbraio 2017, sulle colonne di Repubblica ribadiva che la Rete è uno degli strumenti principali per costruire una filiera di qualità. Peccato che «paradossalmente l’azienda della signora Paola Clemente avrebbe potuto aderire perché formalmente era in regola». La dichiarazione, del segretario nazionale Flai Cgil, Giovanni Mininni, era arrivata molto tempo prima, a pochi giorni dalla partenza della Rete, e denunciava uno dei (tanti) controsensi di questa arma, che nasce spuntata: anche chi non rispetta le regole, se ancora non è stato beccato e certifica di comportarsi bene, può avere il bollino.
Già, perché per iscriversi alla Rete è sufficiente dichiarare di non avere ricevuto multe o condanne in materia di lavoro e fiscale, di essere in regola col versamento dei contributi, e poco più. Certo, ma dopo che la domanda è stata accettata, i controlli – così come accade per qualsiasi certificazione – saranno spietati, si penserà. Tutt’altro. Una volta dentro, le aziende ricevono, per legge, meno attenzioni da ministero del Lavoro e Inps, rispetto alle già rare verifiche di un Ispettorato del lavoro nazionale che è in affanno in molte zone d’Italia, per usare un eufemismo. Il rischio, dunque, è che la Rete diventi un ombrello dietro al quale si riparano aziende sospette. Ma per chi invece non ha nulla da nascondere, quali sarebbero i benefit a cui va incontro?
Alcuni produttori iscritti, contattati da Left, non sanno nemmeno cosa sia questa Rete. Altri confermano che di benefici non vi è nemmeno l’ombra. «Siamo iscritti perché ce l’ha richiesto un nostro fornitore. Ma non abbiamo avuto nessun vantaggio economico», spiega una produttrice di agrumi di Catania. «Ce lo ha chiesto l’Esselunga, dire di no voleva dire rischiare di non lavorare più», chiosa bruscamente un agricoltore fiorentino. Perché è la Grande distribuzione organizzata, a tenere in mano le redini dell’intera filiera.
Durante la trasmissione Radio Anch’io del 22 settembre, un ascoltatore, Dimitri da Belluno, interviene nel dibattito su ghetti, caporalato e sfruttamento. Dimitri si chiede come sia possibile che una passata di pomodoro con tanto di «vaso in vetro e un tappo sopra che si apre» possa costare 15 centesimi. A rispondere in diretta è Marco Nicastro, presidente della Federazione nazionale del pomodoro da industria di Confagricoltura. Chiamando in causa la Grande distribuzione, «che offre non solamente pomodori ma anche altri tipi di prodotti a prezzi stracciati», Nicastro pone l’accento sui ricavi delle aziende per il barattolo a 15 centesimi. «Che in campagna un kg di pomodoro deve essere pagato a 2-3 centesimi per arrivare a quei costi ed essere competitivo sulla Grande distribuzione, io non ci sto».
Lo Stato? Assente ingiustificato
«La Rete del lavoro agricolo di qualità è una grande opportunità – spiega a Left Giovanni Mininni – ma non viene attuata fino in fondo». La cabina di regia si limita a «ratificare le domande di iscrizione, inserendo o depennando le aziende che inoltrano la richiesta». Ma la Rete, sulla carta, è molto di più. Almeno dal 29 ottobre 2016, quando entra in vigore la legge 199 “anticaporalato” – che ha perlomeno facilitato l’azione repressiva dei magistrati – e vengono istituite le sezioni territoriali. Composte da enti locali, centri per l’impiego e agenzie per il lavoro, sportelli unici per l’immigrazione ed enti bilaterali, le sezioni (citiamo testualmente la legge) «(…) svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (…) promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convezioni con gli enti locali». Tutto bene, tanti progetti per promuovere l’agricoltura di qualità. C’è solo un piccolo particolare: le sezioni territoriali non si sono mai riunite.
«Rispetto all’anno scorso non è cambiato nulla». Un dato reale e tangibile, che lo stesso Mininni ha toccato con mano. Con le “brigate del lavoro” il sindacato è entrato nei campi per monitorare la situazione. Dal 5 al 7 settembre, agli sgoccioli della stagione della raccolta del pomodoro, un manipolo di operatori e sindacalisti ha setacciato le campagne pugliesi per incontrare i lavoratori, informarli sull’attuale legge di contrasto del caporalato. Bottigliette d’acqua e cappellini bordati con il logo della Flai regalati nelle distese di terra e braccia. Nonostante questa mobilitazione, ammette lo stesso segretario Flai Cgil, «alle cinque e mezza del mattino, i furgoncini dei caporali raccoglievano dal ciglio della strada centinaia di lavoratori pronti per la giornata, come se nulla fosse successo».
E i centri per l’impiego? Le sperimentazioni? Le forme inedite ed innovative di collocamento, con le imprese che lamentano intoppi e rallentamenti burocratici? Il caso di Foggia è emblematico, «il centro per l’impiego è aperto dalle 9 alle 11 – dichiara sconsolato Mininni -, con la Rete del lavoro agricolo di qualità avremmo potuto avviare progetti che includessero associazioni e istituzioni locali per un collocamento diffuso, utilizzando le liste di prenotazione». Schedari e graduatorie con i nominativi dei lavoratori agricoli registrati, anche su base volontaria. «Alle nostre segnalazioni – chiarisce – poche risposte».
Insomma, siamo di fronte a una partita giocata sui gangli della Rete, sulle crepe e sulle contraddizioni del provvedimento. Nella provincia di Barletta, Andria, Trani (Bat) la Flai Cgil non ha firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli. Una trattativa di 17 mesi: dalla fine del 2015, le parti sociali non riuscivano a siglare un accordo, e Confagricoltura, Coldiretti e Cia, con Fai Cisl e Uila Uil, hanno raggiunto un’intesa solo ad agosto, senza la Cgil. «Non potevamo accettare un simile contratto, penalizzante sotto il profilo salariale, contributivo e previdenziale con uno scivolamento delle figure professionalizzate al parametro più basso». Ma perché puntare ad un contratto che livelli i diritti e le tutele, comprimendo i salari? Oltre al conflitto di classe e agli interessi delle imprese, la risposta risiede nella natura della norma. «Il rispetto del contratto nazionale e provinciale degli operai agricoli è uno dei quattro requisiti introdotti dalla legge 199 per far parte della Rete – spiega il sindacalista -. Far passare un simile accordo, significa allargare le maglie del lavoro di qualità» e, in altre parole, permettere alle aziende di salire con più facilità sul carrozzone della legalità, abbassando il costo del lavoro.
Alle domande che Left ha indirizzato al ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, sul perché di questo stallo nella lotta al caporalato, non abbiamo ricevuto risposta. Ma nel frattempo, mentre si assiste al lento naufragio della Rete, regioni e prefetture guardano altrove, concentrando la loro attenzione sulle baraccopoli dove sono accampati i braccianti in numerose zone italiane.
Nei nuovi ghetti si entra col badge
Il riordino del comparto agroalimentare e la sua normativa passa anche per il “cambio d’abito” dei ghetti nel sud Italia. In Puglia, Calabria e Basilicata, dall’inizio di quest’anno, si assiste a sgomberi e all’allestimento di grandi tendopoli o campi container, che i singoli prefetti definiscono “temporanei”. Alla base di queste operazioni, sembra esserci un disegno securitario che si perpetua, e che in realtà allontana i lavoratori dalla conquista di una casa. In cambio di identificazioni e controlli, infatti, ai migranti che arrivano al sud per la raccolta di pomodori, cocomeri e agrumi, vengono offerti questi alloggi dotati di acqua potabile e assistenza sanitaria. La conditio sine qua non per potervi accedere però sono i documenti: solo con il permesso di soggiorno si ottiene il badge di ingresso.
In Puglia, a Nardò, in provincia di Lecce, teatro della rivolta dei migranti nel luglio 2011, il 23 agosto scorso, il sindaco Giuseppe Mellone ha inaugurato il “Villaggio dell’accoglienza”: 60mila euro di container con telecamere, bagni e presidio medico, finanziati dalla Regione e dal Viminale, nel piazzale antistante la Masseria Boncuri, laddove per una settimana, i braccianti scioperarono per la prima volta, chiedendo condizioni di lavoro dignitose. Le associazioni locali denunciano che il 30 settembre, il campo sarà già smontato, a danno delle decine di lavoratori che resteranno lì fino a dicembre, senza sapere dove andare. Nella zona della Capitanata, in provincia di Foggia, lo sgombero del Gran ghetto di Rignano Garganico è iniziato il primo marzo scorso, ma non ha avuto i risultati sperati. La morte dei maliani Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, nell’incendio del 3 marzo, ha accelerato il trasferimento degli ospiti dell’area, messa sotto sequestro dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, per presunte infiltrazioni criminali.
Da allora, ad accogliere una parte degli “esodati” del Gran ghetto, sono l’azienda agricola Fortore – ribattezzata Casa Sankarà – e l’Arena, entrambe nell’Agro di San Severo, in provincia di Foggia. Qui sono 200 le persone che hanno trovato ospitalità – un numero irrisorio, a fronte delle mille circa che ospitava il ghetto – ma la lontananza dalle campagne rende difficile trovare un lavoro. È per questo che circa 500 migranti hanno scelto di restare nei pressi del Gran ghetto. «Qui c’è il grosso del lavoro ed è qui che i braccianti preferiscono vivere, anche perché c’è meno polizia», commenta Simone Cremaschi, ricercatore in Scienze sociali presso l’European university institute, che segue da mesi gli spostamenti dei lavoratori. Le operazioni di sgombero però hanno provocato la distruzione delle vecchie baracche, lasciando donne e uomini in balia di sé stessi: da giugno quindi, all’ex Ghetto, è nato il business delle roulotte, il cui prezzo adesso sfiora i 400 euro. Ma le condizioni igienico-sanitarie restano precarie, come pure il fronte delle regolarizzazioni dei lavoratori. A denunciarlo, la rete Campagne in lotta, che, dopo l’incontro del 30 giugno al Viminale, ha riportato a Left le parole del capo Dipartimento libertà civili e immigrazione, Gerarda Pantalone: «A Foggia non esistono problemi di illegalità»; e quelle del Commissario straordinario Iolanda Rolli, da poco insediata: «Non conosco ancora bene la situazione del Foggiano».
In Calabria, i riflettori sono tutti puntati sul ghetto di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Anche qui, non si vede neanche l’ombra di una casa per i raccoglitori di agrumi, ma da agosto, è nata la nuova tendopoli, adiacente al vecchio ghetto sorto nel 2010, che ospitava circa 2mila persone. Nel nuovo complesso, composto da due strutture, si entra dotati di badge e solo dopo aver lasciato le impronte digitali. All’interno, la Protezione civile gestisce 464 alloggi, dotati di docce, elettricità, una cucina comune – per una spesa di 600mila euro -, ma sono ancora molti i migranti che preferiscono andare a cucinare nel vecchio ghetto, dove esistono ancora negozietti informali e non si avvertono gli occhi insistenti delle telecamere. Come racconta Michele di Sos Rosarno, l’area è attualmente presidiata da guardia di finanza, polizia e carabinieri, che inibiscono l’avvicinamento dei caporali e quindi, il lavoro dei braccianti. Michele, presente il giorno dello sgombero del vecchio ghetto, ha sottolineato che il prefetto ha indicato la nuova tendopoli come una sistemazione temporanea. «Per i mesi futuri, la prefettura sta interrogando i comuni limitrofi, per cercare di attuare forme di accoglienza diffusa». Ma c’è chi, come Campagne in lotta, non crede in questo disegno e reputa la nuova struttura «inadeguata e fortemente coercitiva».
In Basilicata, non è cambiato niente rispetto agli altri anni. Qui, gli unici ad arricchirsi continuano ad essere i caporali e chi garantisce loro l’impunità. «Solo a Palazzo San Gervasio – racconta Gervasio Ungolo, coordinatore dell’Osservatorio migranti Basilicata – la vendita del pomodoro vale 6 milioni di euro, ma per raccoglierlo, gli agricoltori devono pagare 1 milione, che va tutto ai caporali. Questo significa per i caporali 2-3mila euro al giorno di guadagno». Il ghetto di Boreano è stato sgomberato, ma i migranti vivono ancora tutti attorno a quel comprensorio rurale. Ungolo è stato raggiunto da minacce e intimidazioni e quest’anno non si è recato nei campi insieme agli altri volontari. Ci ha spiegato che, dopo la firma del Protocollo provinciale contro il caporalato, Caritas e Croce rossa italiana forniscono i principali servizi di accoglienza, in cambio di lauti finanziamenti. Ma è ancora nei ghetti che si gioca la partita più importante delle istituzioni, sempre in bilico tra il mantenimento di uno status quo malavitoso e la denuncia degli illeciti. «Ultimamente ad essere cresciuto, è il Ghetto di Strada Mulino Matinelle, un ginepraio di interessi, costruito non più con materiali di risulta, come avviene di solito, ma con travi nuove. Segno che il business dei ghetti è ancora fortissimo e destinato a perdurare».

L’inchiesta di Leonardo Filippi, Maurizio Franco e Maria Panariello è tratta da Left n.39
SOMMARIO ACQUISTA



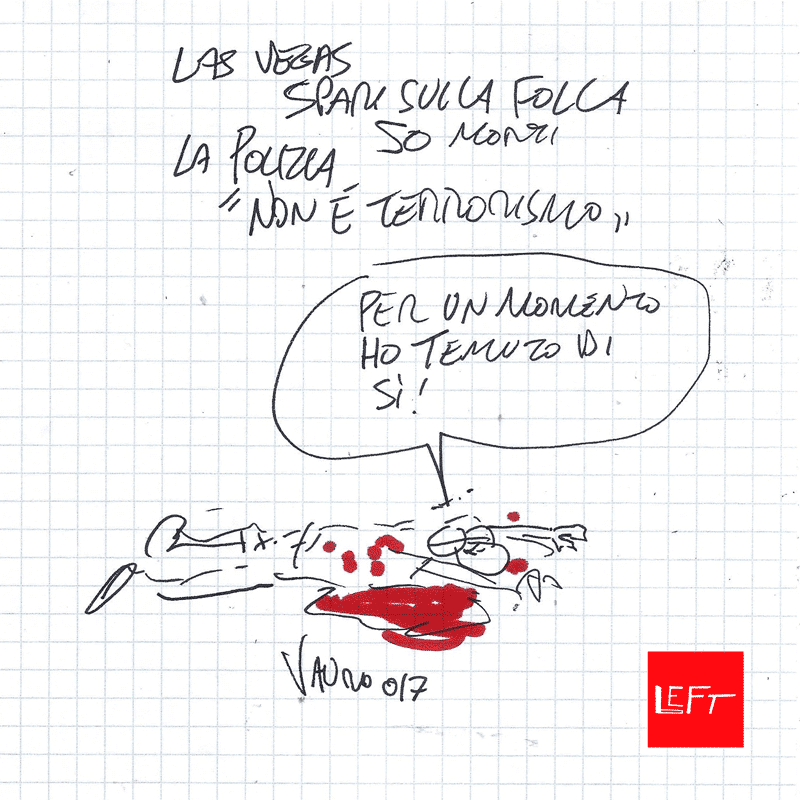




 Spesso tu utilizzi una frase di J. Guimaraes Rosa: «Scrivere per resistere». Cosa significano queste parole per Mario Delgado Aparaín?
Spesso tu utilizzi una frase di J. Guimaraes Rosa: «Scrivere per resistere». Cosa significano queste parole per Mario Delgado Aparaín?



