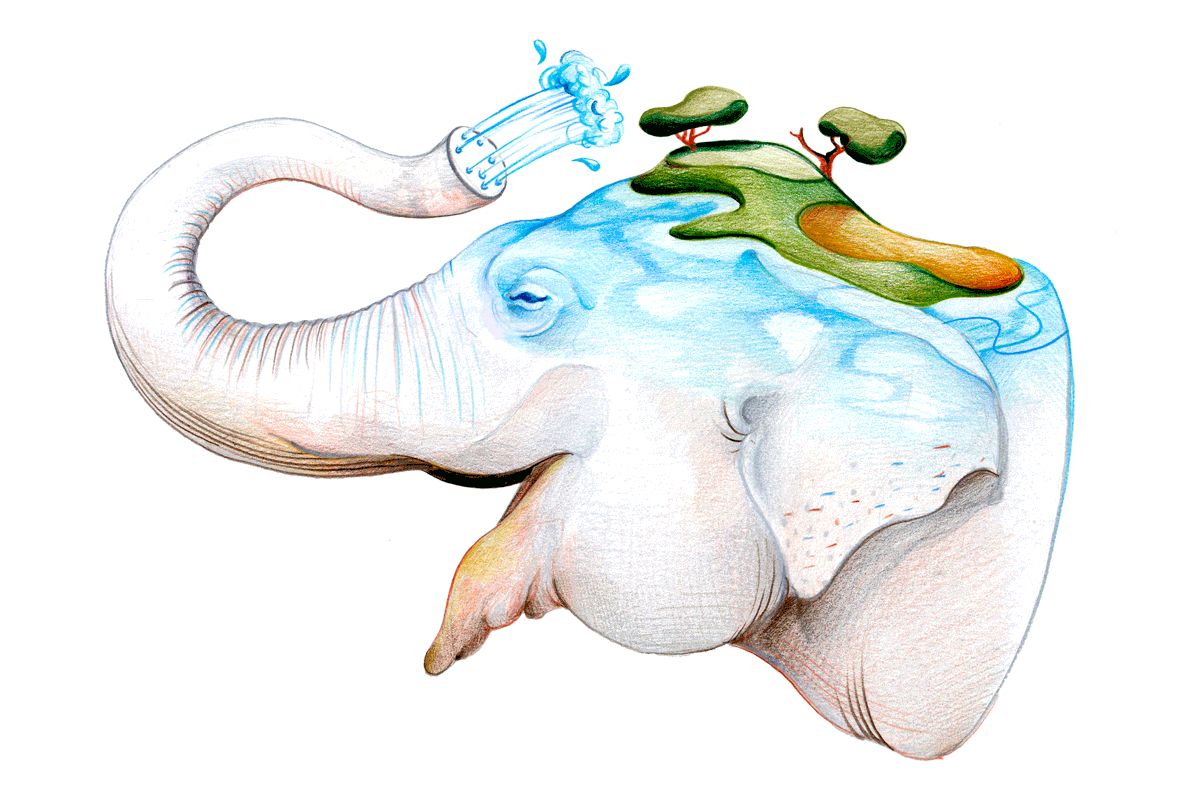Il referendum, innanzitutto: hanno votato 15 milioni di persone. 15 milioni di persone che per tutto il giorno ieri sono stati coglionati da una banda di fascistelli 2.0 che sbavano arroganza sui social. Niente olio di ricino: la nuova frontiera è la presa per il culo di quattro dirigenti servetti (che senza Renzi sarebbero ad animare la pro loco del paesello) che si inventano un #ciaone per pisciare sui referendum con il Matteo nazionale che parla di “un fronte pro referendum che ha monopolizzato le tv” e di “politici che vivono su twitter”. Matteo Renzi, capite: quello che riesce a berlusconare in 140 caratteri, senza nemmeno il calcio, la gnocca e la mafia.
Riuscire ad offendere milioni di persone che nonostante una campagna diffamatoria sul referendum, sulla Repubblica e sulla Costituzione hanno deciso di recarsi alle urne nel Paese più impolitico d’Europa (qui dove la Merkel ha incoronato Monti e poi Napolitano ha incoronato Renzi) in una domenica d’aprile è l’ennesima conferma di ciò che continuo a credere da tempo: siamo di fronte alla più sciatta, insolente, paninara, bulla, arrogante, saccente seppur ignorante, insulsa e pericolosa classe dirigente politica degli ultimi anni. Questi di oggi sono personaggi da televisione anni ’80 cresciuti lobotomizzati da un ego problematico che li ha resi vendicativi e torvi: anche quando sorridono non riescono a nascondere il filo di bava che gli cola dagli angoli dalla bocca per l’ultima masturbatoria vittoria dell’Io. Sono adolescenziali nella gestione dei risultati, immaturi nelle reazioni e appaiono ogni giorno di più come una combriccola di inadeguati che per un colpo di culo si sono incastrati perfettamente convergenti agli interessi del loro tempo. Sono la fibbia patacca di una cintura che tiene le fila delle più vecchie corporazioni: Renzi e renzini sono la buccia geneticamente colorata di un frutto marcio e rimasticato; fingono di avere innestato una nuova generazione nella politica italiana ma sono i figli diretti dei mediocri della prima repubblica con la sola differenza che sanno cercare più in fretta l’aforisma giusto su google in base all’evenienza.
Matteo Renzi in televisione, alla chiusura dei seggi, è apparso con tutta la ferocia di chi per governare ha bisogno di nutrire il proprio risentimento: ha ribaltato la realtà, ha infilato una serie di falsità sparate con il suo solito mezzo sorriso e ha rovesciato il risultato come letame sugli avversari (Michele Emiliano in primis). Non sa, Renzi, che chi ha bisogno dello scontro per brillare è quanto di meno politico ci si possa augurare a capo del governo: l’unica mediazione di cui è capace è quella di parlare di lui al massimo di sponda smontando qualcun altro, buttando legna sul braciere del tifo come un patetico aizzatore del quartierino.
È servito questo referendum a mostrare la vera faccia del potere dominante di questo tempo. Un potere che domina semplicemente perché è malleabile da dominare per coloro che hanno bisogno di restare nascosti e che vive la politica come un’incessante serie di occasioni di rivalsa. Matteo Renzi è la chioccia di un assembramento di mocciosi che non si accorgono, cretini, di essere i migliori amici di coloro che vorrebbero (ma davvero?) combattere: hanno instillato un rancore politico peggiore di alcuni esegeti del Movimento 5 Stelle, rincuorano i conservatori meglio della migliore Democrazia Cristiana, hanno sdoganato la “solidarietà solo tra sodali” meglio di un clan, usano l’Italia come slogan come un partituncolo di destra, leccano le scarpe a confindustria meglio della Forza Italia dei tempi d’oro, continuano ad ammansire imbolsiti comunisti come una sezione rifondarola ma cattocomunista, piacciono ai cardinali ma non disdegnano le puttane, fingono di combattere il sistema che li tiene al guinzaglio meglio dei socialisti dei tempi d’oro, pisciano sul referendum, inaugurano la Salerno-Reggio Calabria, promettono (a chi serve che capisca) il ponte di Messina, fanno petting con i gay con una mezza legge tremolante che accontenta anche i parroci, twittano contro twitter, facebookano contro Facebook, vanno nei talk per dirsi contro i talk, trasformano il giornale di Gramsci in un bugiardino di partito, rendono il partito la lettiera del giglio magico e coglionano gli elettori come faceva quell’altro.
Sul referendum quindi sì, i maggiorenti del PD hanno vinto. Ma tecnicamente parlando a sentire l’effetto che fa viene il dubbio che, come si diceva a Drive In, abbiano pestato una merda.
Buon lunedì.