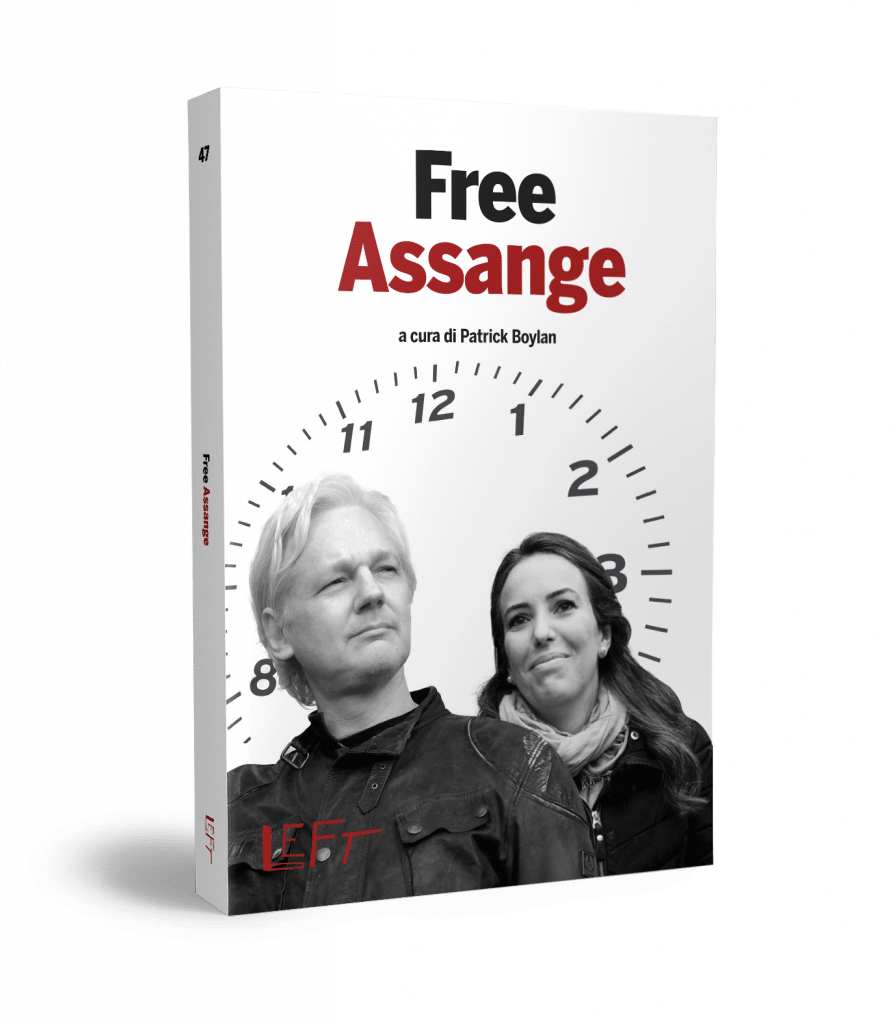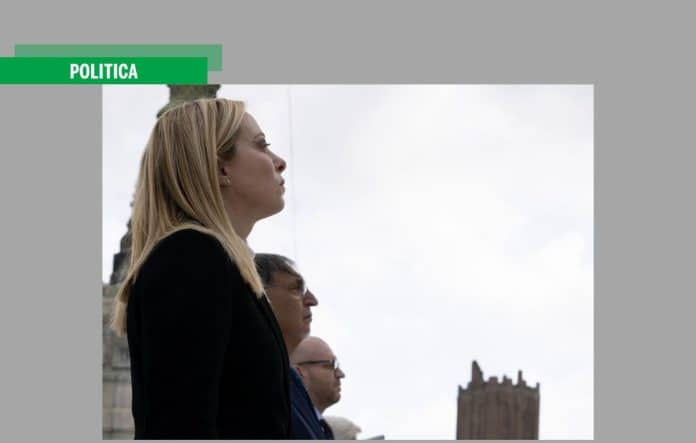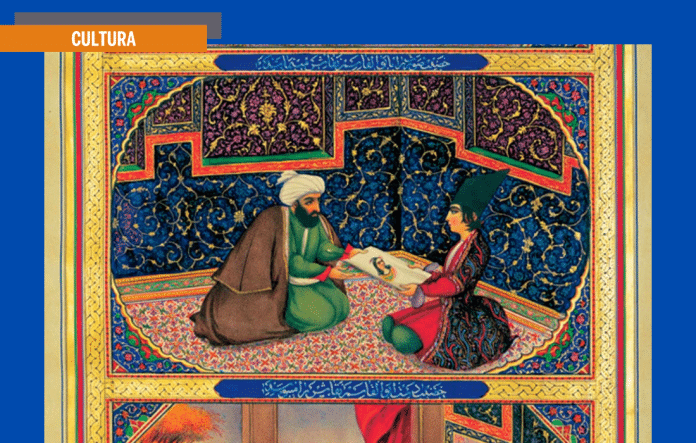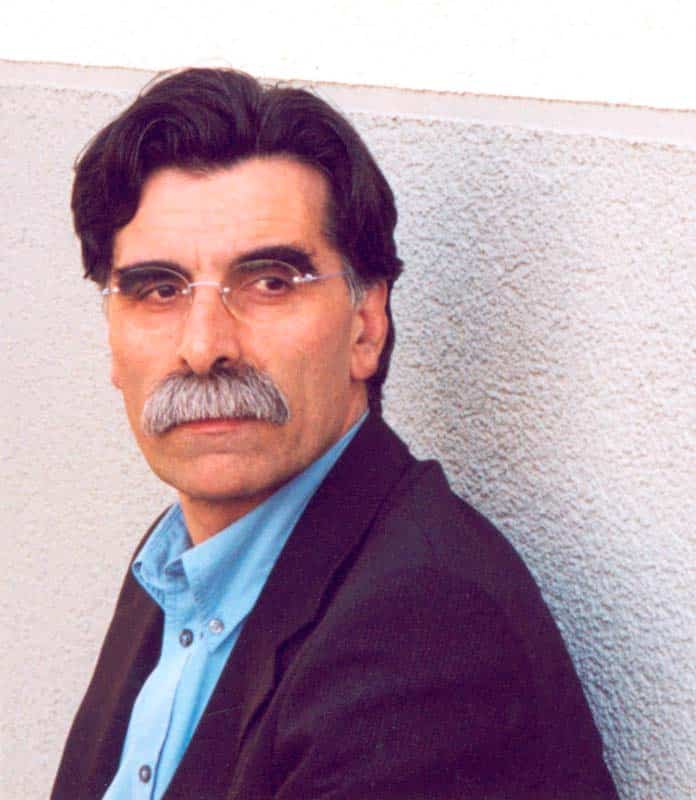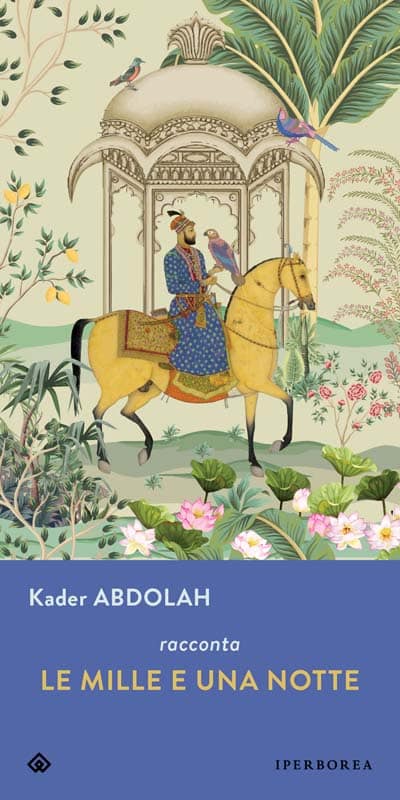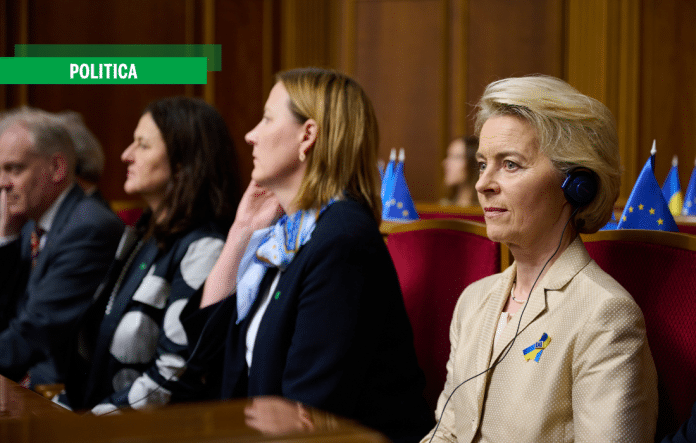«Nel mio lavoro non c’è difesa. La Venere degli stracci deve essere un’opera aperta». Così Michelangelo Pistoletto ci disse all’indomani dell’attacco alla sua opera a Napoli, compiuta da una persona con problemi psichici che lui ha cercato in tutti questi mesi di fare uscire dal carcere perché fosse curato. Oggi 6 marzo, la sua opera rivive a Napoli in nuova forma nuova. La conferenza stampa di presentazione dell’opera si può seguire sul sito del Comune di Napoli
Qui riproponiamo la nostra conversazione pubblicata su Left il 2 agosto 2023
Maestro Michelangelo Pistoletto, l’incendio in piazza del Plebiscito a Napoli della sua Venere degli stracci è stato un femminicidio, lei ha detto in una intervista. La sua Venere è una immagine femminile che vive e si rigenera dal 1967 e nota in tutto il mondo. Come sta vivendo questo momento?
In realtà non è stata una mia espressione: devo alla mia compagna questa considerazione. Quando abbiamo saputo dell’incendio dell’opera ha reagito dicendo: “l’ho sentito come un femminicidio”. Mi ha colpito il suo commento sensibile, mi è parsa molto significativa questa sua intuizione. Concretamente il fuoco è stato appiccato agli stracci. Ma hanno bruciato la Venere insieme ad essi. L’attacco morale di fondo, oltreché estetico, è la Venere che rappresenta la femminilità, che attraversa tutta la storia dell’umanità come emblema di bellezza, di sensibilità, di amore e di venerabilità.
Ha detto di voler incontrare la persona che è accusata di aver incendiato l’opera. Accadrà?
Avevo chiesto di poterlo incontrare quando era stato ipotizzato si trattasse di un clochard. Ma dalle indagini di polizia sembra emergere qualcosa di diverso. A questo punto non voglio intromettermi nel loro lavoro. Non so quali siano state veramente le motivazioni che hanno fatto scattare questo gesto incendiario e mi rendo conto che non posso in un rapporto così, amichevole, arrivare alla verità.
La sua Venere come tutta l’arte in piazza è vulnerabile, è di tutti, è gratuita, non chiede un biglietto. Anche questo concorre alla sua forza e bellezza?
Nel mio lavoro non c’è difesa. L’esposizione pubblica è fatta apposta per favorire l’interazione. Accade fin dai miei primi quadri specchianti dove il mondo rappresentato dalle persone che si guardano nell’opera è interamente compreso in essa. Lo spettatore è parte dell’opera d’arte, viene incluso, non ha una posizione esclusivamente contemplativa. La Venere degli stracci deve essere un’opera aperta. I vestiti che la circondano sono chiamati stracci perché sono stati usati, hanno avuto dentro di sé corpi umani; è l’umanità stessa che si ritrova nella moltitudine di questi indumenti, così come si può ritrovare nella moltitudine delle persone che si riflettono nei quadri specchianti.
Non è la prima volta che le sue opere vengono colpite. Era già accaduto molti anni fa negli Stati Uniti: i suoi quadri specchianti subirono una violenta aggressione nella galleria di Leo Castelli. Cosa scatenò quell’attacco?
Trovai colpi fortissimi sulla parte specchiante dei miei lavori. Accade proprio dentro la galleria di New York dove stavo per inaugurare la mia mostra. Quella volta ebbi un po’ paura. Avvertivo una violenza contro di me, anche a livello personale, che veniva da un certo ambiente artistico. All’epoca il mio lavoro veniva incluso nella Pop art newyorchese. Non perché io mi ci fossi infilato, ma perché mi ci misero dentro. Il mio lavoro era oggettivo e la Pop art praticava l’oggettività della raffigurazione, ma il problema fu che gli artisti americani, già dall’epoca dell’Action Painting, scrivevano esplicitamente che intendevano tagliare i ponti con l’arte europea. L’Europa doveva diventare secondaria rispetto al potere americano, questo era inteso sotto tutti i profili, ma soprattutto sotto quello politico a cui aderirono gli artisti pop. Sposarono quel sistema universalmente inteso che è il sistema consumistico. Il mio lavoro non avendo nulla a che fare con quel sistema non aveva più ragione di essere presente là dove si voleva negare il rapporto con il passato e con l’Europa.
Nella storia, prima del turbo capitalismo, la fantasia degli artisti è stata attaccata dalle teocrazie e dai regimi. La secolare e feroce storia dell’iconoclastia ci insegna che dittatori e religiosi non tollerano riferimenti all’arte che allude all’umanità più profonda e a una possibilità di trasformazione interiore. Che ne pensa?
L’iconoclastia è un fenomeno estremamente complesso e cruciale. Curiosamente nei giorni scorsi stavo appuntando delle note proprio su questo tema (continuo a scrivere man mano che procedo nella mia ricerca). Da sempre mi colpisce la necessità che molte persone hanno di identificarsi in un elemento che possa unirle; fosse pure una bandiera, un dogma, un simbolo di appartenenza. Ma se c’è di mezzo l’aspetto religioso, invece di “religare” (unire), l’effetto è “relegare” (escludere): crescono elementi che confliggono distruttivamente fra di loro, per il possesso del potere. Da qui le guerre, le fratture insanabili. Nell’incapacità di “religare” i rapporti umani si relega e si confligge drammaticamente fra le varie bandiere.
Al contrario lei ha sempre cercato un modo per poter far sì che l’arte sia fattore di coesione e motore di un cambiamento sociale “progressista”, oserei dire, evolutivo per l’umanità. Come si è sviluppata questa sua ricerca?
Io ho sempre pensato che l’arte sia il fermento essenziale del pensiero umano. Non solo in astratto. L’arte è la messa in pratica dell’attività umana; la parola tecnè corrisponde al concetto di arte: è l’arte che pensa, l’arte che fa. Nel Novecento l’arte ha sviluppato una sua autonomia man mano sempre più chiara, sempre più precisa. Ogni singolo artista ha assunto autonomia e autorialità propria. Per me, tuttavia, non era sufficiente che l’artista realizzasse la propria identità e libertà assoluta, perché in questo modo sarebbe rimasto solo, fuori dal mondo. La libertà dell’artista doveva essere messa a disposizione dell’intera umanità.
L’artista, in questo senso, ha una responsabilità?
L’arte per mantenere la propria autonomia non deve essere sottomessa a nessuna altra trama. Ma deve assumersi la responsabilità di produrre in prima istanza il sistema sociale, che va dalla politica all’architettura, a tutto ciò che fa la società. E qui torniamo a ciò che lei accennava: l’arte deve essere al centro di una trasformazione responsabile della società. Lo vediamo tutti i giorni: il mondo è attraversato da molti conflitti distruttivi, dobbiamo liberarcene per andare verso ciò che l’arte può portare: equilibrio, armonia e consapevolezza.
In questa direzione va il suo progetto Terzo paradiso, nato da una espressione persiana, che allude a un giardino protetto?
Il Terzo paradiso è un’idea che mi è balenata quando ho visto che nel mondo erano entrati in conflitto natura (mondo naturale) e artificio (mondo artificiale). Sappiamo ormai benissimo che stiamo procurando al pianeta un danno che torna completamente contro di noi. Non possiamo più aspettare. Come artista sento di dover prendere l’iniziativa per stimolare la capacità di creare che è insita in tutti gli esseri umani. Ribadisco, come artisti possiamo realizzare questa massima libertà e responsabilità. Ma bisogna trovare le forme e i metodi opportuni. Anche per questo ho creato il simbolo che ho chiamato Terzo Paradiso, terzo stato dell’umanità in cui i due elementi contrapposti si incontrano al centro producono un elemento nuovo, una realtà che non esisteva, la sintesi di due opposti. Gli estremi e le contraddizioni ci saranno sempre, sta a noi usare il metodo della creazione per dar vita a quell’equilibrio che corrisponde al termine di “umano”, ancora ben lungi dall’essere raggiunto.
Benché lei avesse già un suo percorso avviato, decise di prendere parte al gruppo dell’Arte povera. Più di recente a Biella ha fondato la Cittadellarte dove collaborano ragazzi da ogni parte del mondo. Quale importanza ha per lei il lavoro creativo collettivo?
Ora, secondo me, non conta più tanto lo studio personale come luogo fisico dell’artista, dove produce il proprio lavoro esclusivo e neanche l’opera dell’artista che va in gruppo per strada facendo i suoi graffiti sui muri. Per me è stato importante creare un luogo dell’arte in cui si incontrino tutti gli elementi, tutti i settori che formano la società. L’arte produce una sensibilità che permette di intuire come i vari aspetti della società stessa possano essere modificati, ricreati, riformulati, proponendone la concreta rigenerazione. La Fondazione Pistoletto Cittadellarte punta a una rifondazione della società. L’asse portante è la scuola: una accademia laboratorio dove si insegnano non solo le diverse discipline ma un’arte interdisciplinare che incentiva lo sviluppo di una nuova società. Si formano i giovani che diventano maestri delle nuove generazioni
La Galleria Arte Continua a San Gimignano propone in particolare un suo nuovo autoritratto in cui lei appare con la regalità della statuaria classica e con la pelle tatuata di qrCode. Quale passo ulteriore rappresenta questa opera rispetto ai suoi celebri autoritratti e ai quadri specchianti?
Nei quadri specchianti ho introdotto la memoria nello specchio. Lo specchio riflette immediatamente ciò che sta accadendo, rispecchia il presente continuamente mutevole: quello che c’era ieri oggi non c’è più, è una incessante trasformazione. Ma io fisso nel quadro un presente che rimane e diviene memoria. La memoria per noi esseri umani è fondamentale. E l’arte evoca la memoria più antica fin dai primordi, fin dalle prime tracce che gli esseri umani hanno lasciato. L’arte, che sia figurazione o parola scritta, rimane.
Nei suoi quadri specchianti c’è la realtà in fieri, il divenire continuo, ma c’è anche lo scatto di un istante fisso fotografato?
Ciò che io fisso su un quadro specchiante è la memoria di un istante che fermo e non lascio passare, dunque, quell’istante durerà fin quando esisterà il quadro specchiante e qualcuno apparirà in esso. Nel quadro specchiante c’è la memoria dell’istante che passa. L’autoritratto qrCode include molteplici memorie di me stesso. Molti momenti della mia vita artistica sono impressi in quella mia immagine: c’è la memoria fissa e c’è la memoria lunga e complessa, così come se dentro la mia immagine ci fosse un libro che racconta me stesso. Ho realizzato questo lavoro ben sapendo che probabilmente in un domani questi dispositivi tecnologici potrebbero anche non funzionare più, come è accaduto per le cassette musicali e video, floppy disk ecc. In futuro la tecnologia attuale sarà superata. Per aggirare una eventuale perdita di memoria questi codici che sono impressi nel mio corpo vengono trasmessi anche attraverso la scrittura e il sistema tradizionale di stampa.
La stampa su carta alla fine è la più longeva, come dimostrano millenni di storia?
Sì, penso che la pubblicazione cartacea sopravviverà come sono sopravvissute le incisioni rupestri, io voglio spaziare in tutti i sistemi tecnologici ed essi ritornano sempre alle basi primarie.
In 90 anni del Maestro dell’Arte povera
Michelangelo Pistoletto non si è mai fermato, ha sempre continuato con passione una propria originalissima ricerca, fin dagli anni della sua prima formazione, quasi da autodidatta, con suo padre pittore figurativo, rifiutando Gesù e il Duce, come guide che venivano imposte in quegli anni e poi lasciando lo studio di Armando Testa dove l’aveva iscritto sua madre, pensando che la pubblicità fosse il futuro. Lui non si rifiutò, ma – come racconta nel libro intervista La voce di Pistoletto (Bompiani) – usò quell’occasione per studiare l’arte contemporanea. Sussunto, suo malgrado, nella Pop art ne rifiutò le ragioni mercantilistiche. Benché fosse già un artista conosciuto si unì al gruppo dell’Arte povera (il nome fu coniato da Germano Celant) che proponeva una nuova estetica attenta al rapporto fra esseri umani e natura, tema assolutamente all’avanguardia negli anni Sessanta. Per poi tornare a sviluppare la propria ricerca in modo autonomo, sperimentando a tutto raggio, investendo molto sull’arte negli spazi pubblici, assumendosene tutti i rischi. Che si sono resi palesi a Napoli, dove la sua ricreazione in chiave monumentale della Venere degli stracci, (concepita nel 1967) curata da Vincenzo Trione nell’ambito del progetto Open. L’arte in centro, è stata attaccata, arsa, ridotta in cenere. La Venere di Pistoletto, simbolo femminile di rigenerazione risorgerà dalle sue ceneri, assicurò il sindaco di Napoli Manfredi, all’indomani del rogo. Mente l’associazione Mi Riconosci? gli contestava la scarsa concertazione con la cittadinanza.
Ci pare importante tornare a raccontare la straordinaria ricerca di Michelangelo Pistoletto che da più di 60 anni si sviluppa giorno per giorno, con una fiducia profondissima nell’umano, investendo proprio nel dialogo con gli altri. Con i giovanissimi giunti da ogni parte del mondo che popolano la sua Accademia alla Cittadellarte a Biella, ma anche con i cittadini dove vengono esposte le sue opere pubbliche e non solo. Di recente ricordiamo la sua mostra a Roma nel Chiostro del Bramante dal titolo Infinity curata da Danilo Eccher: il percorso squadernava 50 opere e 4 installazioni fra le quali una potente edizione della Venere degli stracci, accanto al simbolo del Terzo paradiso che ricrea l’idea del giardino segreto mutuata dalla antichissima e laica cultura persiana. (Nel libro La voce di Pistoletto l’artista afferma di essere ateo, «preferisco pensare e non credere»). A Roma negli spazi della Galleria Continua all’interno dell’albergo The St. Regis si è tenuta Color and Light, the latest works, dedicata a nuovi, coloratissimi lavori. A San Gimignano invece Galleria Continua ha proposto una selezione di quadri specchianti, fra i quali anche il nuovissimo auto ritratto con qrCode. Altre mostre si sono svolte a San Paolo, a Beijing, a Dubai, a Biella e al Castello di Rivoli.