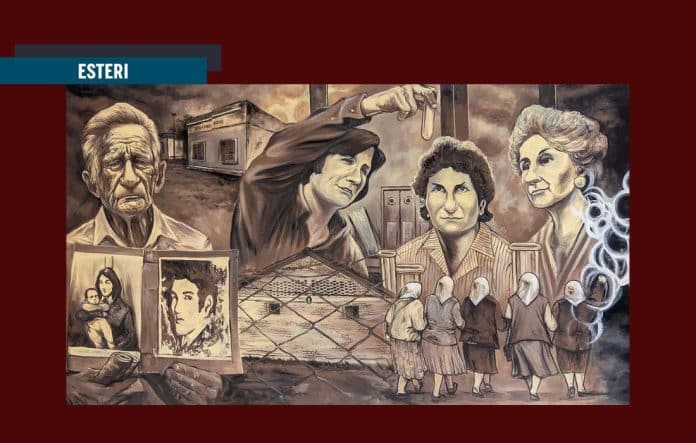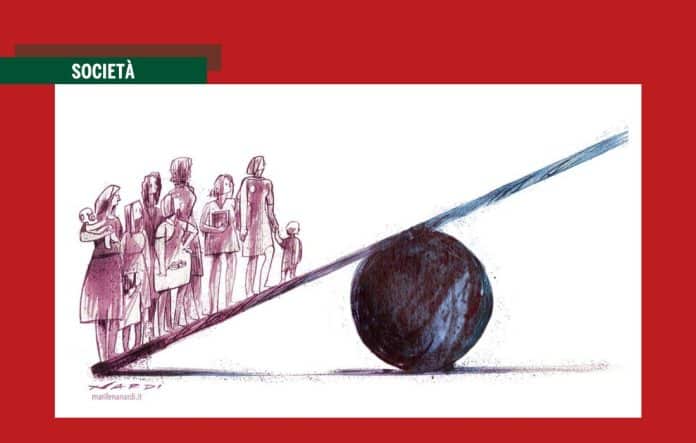Murale realizzato a Tucumán da César Carrillo e Fátima Leal
Con il romanzo biografico Adelaida (Nutrimenti, in corsa per lo Strega), Adrian Bravi compie un’azione di rottura con l’«eterno presente» in cui viviamo, formulando un esercizio di memoria per far riemergere un passato sommerso. Realizzando anche un atto «doveroso» per celebrare un solido rapporto d’amicizia che si è alimentata per oltre vent’anni nelle pieghe di un singolare intreccio tra la sua vita e quella della protagonista. «Sono molti i punti di contatto che mi legano ad Adelaida Gigli – racconta lo scrittore italo-argentino. Quando ero poco più di un bambino ricordo che abitavamo nello stesso quartiere di San Ferdinando, alla periferia di Buenos Aires. Arrivato in Italia, nel 1988, lei è stata la prima persona che ho conosciuto. Frequentarla, a quei tempi, mi permetteva di mantenere vivo il legame con l’Argentina, placare il senso di nostalgia che mi attanagliava. Poi, oltre a riconoscerle il ruolo di custode della storia del mio Paese, l’ho ammirata per il suo spessore di donna e di intellettuale».
Aveva 25 anni Adrian Bravi – oggi scrittore noto e apprezzato e bibliotecario all’Università di Macerata, dove ha conseguito la laurea in filosofia – quando attraversò l’Atlantico per stabilirsi nelle Marche, a Recanati, paese dove era nato suo padre emigrato nella terra d’argento negli anni Quaranta. È qui che rincontrò la sua vecchia vicina di casa, una donna di sessantuno anni e un’artista dalla vita avventurosa, difficile, piena di vitalità, complessa e a tratti tragica: per Adelaida Gigli quello nel borgo di Leopardi era stato un ritorno da esule, dopo essere andata via da piccolissima, a soli quattro anni, col padre Lorenzo, noto pittore, e la mamma bonaerense Maria Teresa Valeiras, per sfuggire al fascismo.
In questo romanzo, appena pubblicato da Nutrimenti, l’undicesimo che scrive in italiano, Bravi si serve della scrittura come «mezzo per partecipare alla storia» consolidando un cambiamento che si era già intravisto in Verde Eldorado.