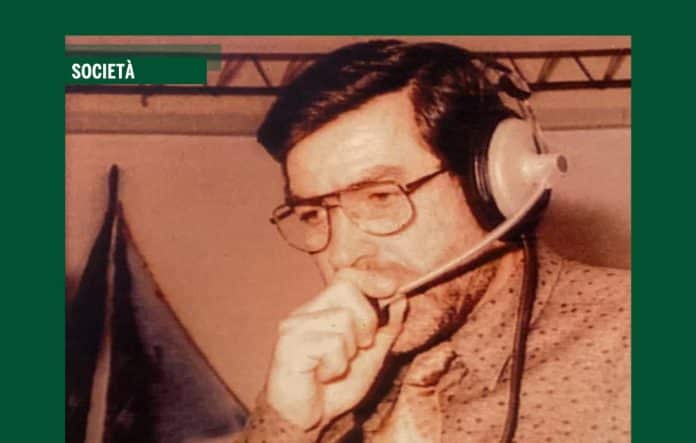Difficile non innamorarsi di Q, il protagonista del romanzo La libertà macchia il cappotto di Antonello Loreto edito da All Around. Scontroso, introverso, di spigolo con la vita, come quel muro storto contro cui palleggia tutti i giorni, mentre vola con la fantasia. Q, che all’anagrafe si chiama Quentin (in omaggio al regista di Pulp fiction),preferisce l’espressività del cinema muto al linguaggio convenzionale, normalizzato, che ferisce per troppa indifferenza. Ed è capace di cotte inenarrabili.
Abbiamo scoperto questo romanzo durante una passeggiata nel bosco nei dintorni di Moena in cui l’autore, di tappa in tappa, se ne faceva cantastorie, sollecitato da un vivissimo circolo di lettori. Ci siamo fermati a parlare con lui.
Benché La libertà macchia il cappotto non sia etichettabile e ascrivibile a un genere, ha molto del romanzo di formazione. Q. diventa adulto attraverso una serie di prove, errori, viaggi ed esperienze. Il pensiero corre a Il giovane Holden di Salinger. E’ stato fonte d’ispirazione?
Quando il romanzo è stato presentato al salone di Torino nella chiave di un Giovane Holden contemporaneo sono stato molto contento. Vedere il mio Q a fianco di un gigante della letteratura come Holden Caulfield è stata un’emozione, tanto più perché l’opera di Salinger è stata per la mia vita di giovane lettore un vero e proprio spartiacque. Per ognuno di noi c’è un prima e un dopo nel percorso personale di lettura, qualche scintilla (un personaggio, una storia) che ti mostra le cose sotto una luce diversa: ecco, per me lo sono stati Holden Caulfield a vent’anni e Ilja Ilic Oblomov a trenta. La loro visione del mondo e il loro originale modo di rapportarsi a esso mi hanno letteralmente cambiato la vita. E poi ancora, entrando nel merito, quasi senza che me ne accorgessi durante la stesura, ci sono molte analogie tra il giovane Holden e il mio Q: entrambi si allontanano progressivamente dai meccanismi della società nella quale vivono, entrambi hanno rapporti complicati con il mondo degli adulti, entrambi fuggono e non scappano, tenendoci molto – sia Q che Holden – a precisare che “fuggire” e “scappare” non sono due semplici sinonimi.
Il romanzo ha un sapore fiabesco. Si avverte il fascino della narrazione orale, dei miti, delle favole..
Tante cose mi portano in quella direzione, fin da quando ero un bambino e mia madre mi regalò “Favole al telefono” di Gianni Rodari (è stato il primo libro che ho letto). E poi il fatto che la Favola di Syd sia stato il mio romanzo d‘esordio, e ancora il fatto che tante persone abbiano avvicinato le storie che scrivo al genere letterario del “realismo magico” e infine la passione smodata che ho per la letteratura “iperborea” (anche grazie alla casa editrice che pubblica letteratura nordeuropea e che mi ha permesso di conoscere i boschi di Aarto Paasilinna). Tutto questo per dire che sono da sempre affascinato dal mondo delle favole soprattutto perché il “e vissero felici e contenti” non è mai scontato e per arrivarci si fatica parecchio
In questo orizzonte fiabesco, fortissima è la presenza del bosco di montagna che, quasi personificato, dialoga con gli altri personaggi. “Nel bosco non si esce mai come si è entrati”, dice la madre di Q. “Il bosco è un luogo di trasformazione”. Lo è anche per la sua narrativa che qui si nutre di una potente ambientazione alpina e della presenza di animali sintonici come il pesce Salgari?
Il mio romanzo punta l’attenzione su quel momento fondamentale per la vita che è rappresentato dal passaggio dalla fase dell’adolescenza alla fase della maturità e anche dal punto di vista simbolico il bosco mi è apparso come il luogo di trasformazione per eccellenza perché è un posto nel quale sai come entri e non sai come esci, quindi era l’ambientazione perfetta per quel passaggio, per quella trasformazione interiore del protagonista da adolescente a uomo maturo. E poi c’è un tributo, come accenno nella prefazione, al bosco di Paneveggio profanato nel 2018 dalla tempesta Vaia che ferì a morte le abetaie di quella foresta meravigliosa che io frequento da anni, e che mi è parso il posto migliore per la tempesta interiore che Q affronta.
Dopo il trauma della scomparsa della madre, di fronte alla superficialità bigotta della nonna e all’indifferenza dello zio che fa solo discorsi di circostanza il giovane Q si ribella scegliendo di non parlare. Il suo è un rifiuto netto ma creativo. Rinunciare al linguaggio convenzionale significa per lui anche scoprire altri linguaggi più emozionanti (dalla musica, al cinema muto). In un certo senso accade così anche a un romanziere?
Quello di Q è un originale sciopero della parola che prende le mosse dal suo grande amore per il cinema, passione che coltiva dopo i fatti terribili della sua adolescenza, quando decide di rinchiudersi in un bunker. In questo rifugio, in questa tana lui si sente protetto e spalleggiato dalle sue passioni per il cinema, appunto, ma anche per la musica, per le vecchie partite di Borg contro McEnroe che vede sul vecchio Vhs della madre, e tutto quel mondo immaginario che gli permette di evadere mentalmente da una realtà routinaria e complicata. Anche il rapporto speciale che Q ha con Emilio Salgari il suo pesce rosso, va in questo senso.
Come si sviluppa il suo originale sciopero della parola?
Q adotta una tecnica tutta speciale che denomina “del cugino Lumière” attraverso la quale ogni volta che si trova in una situazione di disagio sceglie “di muovere la bocca come una cernia dell’Ontario” attendendo pazientemente le reazioni spiazzate dell’interlocutore che ogni volta lo divertono molto. È la sua forma direi quasi autistica di protesta nei confronti di un mondo che non lo sta a sentire. Poi però scopre il “nadsat”, il linguaggio che Burgess utilizza in “Arancia Meccanica” e che viene poi ripreso da Kubrick nella famosa trasposizione filmica del romanzo. Allora Q decide di mettere in scena un suo personale nadsat inventando di continuo alcune paroline e sostenendo che molto spesso la parola deputata a definire esattamente un’azione, la parola ufficiale, non è del tutto efficace come magari può esserlo la parola inventata, e in questo modo giustifica il gioco di un adolescente dandogli un ardito connotato quasi filologico.
Tornando alla domanda, ora io non so se questa cosa succede anche alle altre persone che scrivono ma devo dire che io mi sono sempre divertito a giocare con le parole; nel mio secondo romanzo Un’altra scelta, il protagonista faceva veri e propri salti mortali carpiati con il suo modo particolare di parlare perché credo che sperimentare con la parola sia sfidante e stimolante per chi abbia l’ambizione di scrivere.
Il romanzo che è fortemente musicale. Fin dal titolo, evocativo, La libertà macchia il cappotto. E non solo perché sono citati i Porcupine Tree, Prince, i Pink Floyd ecc. Non solo per play list finale, ma per l’andamento stesso e il ritmo avvolgente della narrazione. Quanto la musica è d’ispirazione? Viene prima la musica o l’immagine?
Fin da ragazzo ho mangiato pane e libri, pane e cinema, pane e musica. Considero la musica uno stupefacente benevolo e formidabile perché, per dirla con Beethoven, la sua potenza trascende la parola ossia dove la parola non ce la fa a esprimere un concetto arriva la musica in suo aiuto.
Fortissima è anche l’impronta cinematografica…
Da giovane scrivevo per il magazine dell’Istituto Cinematografico La lanterna magica e la costruzione narrativa dei miei romanzi ricalca molto la tecnica della sceneggiatura tant’è che io mi trovo spesso a parlare di scena e non di brano. Allora succede che come se fossi un regista, nel momento in cui devo descrivere una scena particolare, sto molto attento a illuminarla per bene come se avessi il direttore della fotografia accanto a me, sto molto attento al montaggio si direbbe del cinema, quindi al ritmo e ai dialoghi, e ovviamente sto molto attento alla colonna sonora di quella scena che è un elemento filmico fondamentale. E dal momento che quando scrivo devo avere sempre musica in sottofondo per concentrarmi, accade spesso che il pezzo che sto ascoltando condizioni l’azione del personaggio protagonista di quella scena o comunque ne influenzi l’ambientazione.
L’incontro inaspettato con la sconosciuta K, così diversa da Q, ma che come lui si è ribellata al nome (e il destino?) imposto dai genitori, dà un’accelerazione al libro, che diventa un romanzo d’amore, travolgente e totalizzante come gli amori adolescenziali, raccontando anche della fragilità di ragazzi che facilmente scambiano la gelosia e la possessività per vero interesse. Quel che accade a K con Manfred per certi versi richiama ciò che le cronache nere ci raccontano. Quanto è importante “vedere” e rifiutare la violenza nei rapporti?
In realtà il tema che affrontiamo con questa domanda è stato oggetto di un mio cruccio, è stato un dubbio atroce che mi ha accompagnato durante la stesura perché l’argomento è così importante, anche e soprattutto in questo momento nel quale purtroppo le cronache ne sono piene, che è stato difficile confinarlo sullo sfondo, pur essendo io consapevole che si tratti di uno delle principali ferite del nostro tempo. Però ero chiamato a fare una scelta, nel senso che affrontare il tema della violenza “domestica” in maniera più approfondita avrebbe deviato tutta la costruzione della mia storia perché a me, in fin dei conti, interessava soltanto mettere Q alla prova con un test difficile, a proposito di quel percorso di crescita che lo porta dall’essere un adolescente problematico a diventare una persona matura. E per questo mi piace pensare che Q sia stato bravo a riconoscere la difficoltà di K e, seppure con i suoi metodi strampalati, a immaginare anche l’estremo sacrificio pur di salvare la ragazza, un po’ anche per rifarsi rispetto al non essere stato in grado di “salvare” sua madre qualche tempo prima.
Questo mi aiuta a dire che fiutare se un uomo tende a essere violento, soprattutto all’inizio della relazione nella quale è tutto ammesso e l’affetto giustifica ogni cosa, vedere quando è un continuo “vedrai che andrà meglio”, sia un aspetto determinante per evitare la catastrofe.
I romanzi di avventura e di amore possono stimolare i ragazzi coinvolgendoli emotivamente più di quanto non facciano poche ore di educazione affettiva calate dall’alto come quelle che prospetta il ministro Valditara?
Per carità, già alla definizione “educazione affettiva” mi vengono i brividi. Questa necessità banale di incasellare sempre ogni cosa per controllare le dinamiche fisiologiche dell’essere umano (mi viene in mente che è la stessa operazione cui assistiamo con le politiche migratorie), per me è devastante a maggior ragione quando vengono toccate alcune sfere intime come gli affetti, l’amore e i rapporti umani in genere. Ognuno di noi è tenuto a trovare la propria strada: certo, può essere aiutato in un percorso formativo che indirizzi al rispetto (a proposito di quello che dicevamo prima riguardo la violenza sulle donne), all’onestà, il civismo ecc, ma bisognerebbe che mi si spiegasse in cosa consiste l’educazione affettiva… I romanzi, leggere in generale, aprono la mente, ti fanno immedesimare in certe storie, ti aiutano a capire da dentro i problemi, ti aiutano a sviluppare una coscienza civile. Sostituiamo l’educazione affettiva con “l’educazione” a leggere, vedremo il salto miracoloso di qualità che farebbe la nostra collettività…
Un altro tema che attraversa in filigrana il romanzo è quello della giustizia e delle ferite che possono determinare errori giudiziari ma anche i processi sommari compiuti dall’opinione pubblica. Il caso della madre di Q mi ha ricordato per altri versi quello di Tortora. Una lettura azzardata?
Anche qui come per il tema della violenza domestica avevo bisogno di un escamotage narrativo, qualcosa che individuasse meglio il percorso adolescenziale accidentato di Q, motivo per cui non mi sono soffermato troppo sugli aspetti “processuali” della vicenda della madre che avrebbero portato fuori strada, ma mi interessava invece mettere l’occhio di bue sul rapporto tenero di madre e figlio, sul fatto che lei provasse a tenerlo lontano dai problemi, sul fatto che lo responsabilizzasse regalandogli il pesce rosso cui Q dovrà badare quando le non ci sarà più. Insomma volevo che venisse fuori il fatto che sua madre aiutasse il figlio a crescere, prima di lasciarlo al suo destino. Certo, se poi vogliamo concentrarci esclusivamente sull’episodio terribile che riguarda i genitori di Q e sul martirio processuale che ne consegue per la madre, senz’altro la storia di Tortora è paragonabile, anche perché nella coscienza collettiva quello è il primo esempio che ci viene sempre in mente quando pensiamo a un errore giudiziario.
Infine chiudiamo con una nota sportiva: il tennis. Durante il continuo palleggiare contro il muro storto di casa sgorga il flusso di coscienza di Q. Il muro è tutt’altro che un rifugio o una via di fuga, per lui. Che cosa rappresenta per lei come romanziere, che come Foster Wallace e Nabokov, è anche un tennista?
Per chi come me scrive romanzi di natura intimista, il riferimento autobiografico è sempre dietro l’angolo al punto che probabilmente questa storia è la più autobiografica delle quattro che ho scritto finora. In mezzo a mille riferimenti alla mia vita da adolescente, mi sono divertito in particolare a parlare di come ho vissuto il tennis da ragazzo, un vero e proprio rapporto di amore e odio, che ho provato a riportare nelle pagine della prima parte del libro. Il mio idolo era davvero John Mc Enroe essendo io mancino come lui, e come Q trascorrevo interi pomeriggi davanti a un muro a palleggiare per perfezionare la tecnica dei colpi. Quindi è venuto naturale utilizzare questo shock narrativo del record di palleggi per permettere al mio protagonista di raccontarci nel frattempo tutti i turbamenti della sua vita di adolescente.
Citando Nabokov che a chi gli domandava quale potesse essere il messaggio che voleva inviare con un suo romanzo rispondeva “io non faccio il postino”, il muro storto è in fondo la metafora della vita bastarda che non ti ritorna mai indietro la pallina in modo lineare, ed è anche per alcuni versi la muraglia di Pavese, “il muro d’orto che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia” nel “Meriggiare pallido e assorto”, e quindi rappresenta un po’ l’oppressione della solitudine, ma è anche il muro dei Pink Floyd in The Wall, ossia quella necessità di sfidare se stessi e andare oltre quel muro, di scavalcarlo per vedere cosa c’è dall’altra parte, di scalare con la speranza di atterrare “outside the wall”, aldilà del muro.
In tour: il 12 gennaio alle 19 Antonello Loreto, presenta “La libertà macchia il cappotto” nello spazio letterario Chiara nei libri di Vasto. E poi il 26 gennaio a Pescara, nella Galleria d’arte Pentagono (via Trento) per il bel finale dopo oltre 50 presentazioni del libro, in collaborazione con l’associazione Ponti erranti

Nella foto il lago di Carezza (Dolomiti occidentali, Bz)