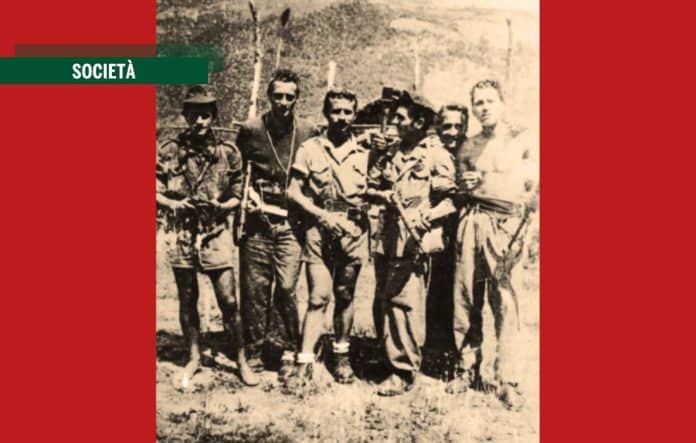L’ultima proposta del governo Meloni è creare una nuova figura professionale, “l’assistente materna”. Da quanto hanno riportato vari quotidiani, questa nuova figura conseguirà il titolo professionale dopo un corso di 9 mesi, volto a dare quelle conoscenze che per il governo basterebbero per occuparsi della donna e del bambino nel post partum.
Secondo questo progetto l’assistente materna servirebbe a dare consigli su come cambiare un pannolino, come allattare, su cosa fare quando il bambino non smette di piangere, ovvero quando la puerpera “può andare in tilt”. E ancora, su come muoversi “in modo corretto” nella relazione. Altra “mansione” dell’assistente materna è osservare se la donna mostri segni di disagio, con l’intento di prevenire la sindrome depressiva post partum. Questa nuova figura, secondo il governo Meloni, non necessita della laurea, in quanto è stata pensata per compensare o integrare quella rete familiare che, specie nelle grandi città, non porta più utili e pratici consigli alle neomamme.
Come pediatre, psicologhe e pedagogiste vorremmo approfondire il pensiero che si nasconde dietro questa proposta, che viene da un governo che millanta da mesi di voler dare sostegno alle famiglie, senza mai citare una volta la figura paterna; come se la donna fosse sempre sola, continuando a proporre, tra le righe, un tipo di rapporto madre-figlio esclusivo. Questa mentalità, da millenni, grava sui vissuti delle neomamme, che culturalmente sarebbero ancora coloro che danno l’identità al bambino.
Con l’assistente materna viene proposto un tipo di aiuto volto alla soddisfazione dei bisogni, e temiamo che le operatrici formate con un breve corso di formazione non siano in grado di cogliere le esigenze materne e del bambino, in un periodo estremamente delicato e vulnerabile della vita di entrambi.
Con questa nuova professione, il governo Meloni, pensa di prevenire la sindrome depressiva post partum, semplicemente aiutando la mamma a sentirsi meno stanca, evitandole di “andare in tilt” insegnandole a “fare le cose nel modo corretto”.
Dietro questo modo di vedere e proporre la relazione madre-figlio, c’è una totale negazione dell’identità dei due protagonisti della nascita: si nega la donna, relegandola al solo ruolo materno e si negano i vissuti del neonato. Viene proposto e promosso un servizio meramente assistenziale, che rischia di portare a percentuali ancora più elevate le patologie perinatali e, da quanto emerge dagli ultimi studi, anche i padri, alla nascita dei loro bambini, vengono coinvolti nell’esordio di patologie psichiche.
Per prevenire le patologie perinatali e riconoscere i primi segni di malessere, servono professionisti competenti, con conoscenze approfondite della mente dell’adulto e del bambino, che sappiano in che modo entrare in relazione e nella relazione madre-figlio, che forniscano gli strumenti adeguati a promuovere lo sviluppo psico-fisico del bambino, permettendogli la naturale propensione alle autonomie. Lavorare a questo livello, significa prevenire e promuovere la salute mentale, che è un diritto, fin dalla nascita, per il bambino e per i genitori.
Queste figure professionali sono già esistenti: l’ostetrica, il pediatra, la pedagogista familiare, la puericultrice, lo psicologo, l’educatore domiciliare, la terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE), che interviene nei casi di parti pretermine o di patologie che possono mettere a rischio lo sviluppo motorio del bambino. Sono tutte professioni che ruotano attorno a questo momento della vita della donna, del bambino e della famiglia, operando a vari livelli e con competenze diverse.
Figure che esistono da decenni e che con competenze diverse sostengono, prevengono e accompagnano la scoperta di una relazione del tutto nuova e che, in alcuni casi, possono sostenere la donna se dovesse sviluppare una depressione – talvolta silente – che necessariamente coinvolgerà anche la salute del bambino.
Una fondamentale azione preventiva viene svolta anche dalle educatrici degli asili nido, figure che a livello culturale e istituzionale non vengono ancora riconosciute nella loro professionalità, attribuendo ancora agli asili nido la sola funzione di custodia.
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che non possano essere messi sullo stesso piano l’accudimento fisico della madre e del bambino, con l’attenzione e l’osservazione di quelle dinamiche relazionali più profonde, che possono portare a sviluppare patologie depressive nei genitori, con il rischio di conseguenze anche serie sul bambino.
Ci domandiamo poi, se il governo del “merito”, abbia minimamente a cuore la salute mentale della donna, del bambino e del padre, o se abbia come obiettivo solo la necessità di fare propaganda per incentivare le nascite, in quanto molto preoccupato della carente natività della propria patria, nonostante arrivino da tutto il “globo terracqueo” minori e giovani che vengono definiti “di altre etnie”, pur appartenendo tutti alla specie umana.
Se la natalità si è ridotta, forse è necessario analizzare vari fattori: le coppie progettano la nascita di un figlio come realizzazione del loro rapporto, ma a volte questo progetto non è realizzabile per le difficoltà economiche e lavorative che gravano sul nostro Paese.
Il messaggio che il Governo Meloni vuole far passare è che il problema della ridotta natalità si possa risolvere grazie ad interventi di tipo assistenziale, di basso livello professionale, anziché analizzare i cambiamenti sociali e generazionali degli ultimi ottant’anni, in cui il ruolo della donna nella società è completamente cambiato. Ricordiamo, che le donne hanno progetti di studio e di realizzazione professionale, che allungano i tempi di “desiderio di maternità” e che si può essere donna realizzata anche senza mettere al mondo un figlio.
Proponiamo che si debba pensare ad una nuova cultura dell’identità della donna e del bambino. Il rispetto della nascita di un essere umano, si basa soprattutto nel riconoscere che il bambino ha una sua identità, distinta da quella materna e che va accudito perché in-potenza, e non per riempire vuoti “etnici”.
La relazione madre-figlio è caratterizzata da continui rapporti e separazioni che fanno crescere. C’è un prima e un dopo, prima c’è il feto, poi c’è il bambino. L’uno solo realtà biologica, l’altro, realtà biologica e realtà non materiale, sempre fuse, la mente è corpo e il corpo è mente.
Se la donna non realizza queste differenze, può perdere il rapporto profondo con il proprio bambino. Qui, può nascere la crisi.
Il bambino, sentendo l’assenza psichica della madre vive e si nutre di un rapporto deludente, che lo fa stare male. Non s’insegna come far smettere di piangere un bambino, si può far capire ad una madre che il bambino sente gli affetti che lo circondano e risponde con il linguaggio del corpo.
Fra le tante cose che in questo spazio non possiamo argomentare, è importante accennare che negli ultimi trent’anni c’è stata una idealizzazione dell’allattamento materno, come unica panacea per la realizzazione del benessere psico-fisico del bambino e della relazione madre-neonato. È passato il messaggio che ogni difficoltà e tensione del lattante, possono essere risolte attraverso la proposta del seno, oggetto parziale, che annulla in toto la realtà interna della madre.
È importante invece capire che la relazione affettiva tra madre e bambino, non passa attraverso il canale alimentare, ma attraverso tutte le percezioni-sensazioni che il bambino vive con il corpo, sentendo l’intenzionalità affettiva di chi lo accudisce. La capacità d’immaginare, grazie alla sensibilità del corpo, porta il bambino alla ricerca di una corrispondenza di sensibilità.
Questo, è il vero motivo per il quale cerca il seno, cerca l’umano. Se trova questa corrispondenza le percezioni-sensazioni si trasformano in memorie, pensieri per immagini.
Il pensiero evolutivo permette al neonato di aumentare la forza del corpo e della mente e, alla fine del primo anno di vita, potrà separarsi da chi gli ha permesso di sopravvivere, e acquisire così la propria identità unica e personale.
Riteniamo che sia difficile sperare che l’assistente materna, con un corso accelerato di 6-9 mesi, possa essere preparata a comunicare la complessità di certe dinamiche di rapporto che pretendono anni di studio e di preparazione, per evitare che s’istauri quel rapporto di identificazione con i propri genitori, che è l’unico che questa cultura ancora propone, negando la donna e il bambino.
Alla luce di questi principi teorici, troviamo fondamentale discostarci da un discorso assistenzialistico per continuare a proporre una cultura della prevenzione, promuovendo la salute mentale della donna, del bambino e del papà. Questo discorso, all’attuale governo piace poco, perché se veramente venisse attuata una prevenzione primaria e secondaria, le casse del Governo dovrebbero reclutare operatori qualificati, creando lavoro adeguatamente remunerato. Dietro la facciata di una proposta che accoglie le esigenze delle donne madri, in realtà si cela l’ennesimo finto tentativo di rispondere ad un’emergenza sociale, basti pensare ai bambini dimenticati in auto o al caso di Alessia Pifferi, la madre che era convinta che lasciare un biberon di latte al proprio figlio di pochi mesi, fosse sufficiente per tenerlo in vita per giorni, nonostante la sua assenza.
Riteniamo, quindi, che sia necessaria la tutela dei professionisti già esistenti, appartenenti al mondo sanitario e pedagogico, che vadano incrementati i consultori familiari e che il mondo della perinatalità debba essere lasciato ai professionisti titolari di laurea, competenti per anni di studio e di tirocinio, al fine di una maggiore tutela del bambino e della genitorialità.
*
Le autrici: Silva Stella è pediatra e psicologo clinico
M. R. Serena Vinci è pedagogista famigliare
A sostegno di tali considerazioni, di seguito riportiamo le firme dei professionisti del settore perinatalità e area infanzia:
Dott.ssa Bernardini Arianna, Psicologa e Psicoterapeuta
Dott.ssa Biagi Daniela, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta
Dott.ssa Boschi Giada, Educatrice di Asilo Nido
Dott.ssa Calesini Irene, Medico Psichiatra-Psicologo Clinico- Psicoterapeuta
Dott.ssa Forti Federica, Psicologa dello Sviluppo-Psicoterapeuta
Dott.ssa Giordano Francesca, Medico- Psicologo Clinico-Psicoterapeuta
Dott.ssa Lauretti Serena, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE)
Dott.ssa Soccorsi Giulia, Logopedista
Dott.ssa Tamburrelli Melissa, Educatrice di Asilo Nido
Dott.ssa Terenzi Gabriella, Psicologo Clinico-Psicoterapeuta
Dott.ssa Terenzi Irene, Ostetrica-Docente
Dott.ssa Zand Rosette, Medico-Specialista in Puericultura-Pediatra di libera scelta
Foto di Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7955863