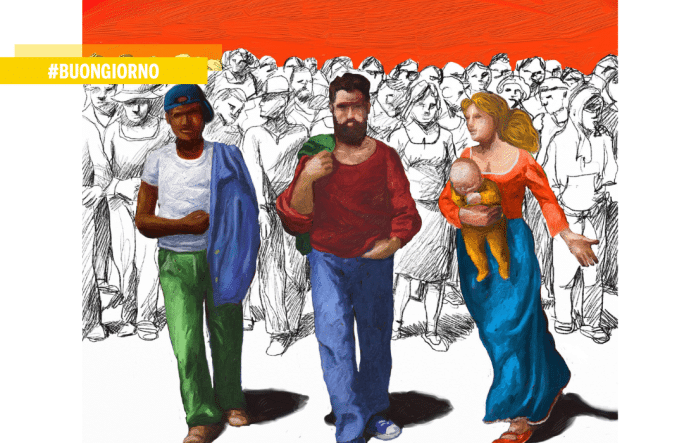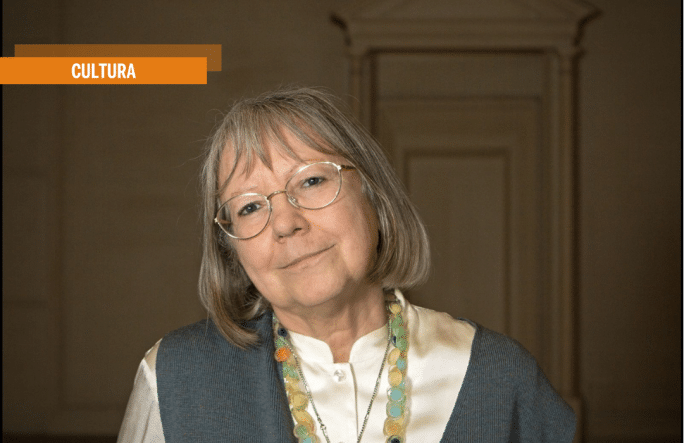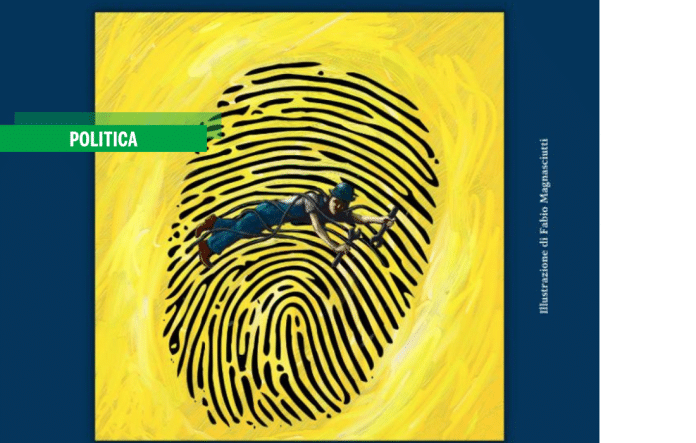Quattordici mesi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca, il cosiddetto ordine internazionale appare quanto mai fluido, pur in presenza dei nuovi “blocchi” che vanno configurandosi. Una nuova “cortina di ferro” è apparsa e si allunga lungo il confine occidentale della Russia, ora che la Nato ha trovato il modo di allargarsi e ricompattarsi. La fortezza dell’Occidente, tuttavia, sembra più isolata, a “difesa della democrazia” contro il resto del mondo che non pare più guardare ad essa come al faro del progresso. Da più parti, si direbbe, si comincia a pensare che forse si può anche fare a meno dell’Occidente e della magna pars in esso, gli Stati Uniti.
Si era partiti con l’idea di infliggere alla Russia sanzioni economiche durissime, dichiarandole una vera e propria guerra economica, per «metterla in ginocchio». Come affermava nel giugno 2022 uno dei generali di quella guerra, Mario Draghi: «Le sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflitto all’economia russa sarà pari a 8.5 punti del Pil. Il tempo ha rivelato e sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci». Quelle previsioni, però, sono state smentite e l’economia russa non è crollata. Perché? Questa domanda è stata espunta dal dibattito pubblico in Italia. Si voleva fare credere che la Russia non fosse che «una stazione di rifornimento di gas con armi nucleari» ma era propaganda, animata per lo più da una distorta informazione sullo stato attuale dell’economia russa e mondiale.
Già da anni, peraltro, nei nostri rapporti con colleghi russi avevamo avvertito lo scarto tra la narrazione prevalente in Occidente sulle cose russe e ciò che vi accade in realtà. Gli anni Novanta erano stati durissimi per i russi, travolti da una crisi economica pari a quella da noi vissuta dopo il 1929. Il crollo dell’Urss, l’apertura al “mercato”, la transizione verso un’economia capitalistica avevano provocato sconvolgimenti. Nel passaggio dal sistema socialista a quello capitalistico era stata adottata quella che è stata poi nota come “terapia d’urto”: selvaggi tagli alla spesa pubblica, riduzione delle dimensioni e dei salari dell’esercito e della polizia, taglio di quasi tutti i sussidi all’industria, privatizzazione delle aziende (per lo più pubbliche), con eventuali chiusure o ristrutturazioni, per rendere così più efficiente il sistema produttivo per poter competere sui mercati. Per liberalizzare l’economia, il governo aveva eliminato le barriere al commercio internazionale, legalizzato la creazione di imprese private e il loro commercio e smantellato i controlli sui prezzi su circa il 90% dei beni di consumo. In teoria, tutte queste rapide riforme avrebbero inflitto al popolo un dolore necessario ma temporaneo e, si sperava, avrebbe generato un’economia più efficiente.
In pratica, l’onere per i cittadini era stato catastrofico. Penuria di beni, disoccupazione, chiusura di grandi e piccole aziende, un rodato sistema di sicurezza sociale smantellato. L’ingente riduzione dell’apparato di sicurezza militare e di polizia aveva poi dato origine a un’ondata di criminalità e violenza, tale da portare la Russia ad avere un tasso di omicidi simile al Messico e alla Colombia. Industrie gigantesche, che non ricevevano più sussidi, iniziarono a licenziare in massa o a non pagare le tasse. La disoccupazione, un tempo vicina allo zero per cento, anche se a causa di inefficienti mandati governativi, salì a oltre il 15%, senza considerare coloro che non venivano pagati o costretti a lavorare a tempo parziale. Passare da un’economia centralizzata, con prezzi amministrati, privatizzazioni farlocche aggiudicate ai dignitari del precedente regime, il mercato dei beni di largo consumo gettato in mano alla giungla competitiva, senza protezioni, significò, per molti, indigenza, mancanza di beni primari, abbandono. La gente comune, come sempre si arrangiò: dal coltivare patate sul balcone di casa a prestarsi come tassista, per arrotondare lo stipendio. Crollarono i servizi pubblici, aumentò la mortalità. Ma ciò che ha veramente spaventato le prospettive economiche a lungo termine della Russia è stato il completo fallimento delle privatizzazioni di beni di proprietà dello Stato con la nascita degli “oligarchi”.
L’assestamento durò un decennio almeno e, una volta imbarcata la via capitalistica, il recupero fu relativamente veloce. Stili di vita “occidentali” si accompagnarono alla crescita dei ceti medi e del reddito. Rispetto a quella situazione ci sono stati miglioramenti enormi e una nuova stabilità economica e sociale è alla base del successo politico di Putin. Tuttavia, l’economia russa non è cambiata granché: grande produttrice di materie prime energetiche e agricole, tale è rimasta. Un’economia che esporta commodities e un po’ di manifattura e importa tecnologie e beni di consumo. Con l’Europa, certo, ma anche con il resto del mondo. Nel grande gioco della globalizzazione la Russia aveva guadagnato un suo posto, rimanendo però un’economia di dimensioni modeste.
Poi, è arrivata la guerra in Ucraina, con il “voltafaccia” risentito degli europei, spinti dagli americani. Dopo anni in cui si era intessuta la rete dell’interscambio – gasdotti, importazione di petrolio e grano e fertilizzanti in cambio di venture capital, tecnologie e prodotti del Made in Europe – gli europei hanno voluto tagliare i ponti, pensando, sì, di soffrire un po’ (il gas era molto economico) ma anche di fare un bel dispetto alla Russia. La banca centrale russa ha subito il congelamento di oltre il 60% delle sue riserve; la Russia è stata tagliata fuori dal sistema Swift (che veicola le transazioni internazionali). Questo doveva essere un colpo mortale diretto al cuore dell’economia russa.
Il consenso generale espresso dagli esperti, dagli economisti e dai media, preannunciava l’imminente catastrofe economica della Russia. Le previsioni andavano dal completo collasso del sistema finanziario russo all’iperinflazione, a una catastrofica contrazione del 15% del Pil entro la fine dell’anno. La previsione era che la conseguente diminuzione del credito, della domanda e dell’accesso alle importazioni critiche avrebbe costretto le industrie a chiudere la produzione, provocando ulteriore inflazione e disoccupazione. Le entrate statali si sarebbero ridotte, costringendo a una contrazione della spesa, che avrebbe portato ad un ulteriore declino dell’attività economica. Molte aziende e holding internazionali hanno lasciato il Paese (ma non tutte, come mostrano il caso dei gruppi bancari Reiffesen e Unicredit): McDonalds, la cui apertura 32 anni fa a Mosca aveva simboleggiato quanto l’ex Unione Sovietica stava cambiando, ha lasciato la Russia nel 2022 segnando una nuova era di rapidi cambiamenti per l’economia russa.
Il risultato di questa guerra economica sarebbe stato il crollo dell’economia russa, che avrebbe reso Putin incapace di finanziare di finanziare una guerra e di far fronte a disordini sociali di massa, che a loro volta avrebbero portato a una ritirata dall’Ucraina. Nella figura sotto l’effetto delle sanzioni Ue contro Mosca stilato dalla Commissione europea a 5 mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, secondo cui le misure prese da Bruxelles «stanno colpendo duramente e profondamente la Russia».
 Diminuzione del Pil russo di oltre il 10%; calo del 90% della produzione automobilistica; più di mille aziende internazionali via dal territorio russo; stop all’export di tecnologie avanzate europee, settore nel quale la dipendenza di Mosca è al 45%
Diminuzione del Pil russo di oltre il 10%; calo del 90% della produzione automobilistica; più di mille aziende internazionali via dal territorio russo; stop all’export di tecnologie avanzate europee, settore nel quale la dipendenza di Mosca è al 45%
Eppure, un anno dopo, l’economia russa, comunque la si pensi, sembra nei fatti, al momento, aver superato fosche previsioni. Alla fine del 2022, il Pil si è ridotto di poco, l’inflazione è aumentata ma molto meno del previsto, e la disoccupazione è ai minimi storici, mentre le casseforti dello Stato si sono riempite di denaro.
La Russia ha utilizzato i guadagni delle sue vendite di gas e petrolio per finanziare la campagna militare (le vendite di gas e petrolio sono infatti proseguite, nonostante le sanzioni). Ma, soprattutto ha iniziato a diversificare pesantemente il suo export, trovando in molti Paesi emergenti e non un acquirente pronto a sostituirsi all’Occidente.
L’invasione russa dell’Ucraina rappresenta una palese e inaccettabile violazione del diritto internazionale e la maggior parte dei Paesi del mondo, oltre 143 Paesi, ha votato a favore della risoluzione Onu che condanna l’invasione. Al contempo Paesi che rappresentano l’85% della popolazione mondiale non hanno imposto sanzioni alla Russia. Né gli Stati Uniti e né gli altri Paesi Nato hanno riflettuto sul perché di questa situazione. Chi, pur condannando l’invasione, non ha sottoscritto le sanzioni ha voluto inviare un segnale che la questione non è così semplice e che la Russia potrebbe aver voluto difendersi dall’espansione della Nato. Questa situazione ha così favorito un cambiamento nei partner della Russia: ciò che ha messo in moto è, di fatto, un ridisegno delle relazioni economiche internazionali che sta portando ad un nuovo vero e proprio “blocco” dato dai Brics con altri Paesi emergenti al seguito. Certo, la Russia soffrirà nel medio periodo del mancato scambio di tecnologie ed expertise. Ma la Cina, l’India e gli altri hanno già un potenziale notevole da offrire (la Cina è il Paese al mondo con il più alto tasso di investimenti in ricerca e sviluppo sul Pil).
Gli occidentali – che denunciano l’inaccettabile invasione russa e la violazione della democrazia – si stanno ritrovando isolati come non avrebbero immaginato anche solo due anni fa. La leadership economica dell’Occidente è in discussione, come più difficili si stanno facendo le relazioni economiche e politiche con tutti i Paesi emergenti.
I leader dei Brics hanno proposto un allargamento del “club” a Paesi come Arabia Saudita, Iran, Kazakhstan, Egitto, Algeria, Nigeria, Senegal, Argentina e Messico. Già oggi il loro Pil supera quello dei G7 e si prevede che da qui al 2050 i cinque “grandi” contribuiranno a più di metà del Pil globale. Sono Paesi molto diversi tra loro, alcuni dichiaratamente e “orgogliosamente” democratici (come gli indiani, fieri di essere «la più grande democrazia del mondo»). Ma non vedono la corrente contrapposizione tra Nato e Russia sulla questione ucraina come un confronto tra “democrazia” e “autocrazia”, e sono parsi preferire l’opzione diplomatica dell’astensione a quella dello schieramento.
L’economia, per molti, sembra contare più che non la violazione di principi sui quali nessuno ha la coscienza immacolata. L’Occidente, peraltro, sta continuando a fare i conti sulle prospettive future come se la sua supremazia tecnologica e militare fosse per sempre. La globalizzazione ha reso ricco il mondo dei Paesi emergenti e ora né il “friendly shoring” (fare affare solo con i Paesi amici) ventilato dagli occidentali né le sanzioni – di cui è colpito anche chi fa affari con la Russia – sembrano spaventarli. Se gli Occidentali ora spavaldamente affermano che una nuova guerra fredda è iniziata e siamo qui per combatterla, gli emergenti paiono dirsi poco spaventati, ora convinti che, forse, il giorno è arrivato in cui potranno mettere l’Occidente all’angolo.
Gli autori: Pier Giorgio Ardeni è professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo all’Università di Bologna. Francesco Sylos Labini, fisico, è dirigente di ricerca presso il Centro Ricerche E. Fermi di Roma, cofondatore e redattore di Roars