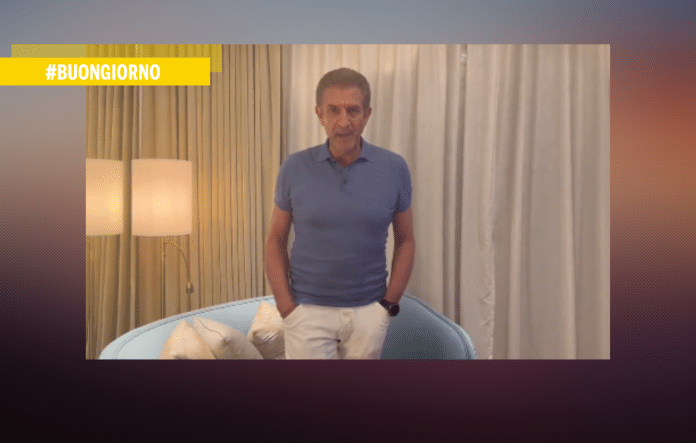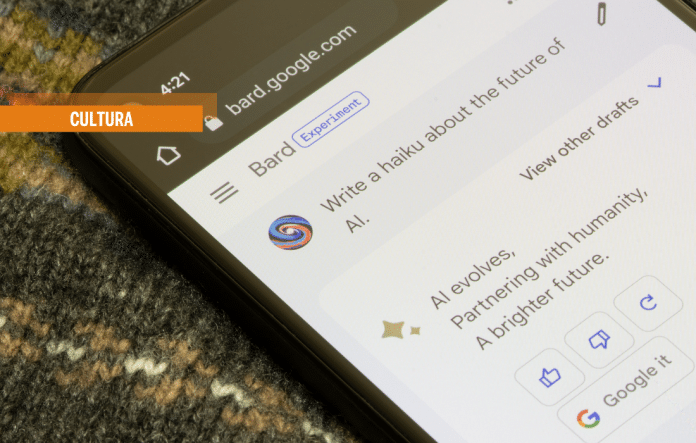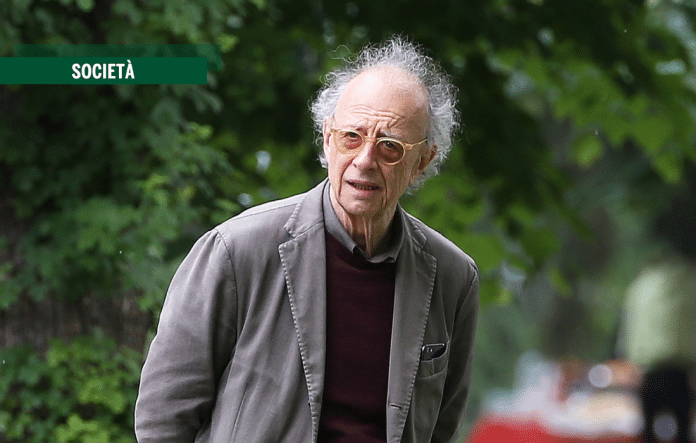L’attesa per i contenuti di una Biennale di Venezia è sempre direttamente proporzionale alla curiosità per il direttore scelto. Guardando alla storia personale della direttrice della Biennale architettura 2023, Lesley Lokko sembra incarnare una figura impegnata di “architetto attivista”: da anni sta combattendo per il riscatto dell’Africa dal punto di vista culturale e, nello specifico, progettuale. Tanto più perché ha una formazione iniziale da sociologa ed è anche affermata scrittrice di romanzi. L’abbiamo incontrata per conoscere più da vicino il suo percorso, la sua visione e per parlare della diciottesima Mostra internazionale di architettura che si svolgerà dal 20 maggio al 26 novembre, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera.
Lesley Lokko, cos’è cambiato in Africa dal suo primo articolo “When a Door is Not a Door”(Nka journal, 1995) dove affrontava il dominio e la violenza degli standard di bellezza bianchi?
Ciò che è cambiato è l’interesse fuori dall’Africa nell’ascoltare una storia diversa, una differente narrazione del continente. Quanto a me, non mi sono mai pensata come una attivista orientata all’azione. Gran parte del mio pensiero si è sviluppato in tempi lunghi e in modo piuttosto solitario. Direi che il mio pensiero ha avuto uno sviluppo soprattutto interiore. La mia primissima conferenza pubblica era intitolata “Argument from silence”. In archeologia si usa questa espressione per dire che se si cerca l’evidenza che in una certa zona sia successo qualcosa e non la si trova, non significa che lì non sia successo niente. Dunque, non userei la parola riscatto perché implica il fatto che qualcosa sia andato perduto e lo si voglia recuperare, mentre per me quel qualcosa c’è sempre stato e c’è.
Penso che lei e Francis Kéré (primo architetto africano ad ottenere il Pritzker Prize) abbiate molto in comune. Burkinabé e tedesco, Kéré sta rivoluzionando canoni estetici e modalità di realizzazione dell’architettura in Africa. Lei dopo anni di permanenza all’estero, sta facendo la stessa cosa sul piano didattico con la recente fondazione ad Accra di una propria scuola di architettura, l’African Futures Institute (Afi). Pensa che tutto questo possa fare scuola? Quali sono gli ostacoli più grandi?
L’Africa è il continente più giovane del mondo e la nostra età media è sotto i vent’anni. Dunque la nostra relazione con l’istruzione è molto diversa dai contesti in cui l’età media è matura e anziana. Per la stragrande maggioranza degli africani il futuro è davanti a sé. È diverso in Europa e negli Stati Uniti. L’istruzione gioca un ruolo fondamentale nell’agevolare le ambizioni della stragrande maggioranza della popolazione; senza, non puoi letteralmente andare avanti, non puoi cambiare il tuo contesto di vita. L’istruzione è la chiave. Abbiamo anche il minor numero di scuole di architettura di qualsiasi continente. Credo che ci siano qualcosa come 75 scuole accreditate per una popolazione di quasi un miliardo di persone. Per fare un paragone, il Regno Unito ha una popolazione di 63 milioni, ci sono 57mila architetti e qualcosa come 33 scuole. Da noi c’è un enorme deficit. Se vogliamo affrontare il cambiamento climatico e la giustizia sociale, i governi, la mobilità, le infrastrutture, l’unico posto dove possiamo farlo è a scuola. Penso che l’aver lasciato l’Africa per un lungo periodo di tempo, anche per la mia formazione altrove, mi abbia permesso di vedere il mio contesto di origine in modo diverso; ed è quella capacità di guardare ciò che conosci con occhi diversi che andrebbe coltivata a scuola. Ed è quello che fanno Francis Kéré, David Adjaye, Mariam Kamara ed altri. Sono tutti partiti e sono tornati. Io vorrei tanto creare una scuola che non obblighi a lasciare il continente per progredire.
A proposito di “radici”, Wangechi Mutu, artista che vive tra Nairobi e New York, dice che essere radicati in tanti posti diversi simultaneamente potenzia moltissimo il lavoro. Per lei è stato così?
Sì, al cento per cento. Sa, penso che da bambina spostarmi tra il Ghana e la Scozia (luoghi d’origine dei miei genitori) mi abbia insegnato molto presto, quasi prima che potessi parlare, che c’è di più al mondo di ciò che hai sotto il naso. Avere due o tre contesti diversi ti mette in una posizione privilegiata perché puoi confrontarli tra loro; così comprendi a pelle che il mondo è un posto complesso. Per sentirmi davvero radicata in Europa ho impiegato molto tempo durante il quale, perlopiù, mi sono sentita una straniera. Forse solo negli ultimi dieci, quindici anni ho cominciato a sentirmi come qualcuno che ha il diritto di essere lì.
In The Well-Laid table l’architetto/educatore Alvin Boyarsky propone una scuola di architettura che tratta i temi della diversità e della divergenza “frontalmente”. Pensa che la Biennale possa rispecchiarne lo spirito?
The Well-Laid table è uno dei testi più interessanti sull’educazione in campo architettonico e, per molti versi, tutto ciò che ho fatto deriva dal modello di Boyarsky. Non posso anticipare molto sulla mostra, ma posso dire che lo stesso approccio ha guidato la selezione dei partecipanti. Mi incuriosiva scoprire se essi, provenienti da contesti molto diversi, potessero avere approcci simili al tema che proponiamo. In altre parole, non è il colore della pelle della persona, non è la sua discendenza, non è la sua etnìa, non è la sua lingua che determinano se il lavoro avrà risonanza, è il suo approccio.
Ha parlato della mostra come di una sorta di “bottega artigiana”. L’artigiano per definizione non è solo creatore di forme ma anche “riparatore” esperto di quelle che il tempo ha danneggiato. Quanto conta nel suo “laboratorio del futuro”?
Ribadisco, la mostra non ha un intento “riparativo”. Quando si presenta l’Africa fuori dall’Africa, in qualche modo ci si aspetta che si debba ricostruire qualcosa. Quello che faremo, invece, è esplorare questioni che, per molto tempo, sono state al di fuori della narrazione. E che possono essere catalizzatori per pensare al mondo in modo diverso. Vogliamo presentarci in mostra come partecipanti alla pari, non con l’onere di riparare danni altrui.
Preferisce, dunque, immaginare nuove strade e lasciarsi alle spalle il presente?
Non esattamente. Voglio rendere esplicito il motivo per cui qualcosa è andato male. Parlare di decarbonizzazione e di decolonizzazione significa anche che dobbiamo comprenderne il contesto. Ma provare a sistemare qualcosa nello stesso momento in cui si sta cercando di esplorarla spesso può far collassare il progetto, poiché è troppo oneroso. In sostanza, questa mostra è uno spazio dove si possono esplorare molti temi senza la responsabilità di dover fornire una risposta ma, allo stesso tempo, con la consapevolezza che l’esplorazione stessa è già una sorta di risposta. Il passato è super importante, ma non lo penso come l’unica chiave per pensare al futuro.
Secondo Octavio Paz assistiamo al tramonto del futuro a favore dell’oggi. La pandemia ci ha obbligati a concentrarsi sull’hic et nunc, tralasciando progetti di lungo corso. L’Africa tuttavia, con la sua attuale effervescenza creativa (vedi Left di ottobre 2022 e la mostra Africa. Big Change Big Chance alla Triennale nel 2014), sembra contraddire tutto questo. Che ne pensa?
Una decina di anni fa durante una conferenza a Monaco un architetto viennese parlò di un progetto in cui aveva messo insieme, nello stesso edificio, studenti e senzatetto. Mentre i primi sono persone che percepiscono il futuro davanti a loro, i secondi sentono che non c’è futuro. Sono due gruppi che hanno una diversa comprensione di ciò che verrà. Analogamente l’Africa è giovane in termini di età ma contemporaneamente è il continente più antico del mondo. Tutto ciò ci offre un approccio diverso al tempo. Noi pensiamo sia lungo il tempo antropologico che nell’immediato. Poiché il presente in Africa è così pieno di conflitti, il futuro è davvero pieno di speranza. Movimenti come l’Afrofuturismo nella letteratura e nel cinema sono estremamente importanti perché permettono di prendere l’energia dell’ambizione e di convogliarla da qualche parte. L’Africa riguarda il futuro diversamente da tante altre parti del mondo in cui si è persa fiducia.
In molti luoghi dell’Africa c’è l’impronta della Cina e dei suoi metodi di urbanizzazione brutale (eclatanti a Nova Cidade de Kilamba). Ma in Cina si stanno anche valorizzando i territori naturali. Come evitare tutti quegli errori che emergono guardando l’attuale sviluppo delle metropoli contemporanee?
Buona domanda. Credo di poter rispondere con una parola che è “leadership”: ciò che ci manca davvero in Africa. Alcune di queste domande di grande portata riguardo all’urbanizzazione, alle risorse, ai governi, alla mobilità, possono trovare risposta solo a livello di “leadership”. E, in un certo senso, il compito dell’educatore è quello di promuoverla. Il livello su cui operano Cina, Francia, Stati Uniti, Russia, è impossibile da gestire singolarmente.
«L’architettura inizia e finisce con Mies van der Rohe», lei ha dichiarato. È sempre dello stesso parere? Cosa pensa dell’attuale panorama architettonico internazionale, ci sono approcci che ritiene più validi di altri?
È un po’ come se qualcuno mi chiedesse quali sono i miei scrittori preferiti… C’è qualcosa di misterioso e magico che ti fa innamorare di un certo scrittore; dipende dal modo con cui usa il linguaggio, dall’argomento, dal contesto. Quando ho messo piede per la prima volta in un edificio di Mies van der Rohe mi sono innamorata del suo linguaggio, sia del suo spazio che della sua forma. Se sono ancora di questa opinione? Direi di sì, è istintivo, è misterioso. Quello che ho imparato ad amare, forse negli ultimi dieci/quindici anni, è ciò che succede quando si prende un linguaggio da cui si è attratti e lo si ricrea in un altro contesto con materiali diversi, con vincoli diversi; quell’atto di tradurre qualcosa “che ti parla” è molto eccitante. Il mio talento, più che nel creare forme nuove, sta proprio in questo: nel riuscire a dialogare con spazi e materiali che mi suscitano emozioni. Quando insegno mi piace fornire strumenti agli studenti e poi stare a guardare mentre li trasformano in autonomia. Quindi posso dire a qualcuno: “Guarda il Padiglione di Barcellona, ora immaginalo nel contesto del Kongo o Kinshasa, cosa succede lì, cosa succede a quel linguaggio?”. Non voglio dire che la storia dell’architettura sia sbagliata, c’è un’immensa bellezza nella storia ufficiale, solo che non credo sia completa.
L’Italia, purtroppo, è piena di periferie degradate dove bruttezza ed ingiustizia sociale sono la regola. Il tema delle politiche verdi nell’approccio al progetto può rischiare di eludere problematiche come quella della vita nelle periferie urbane, della mancanza di alloggi economici di qualità?
In un determinato contesto, certificare che un edificio è verde non dice nulla sulla qualità della vita o sull’accesso alle risorse del 99,99% delle persone che usano l’edificio. È solo una parte della storia. Io sono a favore di qualsiasi approccio che abbracci la complessità. L’approccio scientifico alle politiche verdi spesso cerca di semplificare, in modo da non dover pensare alle implicazioni culturali e sociali. Molti architetti oggi pensano di risolvere i problemi di inquinamento rendendo “verdi” gli edifici e tralasciando problematiche più importanti. Si crede che l’approccio tecnologico fornisca di per sé la soluzione. La formazione di un architetto dovrebbe essere volta ad insegnarti a pensare in modo molto approfondito, ciò che è importante è la relazione tra le cose.
Se pensa al futuro di Venezia, cosa le viene in mente?
Quando sono qui ho la sensazione che qualcosa stia decadendo molto velocemente ma allo stesso tempo ci si innamora di tutto questo. Essere qui significa essere avvolti da una sorta di meraviglia… Contemporaneamente però c’è la chiara consapevolezza che la popolazione si sta riducendo, c’è il livello dell’acqua che sale o scende, il contesto sembra precario. La città ha 50mila residenti ma ha trenta milioni di turisti ogni anno, anche questo rapporto tra chi vive qui e chi la visita colpisce. Venezia è una città con due estremi molto singolari: un passato che è davvero presente. Il passato è qui, è in ogni cosa, è uno stile di vita, ma allo stesso tempo la sensazione è che questo stile di vita sia piuttosto fragile. Non so cosa significhi tutto questo per il futuro.
L’autrice: Patrizia Mello è architetto e saggista. Il suo ultimo libro s’intitola Twentieth-Century Architecture and Modernity ed è pubblicato da Oro editions
__________
Una adunata di “agenti del cambiamento” in Laguna
Si apre il 20 maggio la 18. Mostra Internazionale di architettura Il laboratorio del futuro, curata dalla docente, scrittrice e architetto Lesley Lokko che fa emergere tutta la ricchezza di prospettive che provengono dall’Africa, un luogo a tutti gli effetti fuori dal canone ufficiale dell’architettura che per Lokko è dunque «incompleta».
Una mostra dove prenderanno parola soprattutto le minoranze di approcci al tema progettuale, chi lavora come può/per quello che può dietro le quinte della scena ufficiale internazionale e che proverà a portare le proprie esperienze, i propri singolari approcci (accuratamente selezionati da Lokko) per testarne una possibile efficacia in relazione a grandi tematiche della contemporaneità come la decarbonizzazione e la decolonizzazione.
In definitiva “il piccolo” che agisce “sul grande” e lo sfoltisce di domande fino a ridimensionarne la negatività (si spera). Ecco il capovolgimento attuato da Lokko che porta in scena la “diversità” facendone, a tutti gli effetti, un punto di forza su cui impegnare le nostre energie future, dove posare nuovamente lo sguardo con curiosità perché è nel senso di “autenticità” culturale e di “libertà” implicita che potranno ancora essere rinvenute tracce di “futuro”.
«Ogni autentica creazione è un dono per il futuro» (Camus) è, infatti, il punto di partenza di Lokko come ha avuto modo di dire anche durante la conferenza stampa a Venezia.
Ciascuno potrà prendere la parola in un grande laboratorio fatto di practitioners (e non semplici progettisti), tutti egualmente impegnati nel ruolo di «agenti del cambiamento»: pensatori-artigiani, architetti-poeti, artisti-progettisti, architetti-inventori, in un mix fecondo di interscambi disciplinari (che già di per sé servono a rompere pregiudizi e punti di vista acquisiti in materia di architettura) portando il proprio bagaglio di cultura extra, in grado di immaginare il futuro attraverso la lente di ingrandimento di un’analisi tanto sfaccettata quanto ricca di nuovi illuminanti filtri interpretativi. Tutto si baserà su questo, senza la pretesa di soluzioni definitive che hanno però il desiderio di presentarsi, in ultima analisi, come “L’archivio del futuro”, sintesi forse di una profondità di pensiero che vuole sforare il futuro per rimetterne in gioco sedimentazioni e valori sulla scia di una curatrice come Lokko, ricercatrice solitaria e ora prima portatrice di un vento nuovo a Venezia, con l’obiettivo di ampliare la discussione sui temi progettuali a partire dall’Africa e dalla sua attuale eccentricità di vedute come abbiamo cercato di raccontare in queste pagine e come Left ha fatto in passato anche intervistando l’architetto Kéré. (Patrizia Mello)