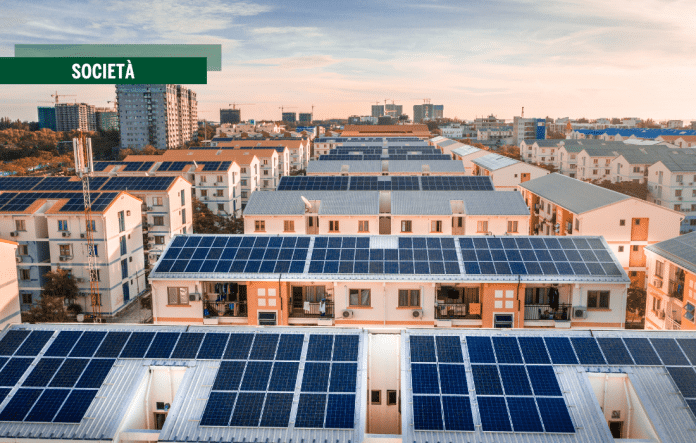L’ 8 febbraio 2022 è stata approvata la modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introduce all’art. 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, «anche nell’interesse delle future generazioni» e stabilisce che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali; e all’art.41 introduce ulteriori limiti alla libertà di iniziativa economica privata, che è sì libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’ambiente e la salute, e al secondo comma, che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e (aggiunge) ambientali».
Una rivoluzione, hanno detto in tanti, anche se ancora una volta una rivoluzione sulla Carta, una «rivoluzione promessa, in cambio di una rivoluzione mancata», per usare le parole di Piero Calamandrei negli anni Cinquanta del Novecento, con cui definì la Costituzione italiana, per molti versi ancora non attuata e, nel corso degli ultimi trent’anni, più volte ignorata dalle leggi ordinarie. Questa modifica ha preoccupato molti illustri giuristi, conservatori e progressisti, che hanno sollevato diverse perplessità, ma è stata un atto dovuto, indubbiamente delicato, pericoloso anche, ma, necessario, che ci ha permesso di fare uno scatto culturale importante, dalla visione antropocentrica, verso la visione biocentrica, ponendo tra le tutele costituzionali l’ambiente nella sua interezza, ossia la sfera di circa quattro chilometri che circonda la terra, la biosfera, indispensabile alla vita su questo pianeta. L’uomo non è più sopra tutte le cose, ma è dentro, non è una parte che si contrappone, ma è una parte in relazione con il tutto. Se questo concetto è apparso a qualcuno «estraneo alla nostra cultura occidentale» è perché si fa confusione, facendo coincidere la nostra cultura con l’ideologia liberale e liberista, dei vari Friedman e dei Mill, che ha anteposto ai beni collettivi il diritto di proprietà privatistica; la stessa modifica dell’articolo 41 è il necessario rafforzamento del concetto di bilanciamento tra diritti, serve a “conciliare” al meglio quella famosa dicotomia tra beni comuni e libera impresa che ci perseguita. È proprio il fallimento di quel modello socioeconomico meccanicistico che ci detta una urgenza di cambiamento; dobbiamo finalmente prendere atto del paradigma della complessità e approdare ad una idea di ecologismo profondo.
Cosa cambia, timori, obiezioni, aspettative
Questa riforma è stata vista da molti come una forzatura culturale, verso il biocentrismo delle nuove Costituzioni latino-americane che guardano naturalmente all’uomo come elemento immerso nel tutto, parte della natura. La verità è che la nostra Costituzione è nata nel dopoguerra, durante la ricostruzione e a seguito delle distruzioni di paesaggio e di beni culturali; le giovani Costituzioni del sud America nascono oggi, nel pieno della spinta globale ecologista mossa delle drammatiche conseguenze del rapporto di contrapposizione, dominio e sfruttamento, dell’uomo sulla natura; esso va necessariamente superato: riconoscendo alla natura personalità giuridica che le permetta di difendersi.
D’altro canto non siamo i soli in Occidente ad introdurre l’ambiente nella carta fondamentale, anzi, siamo in ritardo, sia rispetto alle costituzioni di Spagna, Portogallo e Grecia della fine degli anni 70, sia rispetto alle Costituzioni riformate della Germania (1996), della Francia (la Carta dell’ambiente del 2005). Altri temono che questa riforma sia una riforma neoliberista finalizzata a comporre uno sbilanciamento di fatto tra il bene paesaggio e l’ambiente, che sia un escamotage dell’industria energetica per attuare la tanto discussa transizione energetica, senza i vincoli posti dalle esigenze della tutela del paesaggio e dei beni culturali, un uso strumentale e allo scopo orientato del novello diritto ambientale. C’è da dire che la riforma nasce in un contesto politico che faceva, come fa, ben temere, chi tiene e lavora per la conservazione dei valori paesaggistici e culturali del nostro Paese. In una maggioranza delle “grandi intese” che ha determinato, per dirne una, un cambio emblematico della denominazione del “ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” nel “ministero della Transizione ecologica”, in cui si sono perse parole importanti come “ambiente”, “tutela”, “territorio” e “mare”, che indicano beni materiali sostanziali, e obblighi di conservazione, a favore di una più performante mission, per una azione indeterminata, e non qualificata, di transizione. Preoccupa anche il precedente che si è determinato andando a toccare la Costituzione nei suoi principi fondanti. È una preoccupazione certamente lecita che si contrappone però alla necessità attuale, non più rinviabile, del riconoscimento della soggettività giuridica della natura.
Una riforma necessaria
La Costituzione non conteneva disposizioni espressamente finalizzate a proteggere l’ambiente, fino alla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ciononostante, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale nel corso degli anni, hanno saputo dare fondamento costituzionale alle politiche di tutela ambientale tramite il ricorso ad altre disposizioni.
Già negli anni Sessanta e Settanta con l’emersione delle tematiche ambientali nel dibattito generale, si va via via diffondendo una concezione di paesaggio sempre più estensiva; nel 1976, la Corte costituzionale con la sentenza 106 sancisce il passaggio da un concetto che «ha di mira unicamente i valori paesistici» estranei alla «natura in quanto tale, e quindi la fauna e la stessa flora» ad un concetto di paesaggio fortemente slegato dalla sua dimensione meramente estetica, che coincide con la «forma del territorio e dell’ambiente», includendo di fatto anche la tutela ambientale. Eppure, questa interpretazione non permetteva ancora di offrire copertura costituzionale a circostanze che avevano un impatto sull’ambiente (si pensi ad esempio alle emissioni di anidride carbonica e gas nell’atmosfera, o all’utilizzo di diserbanti agricoli). La giurisprudenza è andata dunque alla ricerca di fondamenti costituzionali ulteriori, in particolare all’art. 32 della Costituzione, e così, con la sentenza della Corte costituzionale n. 210/1987, il diritto alla salute è stato inteso come diritto ad un ambiente salubre. In seguito, la Corte ha accolto la tesi per cui i doveri di solidarietà economica, politica e sociale imposti dall’articolo 2 della Costituzione, includono anche i doveri di solidarietà ambientale. Ma il riferimento agli articoli 2 e 32 continuano a dare centralità all’uomo, perseguendo il diritto ad un ambiente salubre solo in riferimento al danno arrecato alla salute e/o alla dignità dell’uomo e non persegue il diritto dell’ambiente ad essere tutelato. Siamo culturalmente lontani dalla pur occidentalissima Nuova Zelanda che prevede un rappresentante legale per i fiumi, o dal Canada che introduce la action populaire per i danni all’ambiente, che può essere intrapresa da chiunque e non solo da chi ha subito un danno da un danno arrecato all’ambiente.
Responsabilità verso le nuove generazioni
Il termine «future generazioni» inserisce in Costituzione la doverosa responsabilità intergenerazionale, concetto che già troviamo, nella Dichiarazione di Rio de Janeiro, 1992: «Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future»; nella Convenzione sulla diversità biologica, le parti si dichiarano «decise a conservare ed usare in modo sostenibile la diversità biologica a beneficio delle generazioni presenti e future»; la Convenzione di Aarhus, 1998, riconosce «la necessità di tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere»; nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01), la salvaguardia dei valori comuni e la tutela dei diritti umani «fa sorgere la responsabilità e doveri nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future». Va rivista a questo punto la legge 1986 n. 349 che stabilisce che sono legittimate ad agire a tutela dell’ambiente solo le associazioni ambientaliste, «individuate con decreto del ministro dell’Ambiente» e non tutti i cittadini.
In conclusione
Siamo ancora lontani dalla determinazione dell’interesse prevalente, ambientale e sanitario, sebbene le modifiche riprendano e rinforzino tutta quella gloriosa giurisprudenza costituzionale che, dal 2007 in poi, ha considerato l’ambiente bene di valore primario e assoluto, non bilanciabile con altri interessi, per cui l’ambiente non è più un concetto evanescente, un fine o un valore, ma ha assunto dignità di bene materiale, oggetto di tutela esclusiva.
Il modello “culturale occidentale” di cui ci facciamo ancora vanto, che annovera tra i principi quello della concorrenza e del libero mercato, è in precipitosa decadenza; questa modifica nasce da spinte che vengono dalla constatazione che l’antropocentrica visione di sviluppo illimitato e predatorio ha fallito, ci ha portato ai confini del disastro non solo ambientale, ma anche sociale ed economico, dove anche l’uomo ha perso vera centralità, oramai ridotto ad essere solo un anello dell’intero sistema produttivo, al servizio di un unico padrone, il profitto. I problemi di salvaguardia ambientale e di giustizia sociale si intrecciano, basti pensare all’ecologismo dei poveri di Joan Martinez Alier, alla pandemia, al mondo ostaggio dei brevetti di poche multinazionali del farmaco, al disastro climatico che crea eventi estremi e povertà dilagante, penuria di terre fertili e acqua dolce, alla crisi energetica, agli extraprofitti sulla pelle delle persone, alle aziende che delocalizzano, alla precarietà e alla insicurezza sul lavoro. I dati ci dicono che abbiamo avanti a noi solo altre 4 o 5 generazioni, dai Babilonesi ad oggi ne abbiamo avute 127mila. Questo modello ci presenta il conto, ed è altissimo.
L’autrice: Paola Nugnes è architetto, già senatrice nelle ultime due legislature. Eletta nel M5s è poi passata al gruppo misto. Dal 2022 è attivista dell’associazione ManifestA