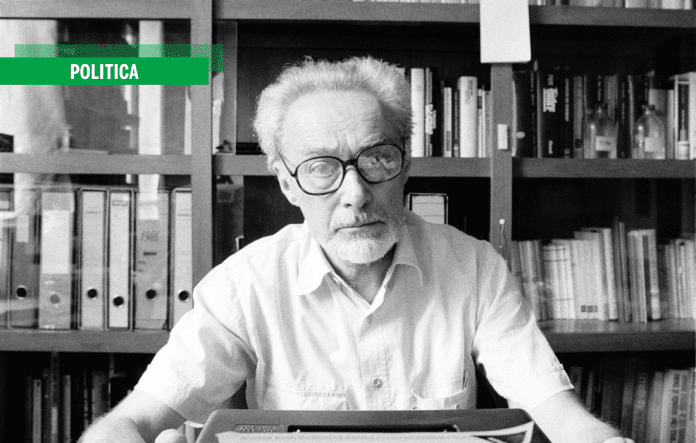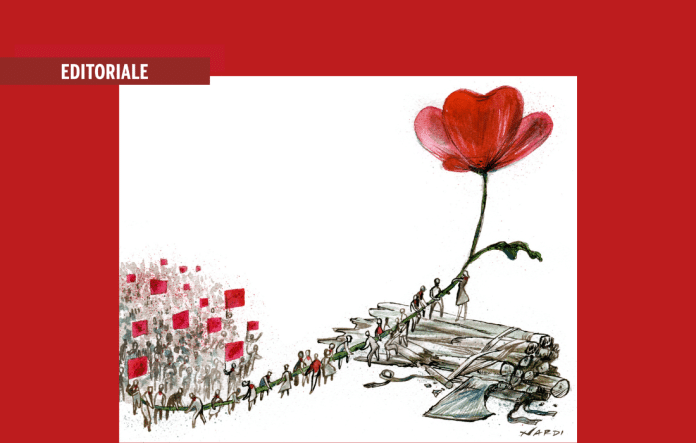Antefatto
Avevo 13 anni quando ho cominciato ad ascoltare la musica in modo più consapevole, riuscendo a tirarne fuori significati profondi che fino ad allora mi erano sfuggiti. Stavo diventando un adolescente irrequieto e ribelle e la musica parlava il linguaggio della ribellione. Avevo 13 anni e non avevo nulla o quasi nulla per ascoltare la musica. All’epoca mio padre aveva solo l’autoradio e una serie di nastri campeggiavano in salotto: Beatles, Venditti e soprattutto Franco Battiato che cantavamo a squarciagola in macchina durante le gite del fine settimana. Ma le vere scoperte avvennero nel momento in cui il nostro vicino di casa, che ascoltava la musica sul suo potentissimo stereo, cominciò ad invadere la mia stanza. Ho questo ricordo nitido di me con l’orecchio appoggiato al pavimento che ascoltavo sconosciuti che urlavano, cantavano, raccontavano storie di cui volevo sapere tutto. Marillion, Frankie Goes To Hollywood, Jethro Tull, Black Sabbath, David Bowie. E poi Genesis, Yes. Infine l’onda new-romantic: Duran Duran, Spandau Ballet, Talk Talk. Come un novello Dante avevo un disperato bisogno del mio Virgilio e lo trovai proprio nel mio vicino che, fedele al suo nuovo ruolo, cominciò a duplicarmi su cassetta una serie di album che adoravo. E le cassette venivano letteralmente consumate dal nuovo fiammante walkman che mio padre, impietosito, mi aveva comprato a Natale. Deejay Television era la mia bibbia del dopo pranzo. Lì passavano i video e potevi scoprire canzoni bellissime che diventavano 45 giri e poi 33 giri comprati con la paghetta mensile. Poi arrivarono i cd, le riviste specializzate, i dischi, e oggi, quell’onda, quello tsunami di ricerca, non si è ancora fermato. Erano gli anni 80 e il mercato musicale era in rampa di lancio verso quello che sarebbe stato il suo decennio più florido, gli anni 90, alla cui fine si sarebbe innestata una crisi irreversibile dovuta all’avvento della rete. Un avvento che avrebbe cambiato completamente le regole del mercato discografico, mettendo per sempre in discussione il ruolo degli artisti e la loro peculiarissima forma di espressione. E quello che aveva caratterizzato il mercato fonografico/discografico dalla sua nascita negli anni 30 fino a quel momento, ovvero la sostanziale irriproducibilità del supporto e il suo conseguente valore commerciale, sarebbe stato spazzato via da quelle stesse innovazioni tecnologiche.
Oggi
I dati ufficiali della Fimi (Federazione industriale musicale italiana) di marzo 2022 sull’andamento del mercato discografico e sugli abbonamenti alle piattaforme streaming ci raccontano di un magnifico 2021 per la musica riprodotta dopo la pandemia. Il settore sembra decisamente essere tornato a produrre profitti, come dichiarato dalla Fimi stessa:«Nel 2021, a livello globale, si sono registrati i migliori risultati di sempre per l’industria discografica, ad oltre vent’anni dalla fase di transizione accompagnata da una devastante pirateria che dimezzò i ricavi del settore». La Fimi riporta ancora che «solo nel segmento audio, ormai ogni settimana, i consumatori italiani realizzano in media oltre un miliardo di stream e nel 2021 hanno speso oltre 19 ore settimanali nell’ascolto di musica. Nessun settore in Italia ha mai adottato una così ampia fascia di tecnologie per sostenere la distribuzione dei propri contenuti: dallo streaming alle app di social media, dal gaming allo short form video di TikTok, non c’è un segmento delle nuove tecnologie dove la musica non sia protagonista e dove non generi ricavi per etichette e artisti. Anche i supporti fisici sembra continuino a crescere con addirittura un +10,6% per i cd e ancora un incremento di oltre il 70% per il vinile, e di un 37% per i diritti di sincronizzazione che superano i dieci milioni di euro». Ma la cosa più interessante è che, sempre secondo la Fimi, negli ultimi anni per la musica italiana, grazie all’innovazione e agli investimenti delle case discografiche nei giovani talenti, si è assistito a un forte ricambio generazionale. I “nuovi talenti” si sono trovati a proprio agio nella musica liquida e nei canali social. Inoltre «nelle classifiche di fine anno, le top ten di singoli e album sono state dominate dal repertorio italiano: diversi artisti della Generazione Z hanno ottenuto risultati di ampio respiro conquistando numerosi dischi di platino».
Un’ultima considerazione della Fimi riguarda l’ampliamento del mercato del prodotto musica che sembra non avere confini: «Se nel passato un artista aveva di fronte, in linea di massima, solo due grandi modelli, quello dei ricavi discografici e quello della musica dal vivo, le opzioni disponibili oggi crescono costantemente… Nft (non-fungible token) e metaverso ad esempio, esperienze immersive cross tra digitale e musica dal vivo accompagnate dalle tecnologie di ultima generazione». A proposito di questo crossover basta ricordare il grande evento del concerto live “virtuale” di Travis Scott all’interno della piattaforma del videogioco Fortnite, seguito dalla bellezza di 12 milioni di utenti. A raccontarla in questo modo qualcuno potrebbe credere che il settore in questione sia una specie di Eden, un mondo in grande crescita, in cui artisti, discografici e addetti ai lavori si spartiscono torte di una certa rilevanza, brindando con ottimo champagne. Ma è davvero così? Oppure dietro questa narrazione tutta al positivo si nasconde qualche crepa? L’era del “segmento fisico”, come la definisce la Fimi, era tutta un’altra cosa, certo. Individuare però la “pirateria” come generica causa della perdita dell’80% dei ricavi di un mercato floridissimo nello spazio di qualche anno significa non riconoscere, tra i diversi fattori che hanno determinato il processo, anche la modalità con cui case discografiche, addetti ai lavori e artisti hanno risposto alle nuove sfide lanciate dall’avvento di internet: un nuovo mercato, nuovi utenti e soprattutto l’addio all’uso massivo dei supporti fonografici.
Come è cambiata, dunque, la fruizione del prodotto musica con la rete, e in che modo la musica è ancora un prodotto? Per rispondere a questa domanda possiamo fare riferimento a un best seller scritto nel 2006 dal saggista e giornalista statunitense Chris Anderson, La coda lunga. Da un mercato di massa a una massa di mercati (edito in Italia da Codice edizioni). Questo libro è stato, negli ultimi anni, un importante vademecum per chi abbia voluto orientarsi in questo mondo nuovo in cui, per dirla con le parole dell’autore, «si è passati da un mercato unico che vendeva milioni di prodotti, a milioni di mercati che vendono pochi prodotti tutti diversi». Queste “nicchie di mercato” hanno dimostrato come fosse più redditizio investire su una offerta radicalmente più vasta invece che concentrarsi sul lancio di poche hit confezionate per milioni di utenti e pronte ad avere successo. In un grafico preso in prestito dal mondo del marketing e della comunicazione, poi, Anderson, che ha diretto Wired Usa tra il 2001 e il 2012, spiega la sua affascinante tesi. Più si allunga l’offerta dei prodotti “di nicchia” e più i ricavi salgono. Ciò significa che complessivamente il totale venduto di questo tipo di prodotti, anche se in pochissime copie, supera sempre le vendite totali degli album, o delle singole hit, di artisti riconosciuti come best sellers. Questo andamento del mercato spiega dunque il fenomeno della coda lunga: una curva che sul lato sinistro ha il classico picco di vendite dei grandi successi, ma sul lato destro non arriva mai allo zero. Per ogni brano o segmento musicale, anche il più improbabile, ci sarà un ascoltatore pronto ad investirci. Tale cambiamento di paradigma ha completamente rivoluzionato e mandato in crisi quella che era stata, fino a quel momento, una delle inossidabili certezze del vecchio mondo dell’intrattenimento basato sul “sistema delle hit”: lanciare un prodotto nel mercato e farlo diventare un successo. C’è stata, poi, una fuga in massa dall’acquisto di supporti fisici: un dato incontrovertibile riguarda le vendite dei cd, passate, dal 1999 al 2005, da circa 900 milioni di pezzi a 170 milioni, spiega Anderson. La democratizzazione degli strumenti di produzione, i pc casalinghi su tutti, è stata una delle grandi rivoluzioni degli anni 90, e la masterizzazione dei cd, una sorta di passaparola da “mercato virale”, ha contribuito certamente ad un fisiologico calo delle vendite. In seguito, dal 2001 in poi, lo storage di massa da download illegale di mp3 (geniale formato che riduce il peso del file tagliando frequenze non udibili dall’orecchio umano e lasciando sostanzialmente intatta la qualità audio) ha inferto un altro colpo tremendo al mondo dei profitti. È noto, però, che il download illegale in realtà ha influito sulle vendite totali per una percentuale che non supera il 50%. E il resto? Qual è la verità dietro questa débacle? Come spesso accade la risposta è in una serie di concause che hanno a che fare principalmente coi cambiamenti dei gusti degli utenti. Come sostiene ancora Anderson, «La cultura oggi non consiste più nel seguire la folla fino alla vetta delle classifiche, ma nel trovare un proprio stile ed esplorare territori lontani dal mainstream come musiche di autori relativamente sconosciuti o classici dei tempi passati».
Trovare un proprio stile, giocarsi una propria identità di fronte all’oceano di produzioni che offrono i canali della rete. Questa è la sfida di oggi. La maggioranza dei ventenni, e anche dei trentenni, difficilmente accende la tv generalista o si forma un’opinione tramite gli altri media tradizionali, anch’essi colpiti da una crisi di vendite che sembra irreversibile, ma ha trovato nuove vie, più “personali”, di intrattenersi, informarsi, comunicare. Sembra quindi una nuova frontiera dell’utenza dove il consumatore sceglie o dovrebbe scegliere in maniera consapevole la propria “formazione musicale”. Ma questa è proprio la grande contraddizione della nostra epoca in cui il tempo della fruizione “mordi e fuggi”, dell’ascolto casuale o distratto del prodotto musica, ha riportato sostanzialmente, come prima degli anni 70, a un lancio costante e continuo di singoli. Il tempo della possibilità di concentrarsi per ascoltare si è modificato e si è accorciato di fronte ai mille input e stimoli a cui siamo costantemente sottoposti. Nessuno vuole più soffermarsi a comprendere il lavoro di un artista contenuto in un album. Ci troviamo di fronte al paradosso per cui il tempo dell’ascolto si è ridotto in maniera inversamente proporzionale all’offerta quasi infinita di prodotti sulla rete. Quindi, seguendo la linea di Anderson, il mercato si è certamente frammentato in milioni di micromercati di nicchia in cui gli utenti potrebbero decidere per sé, ma nella realtà a questi milioni di mercati non corrispondono milioni di utenti consapevoli. Il libro è stato scritto nel 2006 ed è evidente che questi ultimi quasi venti anni ci abbiano messo di fronte al fatto che non tutte le predizioni positivistiche di Anderson siano andate in porto. In particolare l’iniziale fiducia nel talento selvaggio e inespresso di milioni di utenti ha ben presto lasciato il posto alla realtà in cui i social brulicano di meme, microvideo inutili e foto-ritocchi di un popolo sempre più dismorfofobico e sempre meno disposto ad accettare la realtà per quello che è.
Tornando a me e alla mia formazione musicale, invece, mi rendo conto di essere parte di una riserva indiana che è passata dal mondo dell’analogico al mondo del digitale e si è ritrovata a formare la propria cultura musicale pagando quelli che Anderson definisce «i costi della ricerca: soldi, tempo perso, fastidio, direzioni errate, confusione». Costi che però hanno prodotto benefici odierni: oggi so cosa cercare e dove cercarlo. Eravamo alfieri inconsapevoli di quel “marketing virale” iniziato con lo scambio di nastri, proseguito poi coni cd masterizzati e conclusosi con intere collezioni di mp3 scaricate da Soulseek che ci facevano somigliare sempre più pericolosamente a una massa di accumulatori seriali. Tra i costi della ricerca c’erano anche le riviste specializzate: Blow Up, Rumore, Mucchio Selvaggio, Rockerilla, sulle quali ho letto le storie dei musicisti che adoravo e come quelle storie si legassero in maniera indissolubile alle condizioni ambientali e sociali che le avevano prodotte. Ho letto migliaia di recensioni che guidavano per la maggior parte all’acquisto di album bellissimi e ogni tanto regalavano qualche dispiacere. Non mi è mai bastato ascoltare la musica, il suono, volevo anche sapere che cosa e quali condizioni lo avevano generato. Questo sono io. Questa è la mia storia di appassionato di musica cresciuto negli anni 80.
Ma un giovane di oggi, un nativo digitale, come affronta il “prodotto” musica? Come lo fruisce e in quale modo la musica entra a far parte del suo personalissimo mondo, e con quali strumenti affronta questo viaggio? Mi sono fatto raccontare da un ragazzo di 25 anni, l’età che si pone proprio a cavallo di quella fascia 18-34 considerata il maggiore bacino di utenza della discografia internazionale, qual è il suo rapporto con la musica, cosa ascolta, come e per quale motivo. Di fronte alle sue risposte non mi sono sentito così alieno come pensavo. La prima cosa che ho riscontrato è che lui non considera la musica un prodotto da comprare in senso stretto. La musica è ovviamente parte integrante della sua vita: ne ascolta tantissima su Alexa mentre lavora, ma anche con gli earpods dallo smartphone – dove guarda anche film e serie tv. Ha un abbonamento da 4,99 euro al mese a Spotify e gli unici due cd che ha comprato in vita sua li ha acquistati alla presentazione di un disco di un artista che apprezzava molto e li conserva solo perché se li è fatti autografare. Quegli oggetti sono diventati in questo modo unici e irripetibili, ma soprattutto da fotografare per metterli su Instagram e “fare tendenza”, come dice lui. La musica è un prodotto che deve essere gratuito o quasi e la sua fruizione prescinde totalmente dall’aspetto sonoro qualitativo di cui gli interessa poco. L’importante è che ci sia, che esca da un dispositivo bluetooth, dalle casse del telefonino o dalle casse del parcheggio del supermercato, mi spiega. Il suo mondo è un mondo in cui, senza troppe domande, semplicemente ci si bombarda di input e dove l’approfondimento e lo studio vengono visti con disinteresse.
Tutto si mescola in un gigantesco cloud in cui sono contenuti interessi, desideri, musica, cinema, serie tv, giochi e rapporti con gli altri esseri umani gestiti attraverso i social, strumento ormai centrale anche nel conoscere e conoscersi. “Ti piace la trap?”, gli chiedo. “Sì”, mi risponde, specificando però che della Dark Polo Gang, uno dei gruppi trap romani più indisciplinati e dalla scarsa passione valoriale, gli interessano i suoni elettronici e soprattutto il modo in cui le parole stanno insieme, come in un calembour dialettico, per riderci su. E poco importa se si parla di “fica, macchine, orologi, droga” e che alcuni di quei tipi siano poi finiti realmente nei guai con la legge. “Interessante”, penso. In realtà la sua è una struttura di ricezione degli input su più livelli. “So distinguere. Lì (con la Dark Polo Gang, ndr) mi interessava l’immagine, le scarpe e i vestiti e molto poco i contenuti. Invece ascoltando “Coraline” dei Maneskin, uno dei miei gruppi preferiti, la profondità del testo mi ha colpito. L’avrò ascoltata un milione di volte. Sai quando un testo si rivolge direttamente a te?”. “Capirai”, gli ho detto io, “con Somebody dei Depeche Mode ci ho costruito uno stile di vita, figurati”. Ecco quindi il trait d’union tra me e lui. Le canzoni e la musica hanno ancora il potere di cambiare la testa e i pensieri di chi le ascolta. L’attitudine dell’utente giovane, se non giovanissimo, è quella di pensare che ogni cosa che si trova in rete sia “gratuita” o a costo bassissimo senza minimamente chiedersi come questo sia possibile e a quale prezzo. Nella realtà la musica ha un costo di produzione che, in estrema sintesi, comprende una serie di passaggi che vanno dalla scrittura alla stampa dell’album. Tutto ciò che è diritto d’autore, in questo mondo di mezzo in cui i principali operatori online si sono mossi in netta contrapposizione alle regole del mercato classico, ha fatto sì che gli stessi utenti diventassero ignari delle semplici regole di sfruttamento e condivisione del prodotto artistico. Tutto sulla rete si è mosso per anni sempre al confine tra legalità e illegalità, in assenza di regole chiare e precise sulla gestione del copyright. È colpa dell’utente e della sua naturale attitudine alla pirateria, quindi, o c’è di più? In questo deserto di regole, i grandi gestori della rete, per esempio, si sono arricchiti fino a diventare le più potenti multinazionali del pianeta, che da un lato coccolano algoritmicamente i loro clienti, proponendo offerte sempre più in linea con le loro aspettative digitali, dall’altro fanno a pezzi le più elementari regole di concorrenza. Gli artisti vengono pagati pochi centesimi per ogni stream e la musica, considerata esclusivamente come prodotto, rientra nel grande calderone del mercato e trattata come tale. Ma la musica è arte e non solo prodotto di consumo. Dobbiamo osservare il presente per tentare di tracciare una linea che conduca anche al futuro, sempre se esisterà ancora un futuro per la produzione musicale.
Partiamo dai risultati più facilmente analizzabili. Se osserviamo le classifiche italiane di vendita, ci accorgiamo come negli ultimi dieci anni la musica italiana abbia sbancato la concorrenza estera. Una cosa mai vista in sessanta anni. Addirittura, nel 2021, nove dei dieci artisti nelle prime posizioni erano italiani: musica prodotta in Italia cantata in italiano per un pubblico italiano. Mi sono chiesto se i social, che danno ormai forma al 100% dei nuovi comportamenti in un pericoloso andirivieni sinusoidale tra realtà e mondo virtuale, non fossero uno dei motivi di questa nuova “autarchia” artistica. Mi muovo in un territorio inesplorato con una piccola lanterna e provo a darmi delle risposte. Una di queste strade finisce per portarmi al cospetto dell’algoritmo, questa creatura mostruosa che fa capolino ovunque ogni volta che si accende il computer: cookies, note, promozioni, annunci, reminders e pubblicità. L’algoritmo che guida ogni singola scelta, ogni piccolo movimento, ogni desiderio di beni-materiali e non-, accuratamente catalogati in enormi database che diventano poi il vero tesoro sepolto delle grandi multinazionali dell’e-commerce: Amazon, Google, Yahoo, Meta (Facebook + Instagram), Tik-Tok. Tutte sono a caccia dell’utente come prodotto. È questa, a ben vedere, l’ultima favolosa diavoleria capitalistica per cui «se un servizio è gratuito, molto probabilmente il prodotto in vendita sei tu». Come funziona? Semplicemente analizzando ogni cosa digitata, detta al telefono o comunicata con il nostro IP in modo da, senza scomodare gli spauracchi orwelliani, avere sempre un quadro molto preciso di come e per che cosa spenderemo i nostri soldi. Tutto qui. Di una semplicità tanto lampante quanto deprimente. La società dello spettacolo debordiana ha fatto il suo ulteriore passo mettendo lo spettatore in vendita al centro dello spettacolo. Sembra quindi evidente che anche la musica, in quanto prodotto, segua i “suggerimenti” dell’algoritmo. Basta premere play su una traccia di Spotify per cui automaticamente ci si trova proiettati in un “metaverso controllato” in cui le ricerche non sono più necessarie. Hai ascoltato un brano anni 80? Magari proprio del 1984? Te ne propongo un altro e poi un altro ancora sempre dello stesso anno. Stesse sonorità, stesso periodo storico, creando collegamenti razionali e con poca fantasia.
Se penso al romanticismo delle playlist che, con grande dispendio di tempo e passione, si facevano su nastro o su cd, come racconta magnificamente Nick Hornby in Alta fedeltà, mi viene un po’ da piangere. E il mio giovane amico di cui raccontavo poc’anzi? Magari ascoltando un brano di trap sul suo telefono con Spotify in cerca di altri brani della sua virtuale compilation, avrà fatto un giro apparentemente senza fine in un mondo invece chiuso, in cui la playlist trap del momento, scelta dall’algoritmo stesso, la fa da padrone. Un ascolto passivo, ignaro, in cui si pensa di navigare a vista usando la propria libera scelta e invece l’unica libertà rimasta è quella di stoppare questo flusso in repeat di generi e brani uno uguale all’altro. Questo oggi risulta essere il grande tema: la libertà di scegliere e soprattutto di perdersi nella ricerca stessa senza approdare necessariamente in qualche luogo. Quello che ci propone la rete come utenti, in buona sostanza, è il mondo perfetto, in cui ogni desiderio viene esaudito senza spazio per l’errore, la deviazione, la scoperta casuale.
Gli utenti finiscono quindi in due gigantesche macro-categorie: utenti consapevoli e utenti ignari. Badate bene: la questione è molto liquida e ogni utente, a seconda del tema in gioco, può passare da una parte all’altra senza nemmeno rendersene conto, con buona pace dei grandi gestori digitali. E così è cambiato completamente anche il ruolo dell’artista che è utente e produttore di contenuti. Se tutto quello che può veicolare ad un pubblico passa, per un buon 90%, attraverso i social, dovrà modificare completamente il suo modo di comunicare immergendosi in prima persona nel contatto col pubblico. Per molti artisti questo è diventato un secondo lavoro da affiancare a quello della scrittura e della composizione. Per altri artisti, quelli che si sono fatti prendere la mano, è diventata invece la parte centrale. Tutti i giorni un post, una foto, un video per promuovere un brano all’anno. Gli artisti sono cambiati quindi. E la musica? Venderà di più affidandosi a complicate operazioni di marketing come il Donda Stem Player di Kanye West? 200 dollari per un aggeggio che permette all’utente di comporre il proprio remix dell’album Donda, abbattendo di fatto l’ultima barriera tra artista e pubblico. Oppure tornerà di nuovo indietro ad un sistema più classico? Cosa dovranno ancora inventarsi gli artisti per vendere un prodotto dall’ormai scarso appeal commerciale? Quali invenzioni tecnologiche li aiuteranno a portare a casa la sudata pagnotta? È vero che le piattaforme di diffusione si sono moltiplicate, vedi Bandcamp, in cui gli artisti incassano dalle vendite quasi l’85% del valore dell’opera. Ma quale possibilità esiste di far conoscere i propri prodotti per gli artisti medi o piccoli, indipendenti, che pubblicano su queste piattaforme? Non saranno irrimediabilmente relegati in fondo alla benedetta coda lunga e fuori dalle grazie dell’algoritmo? Tutte queste domande non hanno ancora una risposta.
La musica però è viva e vegeta, su questo non ci piove, e ogni anno vengono ancora prodotti album bellissimi da artisti di talento sparsi ai quattro angoli del globo. Soprattutto i sincretismi tra musiche del passato, del presente e del futuro sembrano inarrestabili e avere una formazione culturale aperta e curiosa mai è stato possibile come in questo periodo. Un continuo gioco di colori, sapori e scoperte verosimilmente senza fine. Bisogna solo accontentarsi di guadagnare pochissimo o zero e di mettere nella propria personale vetrina tutto ciò che si è prodotto sperando che qualcuno, prima o poi, se ne accorga. Avremo al nostro fianco tutti i mezzi di marketing e comunicazione possibili. Migliaia di podcast e tutorial che spiegano “come aprire una etichetta online”, “come far girare il proprio video sulle principali piattaforme”, “cos’è il marketing virale per una sola canzone” e “come decuplicare gli ascolti su Spotify”. Ce n’è per tutti i gusti. Tutti gli addetti ai lavori del settore stanno cercando di capire come uscire da questo ginepraio, mentre gli anni della pandemia hanno abbattuto le speranze di alcuni per aprire inaspettate possibilità ad altri. “Ogni artista è padrone di sé stesso”, ripetono come un mantra le fanfare dell’informazione globale in questa gara al meglio. Una competizione senza fine in cui si è annebbiata l’idea del bello, dell’emozione, della profondità. E se un artista fosse molto bravo e talentuoso in tutto tranne che nella comunicazione in un mondo in cui solo il “comunicare bene” ha veramente valore? In quale categoria lo si potrebbe o dovrebbe mettere? Dov’è finita la possibilità di investire in progetti che, pur sembrando ostici o sperimentali, possono portare a grandi successi commerciali? Davvero è tutto nelle mani degli artisti?
Da artista confermo che non è affatto così. Per far uscire un prodotto non si può affatto prescindere dai classici media promozionali: un minimo di ufficio stampa, una agenzia di promotion, un booking per i concerti ecc. In una parola: costi. Il resto sono pure invenzioni. Che poi uno sia bravissimo a comunicare alla sua bolla di utenti/fan quanti panini mangia al giorno o il nome di sua nonna, credo non sposti di fatto di un millimetro la questione per cui se la musica che fa è inascoltabile, anche dopo un giro sui suoi social, lo sarà comunque. Aggiungerei che tutta questa nuova ossessione per il marketing e la comunicazione digitale, di qualunque cosa si tratti, non potrà mai sostituire la qualità, la bellezza e la profondità di un grande album o di una musica sublime. Ogni decade, incluse le ultime due, ha prodotto almeno un’opera musicale che ha saputo rappresentare lo spirito di un’epoca, spostando sempre più in alto l’asticella e ponendosi come punto di riferimento per tutto ciò che è venuto in seguito. Album come Thriller di Michael Jackson, Nevermind dei Nirvana, Kid A dei Radiohead e To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar stanno lì a dimostrarlo. Una lista assolutamente soggettiva e ampiamente modificabile, figlia del pensiero per cui ogni periodo storico traduce in suono tutte le proprie dinamiche e le relative contraddizioni. E queste opere insieme ad altri bellissimi lavori sono uscite per delle major, hanno raccolto consensi e hanno fatto emozionare milioni di ascoltatori.
Alcuni artisti, anche grandissimi, usano molto poco i social e producono album di bellezza siderale. Che poi escano su Bandcamp, in esclusiva su Amazon, solo su YouTube, su Deezer, su Spotify, poco importa. Facendo un salto temporale all’indietro, all’anno 1973, quando tutto quello di cui abbiamo detto era pura fantascienza, usciva The dark side of the moon dei Pink Floyd. Questo album è stato tutte queste cose contemporaneamente: è stato uno degli album più venduti della storia e allo stesso tempo uno dei più grandiosi esperimenti sonori in cui avanguardia, pop, rock, psichedelia, tecnica del cut & paste e profondità dei testi si uniscono in una potentissima ed amara riflessione sui lati oscuri dell’umanità. Disco che anche al centesimo ascolto rinnova la sua magia e lascia basiti. Oggi, un album come quello semplicemente non sarebbe più possibile perché ha bisogno di un ascolto continuo e di una attenzione profonda. Verrebbe gettato via nel giro di una settimana e avanti il prossimo. Così The dark side of the moon, esempio tra tutti gli esempi possibili, pur rimanendo icona del passato, nel suo essere monolite immutabile di infinite possibilità, diventa anche testimonianza di una qualità recuperabile, di un sentiero poco battuto ma meravigliosamente profumato, di tutto ciò che abbiamo perso e potremmo recuperare in questo gigantesco frullatore digitale.
L’autore: Riccardo Bertini è scrittore, compositore, songwriter e producer. Ha realizzato diverse colonne sonore per film, documentari e spettacoli teatrali
Per approfondire leggi Left di marzo