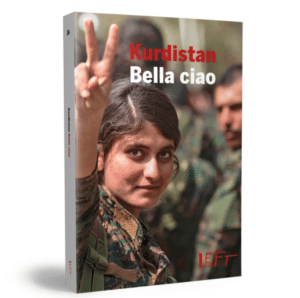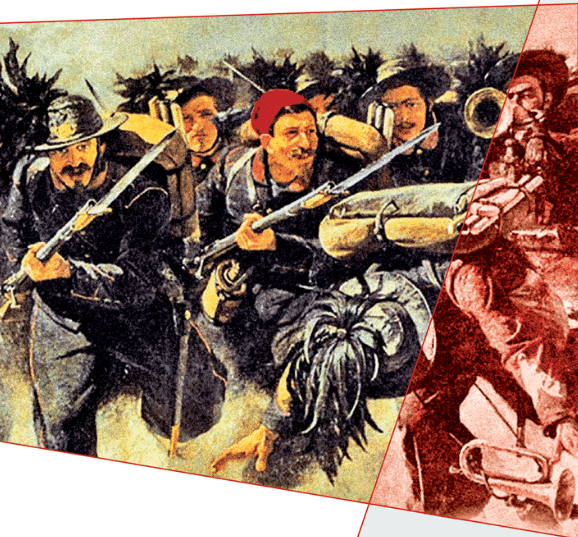Diciamo la verità, non se ne può più di ascoltare e di leggere di scuola: nelle ultime settimane giornali e televisioni si riempiono di indicazioni vaghe e contraddittorie su come avverrà la riapertura, docenti riottosi a ricominciare e a sottoporsi ai test sierologici, banchi monoposto con o senza rotelle, mascherine indossate da seduti o camminanti… Il risultato prodotto è una gran confusione e uno stato di ansia che non giova affatto alla chiarezza e alla operatività di cui invece avremmo bisogno per p oter iniziare un anno che si prospetta niente affatto semplice.
L’unica nota positiva da rilevare è che ci voleva una pandemia mondiale per evidenziare i tagli e i danni che si sono abbattuti da vent’anni nel nostro Paese sulla scuola, tornata a essere finalmente un luogo da ripensare.
Adesso scopriamo che non abbiamo aule abbastanza capienti, che nelle classi ci stanno spesso trenta e più bambini/ragazzi, che l’età media dei professori è di cinquant’anni, che mancano insegnanti, che gli istituti onnicomprensivi sono degli edifici mastodontici con più di mille alunni, istituiti per risparmiare sui costi di gestione.
Come già ben sottolineato da Left del 28 agosto il Covid potrebbe rappresentare un’occasione di svolta e di rinnovamento: per ricollocare al centro dell’agenda politica la scuola e tutto il mondo che vi gravita intorno.
E invece sapete che cosa vi diciamo noi che a scuola ci lavoriamo e che la viviamo? Che non sappiamo ancora assolutamente nulla di quello che accadrà il 14 settembre! Poche e fortunate le scuole i cui dirigenti hanno fornito a famiglie e insegnanti un prospetto su come avverrà la riapertura. Non solo, ma in tutto questo parlar di scuola, a nessuno è venuto in mente che noi professori oltre al problema della “mascherina si” – “mascherina no”, abbiamo quello di come ripensare il nostro lavoro in termini di contenuti e di modalità espressive. Dobbiamo rinnovarci e anche recuperare tutto il tempo perduto. Basti pensare a quei bambini che tra l’inverno e la primavera scorsi stavano iniziando a leggere, a scrivere, a fare di calcolo. O a quei ragazzi che avevano iniziato una lingua straniera, il greco e il latino… Bisognerà rimboccarsi le maniche immediatamente e seriamente se non vogliamo avere una generazione con buchi enormi nella formazione di base (e non solo). È come se…

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE