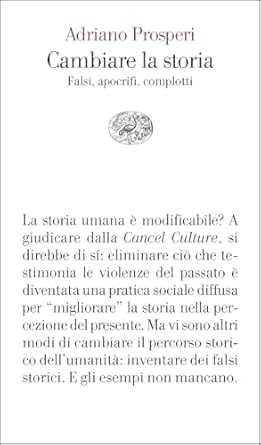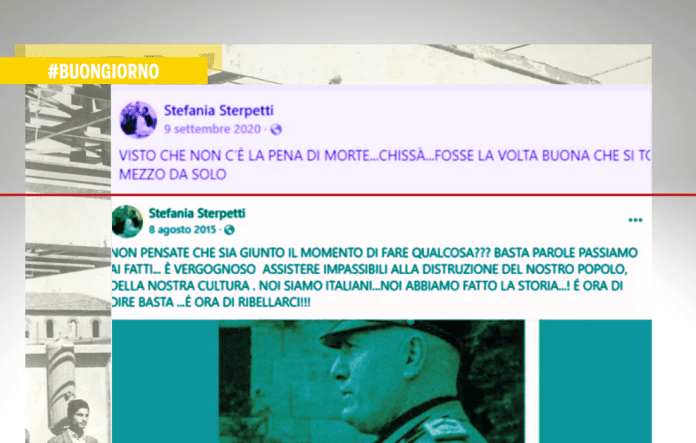Viviamo l’anniversario della liberazione, quest’anno, in un mondo sempre più alla deriva verso autoritarismo e nazionalismo, anche nostalgici. Diventa così importante non solo ricordare la giusta e fondante lotta dei partigiani, ma ancor più interrogarsi sul valore attuale di ciò che onoriamo. La Resistenza non fu solo una battaglia contingente contro il Male del nazifascismo: fu il progetto politico di chi si opponeva – pur nella varietà delle singole posizioni – a ciò che l’Europa stava diventando nell’esasperazione criminale e totalitaria dei nazionalismi. Quello spirito, in Italia, fu incarnato dal CLN prima, e poi soprattutto dal lavoro dell’Assemblea Costituente. Ma purtroppo si perse poco dopo, con il prevalere della logica dei blocchi di Jalta e la rottura dell’unità nazionale, in mezzo agli ostacoli che le sfere d’influenza ponevano ad una piena e autonoma integrazione europea, in quanto tale una possibile rottura nello schema della contrapposizione.
Oggi più che mai è urgente recuperare quella disposizione d’animo. E Ventotene è una tappa obbligata e profonda, non foss’altro per queste ragioni. Ma poi, il mese scorso, la becera cronaca politica ci ha forzatamente riportato lì in modo scorretto, manipolando la realtà.
E allora, dobbiamo oggi tornare a dire sì, Meloni, l’Europa che vogliamo è proprio quella di Spinelli Rossi e Colorni, quell’Europa che lei presidente non ha capito. O rifiuta di capire, perché in fondo non le dispiace l’immagine della Fortezza Europa a protezione delle nazionalità, di cui però parlavano proprio Hitler e Mussolini nel 1938 (si vedano come sempre le illuminanti pagine di Klemperer, in presa diretta su quegli atroci discorsi).
L’uso fatto in Parlamento da Meloni si inseriva nel solco delle grette manipolazioni a cui ormai la politica ci sta abituando su ogni sponda dell’Atlantico, attraverso citazioni decontestualizzate e opportunamente tagliate a proprio vantaggio. Ma anche certa stampa, lisciando il pelo alla presidente, non è stata da meno, con toni sguaiati: l’ormai sempre presente Galli della Loggia ha ripubblicato con Il Foglio un suo passato intervento, titolato ora Perché il manifesto di Ventotene è una boiata pazzesca (19 marzo); Pierluigi Battista, su Huffpost e in un’intervista al Giornale (20 marzo), parla di dittatura illiberale e controllo oligarchico della proprietà privata in modo – volutamente – parziale.
In quei giorni il dibattito è stato acceso e a tratti sgradevole, mentre il testo in questione avrebbe richiesto un atteggiamento più posato e rispettoso. Nato in un momento storico preciso, e da misurare su quel riferimento – come è stato a più riprese detto –, rimane però un testo proiettato nel domani, e dunque parla a noi, chiede di agire. Questo non esclude che alcuni punti della riflessione possano essere oggetto di riformulazione, e lo stesso Spinelli vi tornò negli anni successivi alla guerra. Basterebbe già solo ricordare, e prendere in mano, la voce Europeismo da lui stesa per l’Enciclopedia del Novecento della Treccani nel 1977. Galli della Loggia ed esponenti di FdI accusano Spinelli di spirito giacobino-leninista, dimenticandosi la sua avversione per il regime sovietico, ma più in generale per ogni brutale repressione e oppressione. Infatti nella voce Treccani attacca l’imperialismo hitleriano e ma anche quello napoleonico (figlio del giacobinismo a cui Bonaparte aveva aderito in gioventù). E poi, sempre in quelle pagine, Spinelli riconosce nella Svizzera uno dei pochi modelli alternativi di successo da prendere a riferimento per la soluzione federale. Difficile immaginare un feroce bolscevico che prende a modello la realtà elvetica, no?
C’è povertà di spirito critico se si vuole parlare del progetto federalista di Ventotene senza tener conto del personale sviluppo della riflessione da parte dei suoi promotori. Ma lo spirito critico non è di moda oggi purtroppo.
Come ogni testo, tanto più se legato ad un progetto politico, parla a noi che lo leggiamo, anche a distanza, ma certo occorre esser consapevoli che termini ed espressioni vanno misurati sul vocabolario del tempo, specie sui punti tecnici, altrimenti il fraintendimento è all’ordine del giorno. Ma i politici cercano in modo spasmodico questa ignoranza.
«La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente». Meloni, Battista, Loggia, sembrano aver dimenticato l’art. 42 della Costituzione, che parla di «limiti», «funzione sociale» della proprietà privata, possibilità di esproprio, contrasto ai monopoli. Per loro anche la carta costituente è un pericoloso documento di statalizzazione? Di sicuro non piace sotto vari punti di vista, ormai è chiaro. Tutti accusano il manifesto di essere marxista, o bolscevico. Ma evitano accuratamente di soffermarsi su un’espressione fondamentale: «non dogmaticamente». Ventotene smentisce da sé tutti i suoi detrattori, e più avanti dice: «essere coerenti, quantunque sia abbastanza difficile, è infinitamente più facile che esser saggi» (ci pensi chi si vanta, a torto, di coerenza). Il rifiuto del dogma implica un approccio socio-economico pragmatico, in cui non si detta una regola fissa (abolita, limitata o estesa!). Ciò esclude in partenza giacobinismo, marxismo ortodosso, leninismo e stalinismo. Spinelli rifiuta il dogma in nome di una pluralità di opzioni, da vagliare sui casi specifici. Il manifesto rifiuta il socialismo tradizionalista dogmatico, rifiuta le rigidità e il fideismo, con i connessi rischi totalitari. Spinelli parla di un mondo socialista, sì, ma propone un «socialismo spregiudicato», libero da assiomi e teso verso una società più giusta, lontano da ogni «torpido tradizionalismo» in cui anche il comunismo corre il rischio di cadere, quando pensa solo a perpetuare la sua idea, senza mettersi in discussione. Spinelli propone una visione in grado di adattarsi incessantemente al cambiamento, dunque un vero progressismo.
Ma la selezione parziale è la miglior arma di manipolazione, e tutti hanno ignorato la complessità degli scritti di Ventotene che oltre al Progetto d’un manifesto vedono anche: Gli stati uniti d’Europa e le varie tendenze politiche e Politica marxista e politica federalista. Qui si specificano e approfondiscono punti trattati nel primotesto, e sono fondamentali per capire cosa pensavano Spinelli Rossi e Colorni. Emerge una riformulazione del socialismo che prendere le distanze in modo netto dall’Urss, ma anche dal dogmatismo di Marx, individuando alcuni errori nella teoria socio-economica comunista (nell’assolutizzazione del concetto di lotta di classe e in forme di collettivizzazione piena). Si avanza in queste pagine una nuova visione socialista, che critica il capitalismo lasciato a se stesso, ma riconosce i vantaggi del libero scambio, e anche della produzione di profitto, purché indirizzata a investimenti redistribuivi, e non a forme di accumulo. Il vero bersaglio è la concezione monopolistica, propria del capitalismo estremo, ma che giustamente Spinelli riconosce, in forme deformate (monopoloidi) anche nel regime sovietico.
Pur nelle distanze, però, è su Marx che occorre misurare il termine su cui Meloni ha voluto di più calcare la mano: dittatura. Ogni parola ha diverse accezioni, specie se entriamo nel lessico di discipline come la politologia e la filosofia. Questo rende lo studio interessante ma anche insidioso, perché è necessario maneggiare con precisione i concetti. Se dittatura indica, nella percezione comune, un governo tirannico ed autoritario, anticamera del totalitarismo, occorre fare delle precisazioni per la filosofia e la storia delle forme di governo. Nell’antica Roma la dittatura era un assetto costituzionale previsto in momenti di crisi, una fase di passaggio in cui lo stato veniva traghettato da un prima ad un dopo. A questa formulazione non è estranea la visione di Marx quando parla di dittatura del proletariato. Strumentalmente la destra si ferma lì, spacciando questa teoria come il punto d’arrivo previsto dal comunismo. La dittatura del proletariato è per Marx un assetto di transizione: l’emergere delle contraddizioni e tensioni insite nel modello capitalista porterà inevitabilmente ad una crisi in cui la lotta di classe verrà esacerbata; per gestire la crisi e uscirne in modo nuovo, non reazionario, servirà – alla romana – una dittatura che guidi la mediazione dal capitalismo e comunismo, in vista addirittura di un’estinzione dello stato, idea certo non compatibile con idee di potere oppressivo.
Ora, Spinelli si distingue da Marx, ma legami restano nell’uso di certe parole. Davanti alla crisi della Seconda Guerra Mondiale, con il collasso prodotto dalle logiche degli Stati-Nazione, si potrà uscire in due modi: ripristinando l’ordine in ottica nazionale, o cercando una soluzione nuova. In entrambi i casi la transizione può esser definita dittatura – nel senso romano e marxista. Ventotene augura una «dittatura del partito rivoluzionario», cioè una soluzione di cambiamento. Questa dittatura è temporanea, per gestire nella fase di transizione le «informi masse»: qui, non c’è alcuna idea di popolo immaturo (cit. Battista e Loggia) ma, in termini filosofici (che pur nel distacco risentono del riferimento hegeliano-marxista), la consapevolezza di un ciclo dialettico della storia: la crisi e la catastrofe della guerra hanno sfaldato il corpo civile, che deve ritrovare una sua integrità e coesione; questo risultato non può essere ottenuto con lo Stato-Nazione. Occorre superare questo concetto nello spazio europeo, e adottare la logica federale, in un progetto che coinvolga partiti di diversi orientamenti, per costruire la vera libertà di popoli e individui. La dittatura infatti non è classista ma rivoluzionario-federale, e unirà tutti gli oppositori del totalitarismo, dai comunisti ai liberali, purché sappiano uscire dagli schemi dogmatici delle loro correnti. Il manifesto è chiaro, lo scopo della transizione è creare condizioni istituzionali, costituzionali e dunque culturali «per una vita libera, in cui tutti i cittadini possano partecipare veramente alla vita dello stato»; «non è da temere che un tale regime rivoluzionario debba necessariamente sboccare in un rinnovato dispotismo», proprio perché non si mira ad una società servile (cosa che accadrebbe invece con un ritorno all’ordine capitalista e nazionalista lasciato a se stesso). La Federazione Europea avrebbe infine dovuto svolgere, per il manifesto di Ventotene, il ruolo di mediatore e garante nei rapporti fra altri popoli, memore dei suoi errori e rafforzato da una nuova visione.
La politica oggi affronta testi di tale profondità senza la necessaria consapevolezza, e senza il rispetto dovuto, alimentando un non-progetto che nega la riflessione e il confronto, cerca la via plebiscitaria per accumulare potere e imporre una visione ideologica. Le destre oggi alla ribalta sono figlie dei nazionalismi che portarono allora alla catastrofe, e non rinnegano quelle radici, anzi. Dall’Europa delle nazioni di Meloni, ai Patriots, lo Stato-Nazione è l’ideale perseguito, ostacolando l’unione e rompendo con ogni forma di controllo sovranazionale (vediamo moltiplicarsi gli attacchi alla Cpi, e ad altri organismi analoghi). Il ritorno di queste tendenze pericolose è stato certo incoraggiato dal rancore delle classi medie, cavalcato per acquisire consensi (pensiamo al caso emblematico di Trump), con una dinamica che già nel ’41 Spinelli individuava come propria dei totalitarismi. Ma anche una sbagliata realizzazione del sogno europeo, sfociato in forme tecnocratiche in più casi discutibili, ha contribuito. E sempre Spinelli ci avvertiva di questo rischio amministrativo-tecnicistico, nella voce Treccani: «Un’amministrazione è sempre necessaria per realizzare un piano politico, ma tende per sua natura a irrigidirlo […] Nessuna agenzia settoriale europea avrebbe avuto una forza trascinante per il resto delle economia e della società europea, ove fossero mancati impulsi politici nuovi». Un’impostazione amministrativa, con la sua natura ibrida, è risultata più digeribile rispetto al vero federalismo, non intaccava veramente la sovranità nazionale. Ma il risultato a lungo andare è la rigidità, e questo elemento ha dato un nuovo ulteriore bersaglio ai nazionalismi. Per questo occorre tornare alla piena lezione di Ventotene, all’idea di esecutivo e legislativo europei «fondati sulla partecipazione diretta dei cittadini e non su rappresentanze degli stati federali» (come invece accade). La linea di divisione morale non deve essere in questa fase destra-sinistra, ma come diceva il manifesto nazionalismo-federalismo, perché il progetto europeo di Ventotene aveva una natura interpartitica, di unità, come Bobbio riconobbe più tardi e come chiarì subito nella prefazione Colorni. Dopo aver realizzato a pieno questo spazio politico si lascerà alla vita libera la dialettica fra diverse e legittime posizioni, nel rispetto condiviso per l’umanità.
Non si tratta di trovare una soluzione definitiva e fissa, come invece avrebbe voluto un progetto marxista ortodosso. Il progetto federalista è socialista perché vuole realizzare condizioni eque e libere per tutti. Ma non si tratta di un risultato raggiunto una volta per tutte. L’opera rivoluzionaria è solo «l’inizio di un’operosità che potrà durare e svilupparsi solo finché gli uomini conservino una seria volontà di lavorare in quel senso». Non servono istituzioni perfette, ma «in cui si formino uomini desiderosi e interessati a svilupparle, come garanzia della loro libertà e come strumento per la loro ascesa a forme più alte di vita individuale e collettiva». Solo così «i pericoli di domani possono essere serenamente affrontati con la sicurezza che saranno superati. Se invece il tipo umano prevalente dovesse essere quello dell’uomo-soldato ubbidiente […] nessuna organizzazione sociale […] potrebbe mantenere una civiltà di uguaglianza e di libertà». La ricerca dogmatica marxista correva il rischio di produrre un mondo del genere, irrigidito in una soluzione fissata una volta per tutte e a cui obbedire. Spinelli riconosce che «la soluzione federalista, intelligente, e perciò non definitiva, mira ad allevare uomini cui si possa con fiducia affidare il compito».
L’autore: Matteo Cazzato è dottore in filologia, ricercatore e insegnante