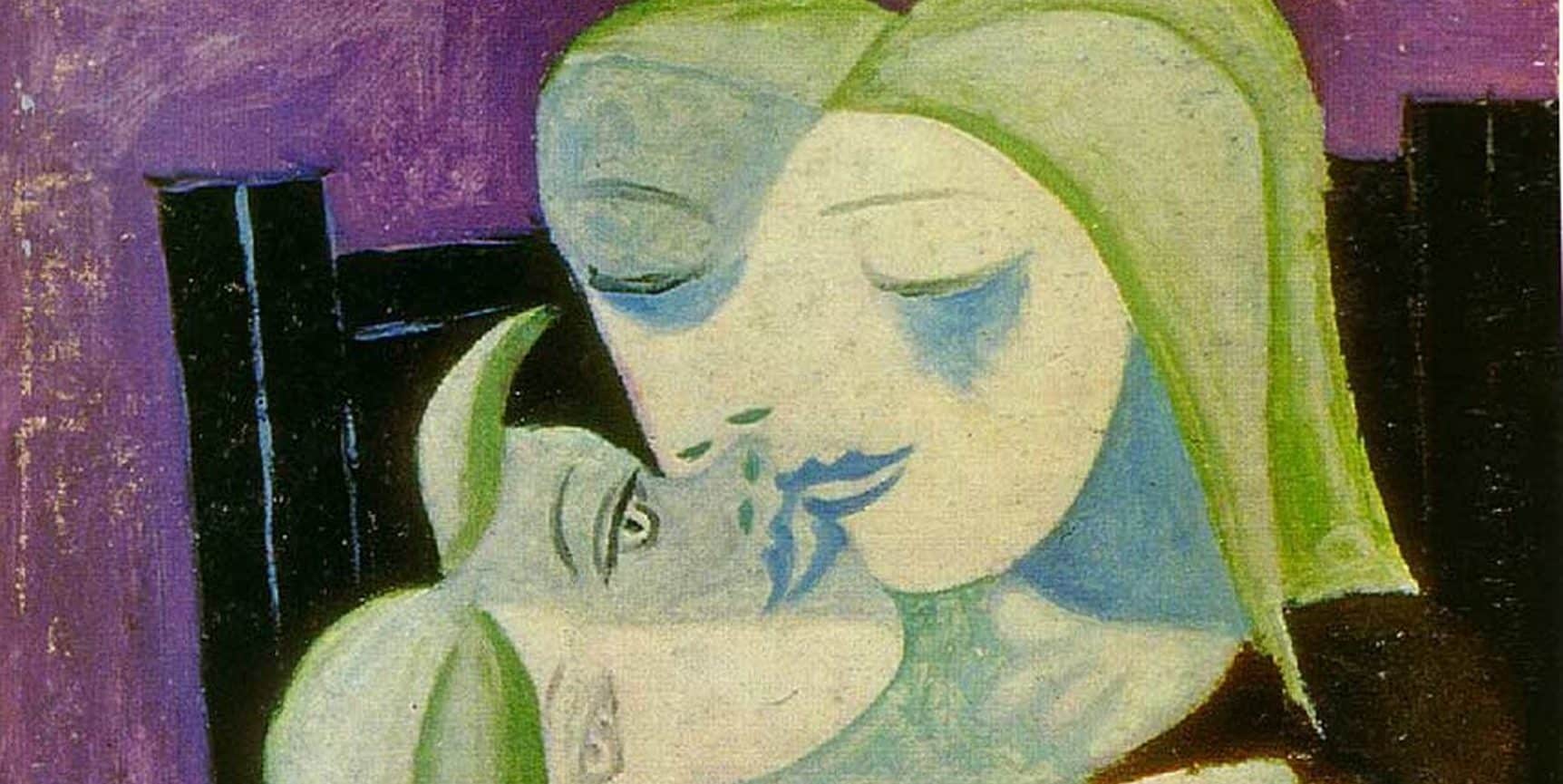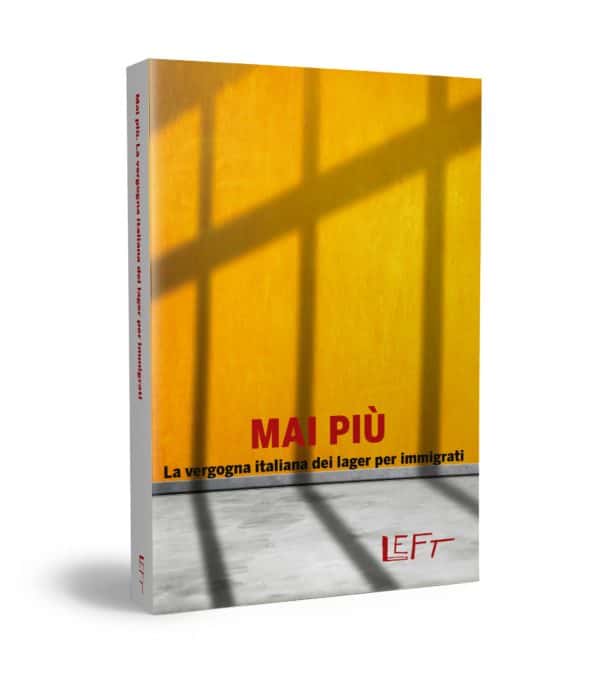«Non si può effettuare un cambiamento fondamentale senza una certa dose di follia. In questo caso si tratta di non conformità: il coraggio di voltare le spalle alle vecchie formule, il coraggio di inventare il futuro. Ci sono voluti i folli di ieri per permetterci di agire con estrema lucidità oggi. Voglio essere uno di quei folli. Dobbiamo avere il coraggio di inventare il futuro». In questo brano di un’intervista realizzata nel 1985 che potremmo considerare la sua epigrafe, Thomas Sankara, leader rivoluzionario di sinistra che rinominò l’Alto Volta in Burkina Faso, ben sintetizzò il cuore della propria eredità storica e intellettuale.
Presidente del Paese africano dall’83 all’87, politico in prima linea contro la povertà, militare difensore della pace e dei diritti umani, chitarrista in gioventù, la «follia» di cui parlò nell’intervista, naturalmente, non è da intendersi nell’accezione patologica del termine. Indica piuttosto il rifiuto di una certa razionalità. Quella, spietata, del pensiero neocolonialista (e neoliberista) che nega l’uguaglianza degli esseri umani ma subordina coloro i quali vivono nel Terzo mondo, legittimando il furto dei loro beni materiali e, in definitiva, della loro possibilità di realizzarsi. In questo senso, il termine “follia” indica un ostinato ed appassionato impegno nel pensare fuori dagli schemi imperialisti e violenti, le «vecchie formule», per rimettere le persone e la loro uguaglianza al centro della politica. Un insegnamento straordinariamente attuale. Al pari – come vedremo – di molti altri che hanno costellato la sua particolare esperienza rivoluzionaria.
Uno dei gesti più significativi di capitan Sankara nel modificare l’immaginario dei cittadini, per tagliare definitivamente i ponti col passato coloniale, fu il cambiare nome al Paese in «Burkina Faso», ossia «Terra degli uomini integri». Modificò pure bandiera ed inno nazionale. Volle ricreare un Stato autonomo e libero dalle ingerenze predatorie straniere. Nelle sue celebri orazioni alle Nazioni unite sono sferzanti le critiche alle forze dominatrici occidentali, e non solo. Memorabile è il suo faccia a faccia col presidente Mitterrand, accolto in modo ben poco “diplomatico” nella ex colonia francese nel 1986, con un discorso che denunciava la compiacenza di Parigi verso il regime dell’apartheid in Sudafrica. Ma Sankara ebbe a condannare anche l’invasione sovietica in Afghanistan. Perché il suo era un socialismo non dogmatico e non allineato.
Quando prese il potere con un colpo di Stato, subito si impegnò a migliorare le condizioni di vita del popolo burkinabé. Per lui quella era la vera rivoluzione. Diede il via ad un avveniristico programma di riforme puntando su diritti delle donne, istruzione, sanità, lotta alla povertà, ambiente, taglio degli enormi privilegi della classe dirigente. Priorità che dovrebbero segnare la rotta pure per la sinistra di oggi, e non solo quella africana. Certo, la sua sfida era titanica. Per descrivere le condizioni in cui versava l’Alto Volta basta citare alcuni dati, come fece Sankara stesso all’Onu nel 1984: «Un Paese di sette milioni di abitanti, più di sei milioni dei quali sono contadini; un tasso di mortalità infantile stimato al 180 per mille; un’aspettativa di vita media di soli 40 anni; un tasso di analfabetismo del 98%, se definiamo alfabetizzato colui che sa leggere, scrivere e parlare una lingua; un medico ogni 50mila abitanti; un tasso di frequenza scolastica del 16%». E poi, l’enorme zavorra del debito internazionale, che egli voleva cancellare con una azione non violenta e coordinata di tutti i Paesi africani.
Mentre ebbe successo nel restituire dignità almeno per un po’ ai propri concittadini, potenziando le scuole («un uomo che impara a leggere e scrivere – diceva – è come un cieco che riacquista la vista») e arrivando ad esempio a garantire per tutti i burkinabé due pasti al giorno e alcuni litri di acqua, fallì invece inesorabilmente sulla questione del debito. La sua strategia per creare un fronte panafricano contro il neocolonialismo era insopportabile agli occhi delle potenze occidentali. Se le idee di Sankara si fossero propagate, l’intero continente avrebbe potuto rialzare la testa, mettendo fine alla schiavitù finanziaria e alla rapina di materie prime pregiate a basso costo. Per questo il presidente burkinabé venne ucciso il 15 ottobre 1987 insieme a dodici ufficiali in un golpe organizzato dal suo ex compagno d’armi Blaise Compaoré, con la protezione dei servizi di Parigi e di Washington. (Cambiato contesto, attori e senza dubbio “metodi”, come può non tornare alla mente la crisi greca nell’estate 2015?). Alla sua morte lascia un magro conto in banca, quattro biciclette, un’auto – nel frattempo aveva sostituito le costose vetture di rappresentanza governative con delle frugali Renault -, tre chitarre e un frigo.
Ma «mentre i rivoluzionari come individui possono essere uccisi, non puoi uccidere le loro idee», come Sankara stesso disse nel suo ultimo discorso pubblico, ad ottobre del 1987, in onore di Che Guevara, assassinato esattamente vent’anni prima. E la veridicità di quella massima a ventisette anni di distanza è stata confermata, quando nel 2014 il suo volto è ricomparso su murales e cartelli nelle mobilitazioni che hanno portato alla caduta di Compaoré, ora in esilio in Costa d’Avorio.
«A livello personale, la sua semplicità, modestia e integrità morale sono un modello per tutti coloro che aspirano a gestire la cosa pubblica. A livello di lotta politica, non dimentichiamo il coraggio e la determinazione che ebbe nel costruire un Burkina Faso all’insegna di giustizia sociale e sviluppo inclusivo, che tenesse in considerazione sia l’ambiente che le future generazioni», ha dichiarato nel 2016 il rapper burkinabé Smockey, uno dei fondatori del gruppo di attivisti Balai Citoyen che ha contribuito all’insurrezione del 2014 diffondendo controcultura musicale che rinsaldava il mito di Sankara.
Perché è davvero una lezione attualissima, quella del “Che Guevara africano”. C’è chi riassume il suo punto di vista descrivendolo come un originale «marxismo umanista», che il presidente rivoluzionario avrebbe iniziato ad elaborare sin dagli anni della sua formazione militare. Questa è, ad esempio, l’opinione che il giornalista e ricercatore della Columbia University Ernest Harsch argomenta in A certain amount of madness (Pluto press, 2018), tomo fondamentale per comprendere il peso del lascito politico di Sankara e il suo riverbero nei movimenti sociali del XXI secolo.
Un lascito multiforme e diffuso, anche per quanto riguarda le politiche di genere. «Se perdiamo la lotta per la liberazione della donna – disse Sankara l’8 marzo 1987 – avremo perso il diritto di sperare in una trasformazione positiva superiore della nostra società. La nostra rivoluzione non avrà dunque più senso. Ed è a questa nobile lotta che siamo tutti invitati, uomini e donne». Per dargli spazio, Sankara incoraggia la ribellione al maschilismo imperante, vieta infibulazione e poligamia, promuove campagne contro l’Aids invitando ad usare i contraccettivi (mentre in Vaticano un altro capo di Stato ne scoraggiava fortemente l’uso), lotta contro la prostituzione, che considera «una sintesi tragica e dolorosa di tutte le forme di schiavitù femminile».
Inoltre, «di solito i politici maschi invocano la parità di genere come parte di un appello per “salvare” le donne dalla loro condizione di “vittima” nella società – ha sottolineato la sociologa e attivista Patricia McFadden -. Sankara invece ribadisce che la libertà delle donne e la loro emancipazione non sono qualcosa che viene concesso dall’uomo per una qualche forma di gentilezza o altruismo, bensì sono i risultati della lotta contro il patriarcato, praticato e difeso dai maschi». «Lo dicevamo già nelle prime ore della rivoluzione democratica e popolare – ribadì infatti Sankara in occasione della Giornata internazionale della donna – “L’emancipazione, come la libertà, non viene regalata, si conquista. E tocca alle stesse donne avanzare le loro rivendicazioni e mobilitarsi per farle arrivare a buon fine”». Nessun approccio caritatevole o paternalista alle questioni di genere, insomma.
E poi, ancora una volta anticipando i tempi, c’è la lotta di Sankara in difesa dell’ambiente. Oggi, mentre il movimento Fridays for future ravviva la sua battaglia globale contro il climate change, e affina i propri strumenti operativi e intellettuali, il chitarrista rivoluzionario offre una dritta sul “nemico” contro il quale indirizzare le forze. «Questa lotta per difendere gli alberi e la foresta è prima di tutto una lotta contro l’imperialismo – disse a Parigi nel 1986 -. Perché l’imperialismo è il piromane delle nostre foreste e delle nostre savane». Così, alla prima Conferenza sugli alberi e le foreste, Sankara andava come sempre al sodo nel denunciare i rapporti economici e di potere che sono alla base dell’inquinamento e della deforestazione.
Ma, ribadiva davanti alle Nazioni unite alcuni anni prima, nel 1984, «non pretendo qui di affermare dottrine. Non sono un messia né un profeta. Non posseggo verità. I miei obiettivi sono due: in primo luogo, parlare in nome del mio popolo, il popolo del Burkina Faso, con parole semplici, con il linguaggio dei fatti e della chiarezza; e poi, arrivare ad esprimere, a modo mio, la parola del “grande popolo dei diseredati”, di coloro che appartengono a quel mondo che viene sprezzantemente chiamato Terzo mondo».
L’augurio è che questo popolo, senza messia né profeti, torni a farsi sentire con forza in questo nuovo decennio.