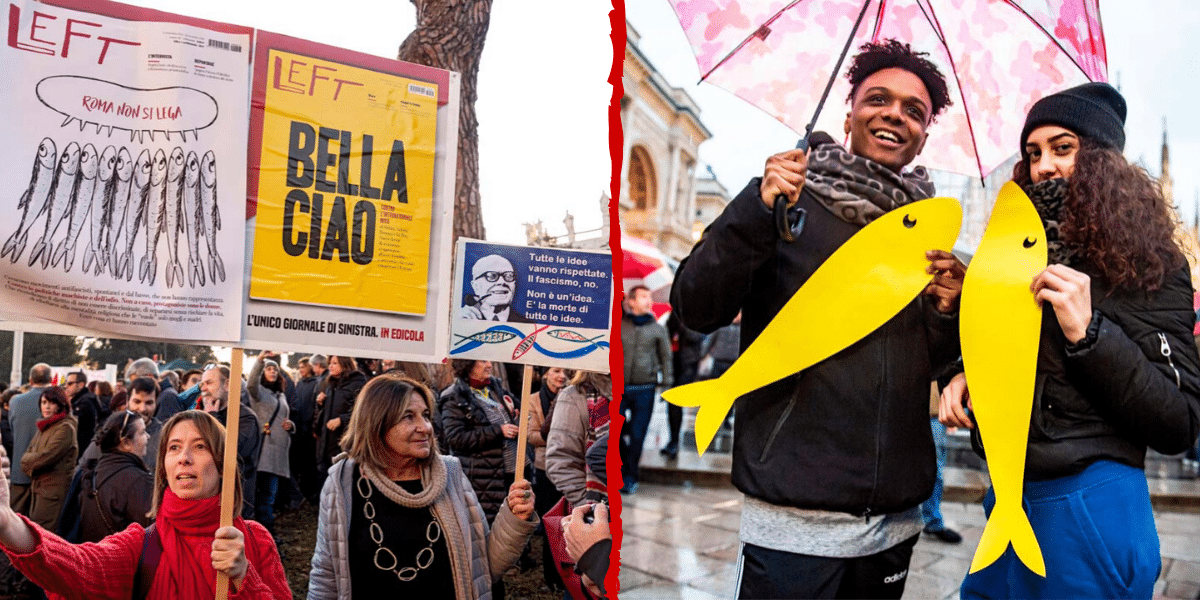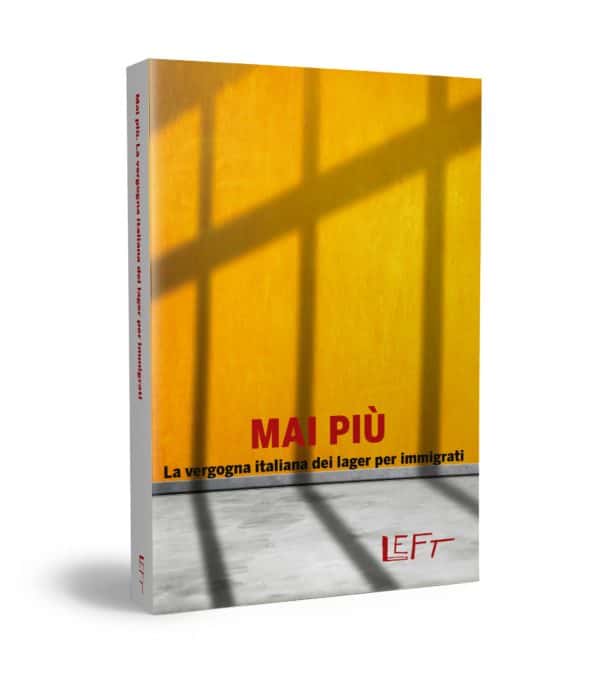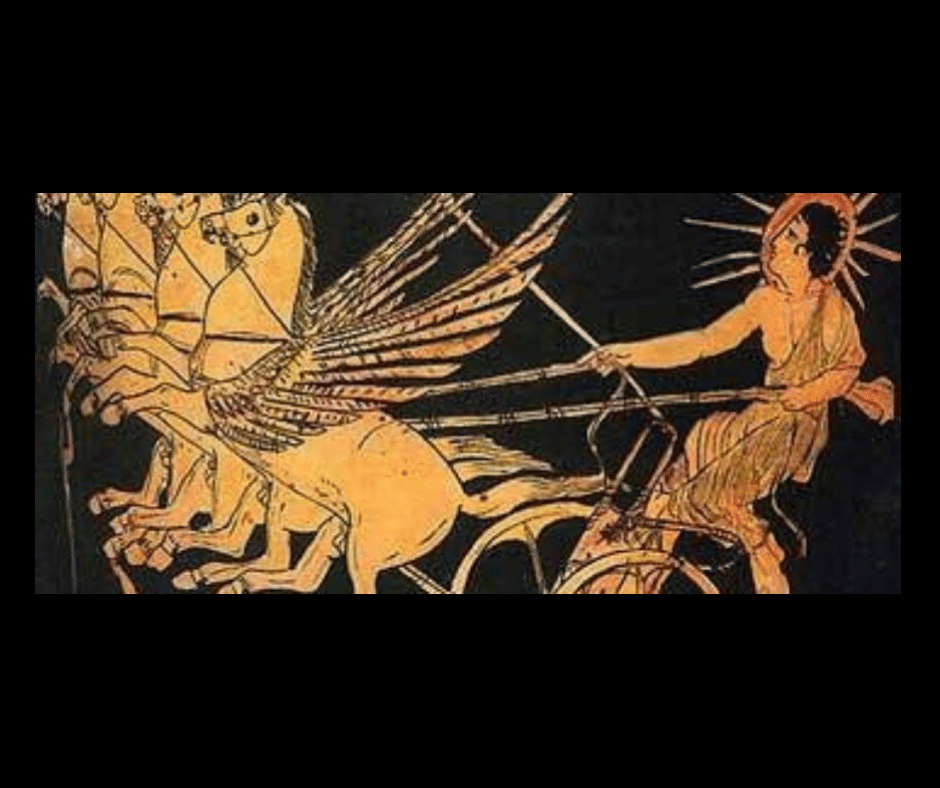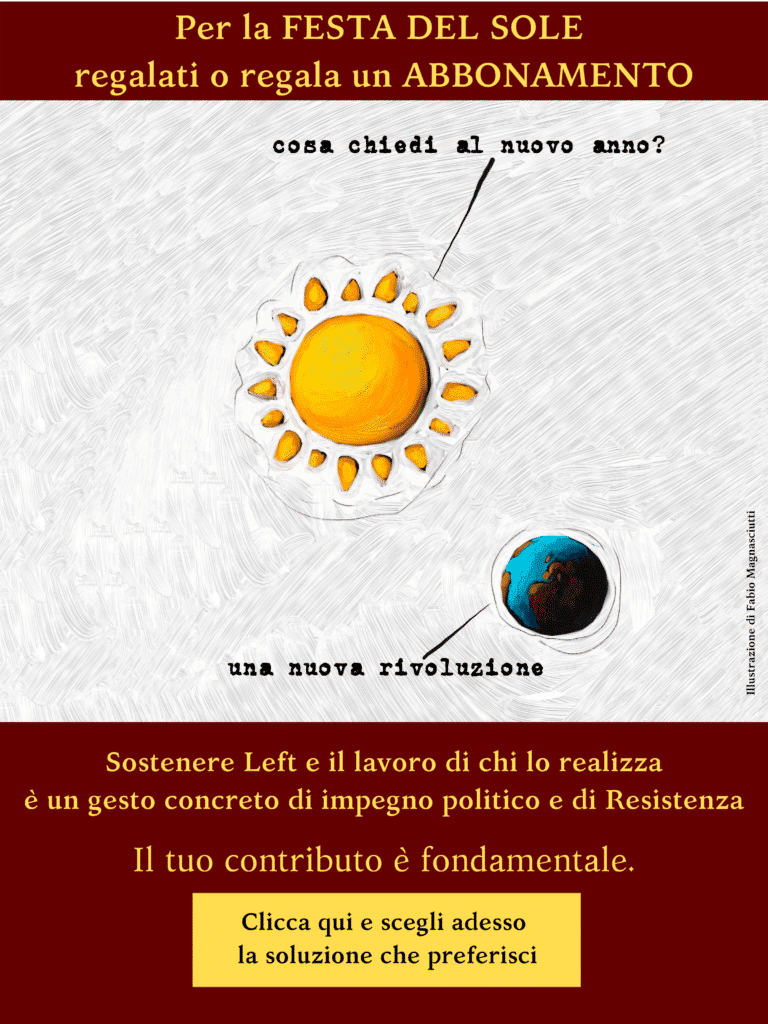Anche in epoca di crisi, nel 2008, la Germania e altri Paesi europei hanno investito nella scuola e nell’università come volano di sviluppo, non così in Italia. All’epoca di Berlusconi furono drasticamente tagliati i fondi alla scuola e alla cultura. E da allora non c’è stato alcun reintegro. Abbiamo chiesto cosa ne pensa al ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti.
Ministro Fioramonti, lei più volte ha posto la questione dei fondi per la scuola e per la ricerca, come settori strategici per il futuro dei giovani e per la crescita democratica del Paese. È urgente un cambio di rotta?
È più che urgente. È necessaria un’importante inversione di tendenza. Questa sensibilità nel nuovo esecutivo l’ho colta, ma ora servono i fatti. Risorse. Stanziamenti. È vero: i grandi Paesi in Europa hanno investito nell’istruzione e nella ricerca, con il risultato di una spinta decisiva alla loro economia. Investire sulla formazione non incide solo sul prodotto interno lordo, ma anche sulla qualità di quello che si fa e si produce. Non c’è futuro senza un’economia della conoscenza. Aver tagliato i fondi all’istruzione ha reso l’Italia meno reattiva alle sfide contemporanee, dallo sviluppo tecnologico alla riconversione industriale in senso sostenibile. Per questo ogni giorno mi batto per incrementare gli stanziamenti. A Bruxelles, dove sono stato recentemente per la riunione del Consiglio dell’Unione Europea sull’educazione, anche tutti i ministri delle Finanze hanno convenuto su come sia indispensabile investire in formazione e ricerca. Prendendo spunto da questo, se è l’Europa che indica questa strada, bisogna che consenta a tutti i Paesi di avere lo stesso passo. Un’idea è che questi investimenti siano scorporati dai parametri di bilancio richiesti dall’Unione.
I giovani dei Fridays for future pongono domande radicali non solo per fermare il climate change ma anche parlando di sviluppo sostenibile, immaginando un modo diverso di fare società. Inserire un insegnamento ad hoc su questi temi, come lei ha proposto, può essere un primo passo, in che modo? Sarà a costo zero?
Dal prossimo anno scolastico tutte le scuole dedicheranno 33 ore, quindi un’ora a settimana, all’educazione civica. Stiamo lavorando a un modello innovativo. Vogliamo centrare l’educazione civica anche sulle grandi questioni legate ai cambiamenti climatici, sui diritti ambientali, sulla lotta alle disuguaglianze. Punto di riferimento saranno i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Dobbiamo ascoltare le richieste dei giovani di un cambiamento culturale incentrato sul pianeta. A gennaio partirà la formazione dei docenti.
L’hate speech si combatte anche a scuola? Occorre rafforzare l’insegnamento di storia oltreché ripristinare la traccia di storia all’esame di maturità?
Sì, si combatte anche a scuola, dove si devono offrire strumenti per un linguaggio consapevole. E il ruolo dei docenti, ovviamente, è fondamentale anche in questo: spetta a loro educare gli studenti all’uso responsabile delle parole. Le scuole devono essere il posto dove si impara a contrastare l’odio, anche attraverso lo studio della storia. La storia è una bussola civile, non può essere solo una sequenza di date. E ripristinarne la traccia alla Maturità è il primo passo di un percorso più articolato che restituisce centralità a questa disciplina.
I costituenti pensarono e scrissero con grande lungimiranza l’articolo 9 che tutela il patrimonio artistico e il paesaggio legandolo alla ricerca. Ma il ministro Gelmini del governo Berlusconi ha tagliato l’insegnamento della storia dell’arte. Cosa ne pensa?
La storia d’Italia non prescinde dalla storia dell’arte. Siamo il Paese nel mondo che custodisce quello che è di gran lunga il più grande patrimonio artistico e culturale e una riflessione su come recuperare questo insegnamento la stiamo già facendo.
La scuola deve essere aperta a tutti. Una sentenza della Corte europea ha stigmatizzato la presenza del crocifisso nelle aule come elemento discriminante, appendere alle pareti mappe geografiche o articoli della Costituzione tutelerebbe di più credenti e non?
Lei cita una sentenza di una decina d’anni fa, ma poi la Corte europea si è espressa anche in modo diverso, accogliendo proprio un ricorso del governo italiano che difendeva l’esposizione del crocefisso nelle aule. Ho già detto qual è il mio pensiero di laico, un pensiero cauto e problematico, ed è stato deformato e strumentalizzato affermando che volevo togliere i crocefissi dalle classi. La scuola ha bisogno di tante cose, a cominciare dalla messa in sicurezza degli edifici, ma non ha bisogno di polemiche dove la tutela dei credenti o degli atei non è più un tema di rispetto delle diverse sensibilità ma è soltanto un pretesto.

Che effetti produrrebbe l’autonomia differenziata? L’Italia, una e indivisibile, sarebbe messa in discussione come luogo dell’esigibilità di diritti garantiti per tutti?
L’autonomia differenziata nella scuola è una falsa soluzione. I criteri divisivi non portano a nulla.
I sindacati hanno lanciato una mobilitazione a causa degli impegni disattesi sul concorso della scuola, come affrontare la questione?
I sindacati fanno la loro parte, sarebbe un problema il contrario. Difendono i diritti dei lavoratori della scuola con molte buone ragioni. Ma sul concorso della scuola abbiamo trovato un difficile percorso di stabilizzazione, e l’abbiamo trovato insieme ai sindacati. Più insegnanti di ruolo e meno precari. Io chiedo solo, come ministro, che ci vengano date le risorse per non scontare altri ritardi su questo percorso condiviso.
L’articolo 28 della legge di stabilità istituisce l’Agenzia nazionale della ricerca i cui vertici saranno in gran parte di nomina politica. Cosa ne pensa? Non dovrebbe essere guidato da una figura di alto profilo scientifico?
Un’Agenzia nazionale servirà a portare ricerca e formazione al centro della nostra politica economica. Dovrà essere governata dalla comunità scientifica, come nelle migliori pratiche internazionali, e non dalla politica. Sono sicuro che la discussione parlamentare porterà miglioramenti e offrirà indicazioni utili. Ritengo che la scelta sulla governance dell’Agenzia vada stralciata dalla manovra e rinviata a una norma successiva dopo un confronto con la comunità di ricerca.
Cosa rispondere ai tanti ricercatori che vorrebbero poter scegliere anche di restare in Italia?
È grave che vi siano ricercatori italiani costretti ad andare a lavorare all’estero. Va bene fare un’esperienza di formazione all’estero. Ma che questo avvenga perché si è costretti, no, non va bene. Ogni ricercatore per la sua preparazione ci costa trecentomila euro. Se poi va a lavorare fuori dall’Italia è come se noi questi soldi li avessimo regalati all’economia di un altro Paese. È necessario ragionare su un nuovo modello di sviluppo che porti al centro la ricerca. Servono finanziamenti, risorse, idee della politica. Le energie e le qualità umane ci sono.
Intervista pubblicata su Left del 15 novembre 2019