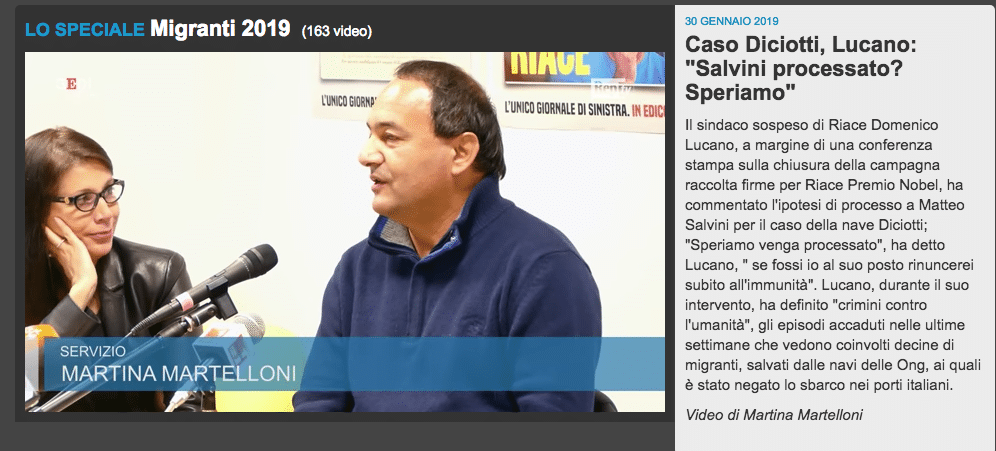«Salvini ha già detto “non voglio aiuti, voglio farmi processare”. Il problema non si porrà nella giunta autorizzazione a procedere». A tarda sera il dibattito si sposta sui talk show e Di Maio proclama questo da Rete 4. «Io ho preso le stesse decisioni di Salvini, non scappo dalle mie responsabilità». «E allora processate pure me!», dice Toninelli mostrando il petto a un plotone d’esecuzione che vede solo lui, ma lui lo vedono tutti quelli sintonizzati al mattino su Canale 5. Ma Salvini ci ripensa a mezzo stampa. E scrive al Corriere della sera. Quella per la nave Diciotti è stata una decisione presa «nell’interesse pubblico», per questo «va negata l’autorizzazione ai giudici». «La mia vicenda giudiziaria è strettamente legata all’attività di ministro dell’Interno e alla ferma volontà di mantenere gli impegni della campagna elettorale», evidenzia Salvini citando i dati su sbarchi e rimpatri. «Non rinnego nulla e non fuggo dalle mie responsabilità di ministro. Sono convinto di aver agito sempre nell’interesse superiore del Paese e nel pieno rispetto del mio mandato. Rifarei tutto. E non mollo».
«La valutazione del Senato è vincolata all’accertamento di due requisiti (ciascuno dei quali di per sé sufficiente a negare l’autorizzazione): la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o il perseguimento di un preminente interesse pubblico», spiega Salvini. «Il Senato non è chiamato a giudicare se esista il fumus persecutionis nei miei confronti dal momento che in questa decisione non vi è nulla di personale». Infatti, prosegue il vicepremier, «i giudici mi accusano di aver violato la legge imponendo lo stop allo sbarco, in virtù del mio ruolo di ministro dell’Interno». «Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l’autorizzazione a procedere debba essere negata. E in questo non c’entra la mia persona. Innanzitutto il contrasto all’immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico, posto a fondamento di precise disposizioni», sottolinea il leader della Lega. «In secondo luogo, ci sono precise considerazioni politiche. Il governo italiano, quindi non Matteo Salvini personalmente, ha agito al fine di verificare la possibilità di un’equa ripartizione tra i Paesi dell’Ue degli immigrati a bordo della nave Diciotti. Questo obiettivo – conclude – emerge con chiarezza dalle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno del 2018».
Processatemi, anzi no. Salvini sarà sott’esame per due mesi al massimo. Entro la fine di marzo sarà giudicato dal Senato, che deciderà se dare o meno l’autorizzazione a procedere contro di lui per il sequestro di persona a scopo di coazione, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale. Reati che avrebbe commesso “nell’esercizio delle funzioni di ministro” lo scorso agosto, quando Salvini ordinò alla Diciotti, pattugliatore della Guardia Costiera, di rimanere nel porto di Catania senza far sbarcare nessuna delle 190 persone partite dalla Libia che si trovavano a bordo. L’iter ha contemplato un primo passaggio al Tribunale dei ministri e dovrà passare ora attraverso l’autorizzazione a procedere della camera di appartenenza del ministro, il Senato. Il Tribunale dei ministri esiste in ogni distretto di Corte d’appello ed è composto da tre magistrati sorteggiati ogni due anni. Ha poteri di indagine, può ascoltare testimoni e ha 90 giorni di tempo per svolgere le sue indagini, prolungabili di altri 60. Al termine può archiviare, decisione definitiva e non appellabile, oppure trasmettere gli atti alla camera di appartenenza dell’indagato per chiedere un’autorizzazione a procedere contro di lui. Nel caso di Salvini il reato è stato commesso in Sicilia ed è quindi competente il Tribunale dei ministri presso la Corte d’appello di Palermo, formato al momento dal gip Fabio Pilato; Filippo Serio, del Tribunale del riesame; Giuseppe Sidoti, della sezione fallimentare.
Dal 30 gennaio la partita si giocherà a Palazzo Madama e coinvolge la maggioranza. Se il M5s preannuncia che voterà sì, la Lega minaccia che processare il vicepremier leghista significa «processare il governo». A favore dovrebbero schierarsi anche Pd e Leu mentre fedeli al garantismo berlusconiano, e quindi per il no, i senatori di Forza Italia. L’iter partirà mercoledì alle 11 quando si riunirà la Giunta delle elezioni e delle immunità. Il presidente (che è il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, in tutto sono 23 i componenti) leggerà la sua relazione, sulla base delle quasi 50 pagine scritte dal Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, sul caso Diciotti. Documenti arrivati al Senato giovedì scorso. Entro 30 giorni da allora la Giunta dovrà votare. Prima, si chiederà al ministro se intende replicare, di persona o per iscritto. «Voglio precisare che finora non è arrivata nessuna relazione di Salvini, anche perché non gliel’abbiamo chiesta», rimarcava ieri sera Gasparri (prima di trovare il Corsera nella mazzetta di stamane) aggiungendo che in genere si concedono dai 3 ai 7 giorni per la replica. Subito dopo il presidente della Giunta farà una proposta, dando così un primo orientamento sulla questione. Poi – ed entro fine febbraio – si passa al voto della Giunta (palese e a cui potrebbe partecipare il presidente). Step successivo, ed entro 60 giorni da quando il Senato ha ricevuto le carte processuali, cioè entro fine marzo, voterà l’Aula (voto palese e a maggioranza assoluta). Caso precedente al Senato fu quello dell’ex ministro dell’Ambiente Altero Matteoli coinvolto nell’inchiesta Mose e che finì con l’autorizzazione a procedere. Sul caso Salvini è per il «sì» non solo gran parte delle opposizioni ma anche il suo stesso alleato a Palazzo Chigi. Una scelta per coerenza, è l’argomentazione ufficiale.
E intanto l’Italia entra nelle attenzioni della Corte europea dei diritti dell’uomo per la vicenda Sea Watch, una recidiva di sequestro di persona. Proprio oggi Palazzo Chigi depositerà a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione «appartiene all’Olanda», Paese di bandiera della nave. Una volta riconosciuto ciò, l’Italia è pronta ad offrire un corridoio umanitario per trasferire i 47 migranti in territorio olandese. Intanto, la Sea watch 3 è isolata come una nave in quarantena. Vietato avvicinarsi per un raggio di mezzo miglio, ordina la Capitaneria di porto di Siracusa. E per il quarto giorno i naufraghi soccorsi il 19 gennaio scorso davanti alla Libia sono prigionieri a bordo. Non si scende.
Il Pd, come annunciato dal presidente Matteo Orfini e dal segretario Maurizio Martina, presenterà un esposto in procura contro la «detenzione illegale» dei naufraghi. I due, dopo essere saliti a bordo della Sea watch per una visita, sono finiti però tra gli indagati. «Ci contestano la violazione di un dispositivo di polizia, noi riteniamo di non aver violato alcuna legge e che quello che abbiamo fatto è nelle nostre prerogative parlamentari». La prefettura ribatte sostenendo di non aver autorizzato «alcun accesso alla nave, né ha il potere di farlo» ai parlamentari, aggiungendo che questi «sono stati informati del divieto e delle eventuali conseguenze di legge». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini mantiene la linea dura e ironizza: a chi «vuole portarmi in tribunale, rispondiamo col sorriso. A sinistra non hanno niente di meglio da fare che affittare gommoni per solidarizzare con i clandestini e denunciarmi. Io non mollo».
Intanto, si prospetta un’emergenza umanitaria: il comandante della nave comunica che i tre bagni stanno per raggiungere la saturazione: li usano i 47 passeggeri più i 22 membri dell’equipaggio. Potrebbe essere lo spiraglio per un possibile ok allo sbarco. L’Italia, dunque, è pronta a difendersi davanti alla Corte Ue sostenendo le responsabilità dell’Olanda e quelle della Sea Watch che, con una «temeraria condotta», in condizioni di mare mosso, rileva Palazzo Chigi, «anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia, universalmente considerata porto sicuro, si è avventurata in una traversata di centinaia di miglia mettendo a rischio l’incolumità dei migranti a bordo». Il Governo chiede poi se «l’obiettivo della Sea watch era salvare i naufraghi oppure creare un caso internazionale richiamando l’attenzione dei massi media?».
«Lo scorso 23 gennaio Sea watch – replica così la ong tedesca – a causa dell’arrivo di una forte perturbazione da nord-ovest, definita ciclone mediterraneo, abbiamo avuto diverse comunicazioni con il Jrcc olandese e con la capitaneria di porto di Lampedusa. Il centro di coordinamento marittimo olandese, dopo aver preso atto dell’impossibilità di entrare nel porto di Lampedusa, ha informato la nave che l’opzione di trovare riparo in Tunisia poteva essere percorribile. Il governo olandese ha quindi contattato il governo tunisino, senza però ricevere alcuna risposta». Già a novembre alla Sea watch era stato negato l’approdo in Tunisia per fare rifornimento e per ripararsi durante una tempesta, spiega l’ong: la nave si era ritrova per oltre 5 giorni al largo delle coste di Zarzis senza poter entrare in porto. Per questo, il comandante della Sea watch 3 ha fatto rotta verso Nord, verso l’Italia.
Nel frattempo, il governo, bontà sua, sottolinea la «totale disponibilità per assistenza in caso di richiesta» attraverso motovedette di Guarda costiera e Guardia di finanza. Pronti generi di conforto e assistenza sanitaria. C’è una bandiera gialla issata sulla Sea Watch: nel codice nautico comunica che è in corso la procedura per il rilascio della libera pratica sanitaria, sono cioè in corso accertamenti per verificare che non vi siano problemi sanitari a bordo. «47 persone in cerca di protezione sono davvero un rischio per la sicurezza nazionale?», chiede la ong tedesca. Ma, dopo il blitz di Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, la Capitaneria ha interdetto alla navigazione le acque intorno all’imbarcazione umanitaria per evitare «problemi riguardanti l’ordine pubblico e la sanità pubblica». Il procuratore siracusano Fabio Scavone, da parte sua, per ora non si muove. Non c’è nessun indagato, assicura. E smonta anche le «prove» ipotizzate da Salvini contro il comandante che avrebbe messo a rischio la vita dei migranti soccorsi per essersi diretto verso l’Italia invece che in Tunisia durante una tempesta: nessun reato, spiega il pm, ha scelto la rotta che riteneva più sicura. Quanto all’altro reato suggerito dal titolare del Viminale, favoreggiamento all’immigrazione clandestina, il pm non lo ravvisa. Scavone conferma invece i dubbi espressi dal ministro sull’età dei minorenni (sarebbero 13 secondo la ong). «Non hanno nessun documento con sé – rileva – e quindi è riportato soltanto l’anno di nascita senza neanche giorno e mese. Quindi è un profilo da verificare». E la situazione di stallo preoccupa il Quirinale. Il presidente Sergio Mattarella – che è in contatto con il premier Conte – segue da vicino la vicenda e, senza interferire, esprime l’auspicio che venga trovata una via d’uscita dallo stallo individuando una pronta soluzione.
Secondo i dati diffusi dall’Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), nel 2018, oltre 2.800 rifugiati e migranti sono morti in mare nel tentativo di raggiungere l’Italia dalla Libia su imbarcazioni inadatte alla navigazione e sovraffollate. «L’incidente della Diciotti ha rappresentato il culmine della politica dei “porti chiusi”, che il governo ha attuato senza averla deliberata né formalmente comunicata alle autorità competenti e senza riguardo né per la salute e la sicurezza delle persone coinvolte, né per i propri obblighi internazionali», scrivono Elisa De Pieri e Matteo De Bellis, ricercatori di Amnesty International, su La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019. Il diritto internazionale del mare impone agli Stati l’obbligo di garantire l’approdo di persone in difficoltà in un luogo sicuro nel più breve tempo possibile. Lo sbarco negato alla nave olandese Sea Watch, da giorni ancorata a un miglio da Siracusa, è un’ulteriore prova della violazione di questi principi. Persone vulnerabili, in fuga dalla fame e dalla guerra, continuano a essere ostaggi dell’ennesima disputa tra Stati.