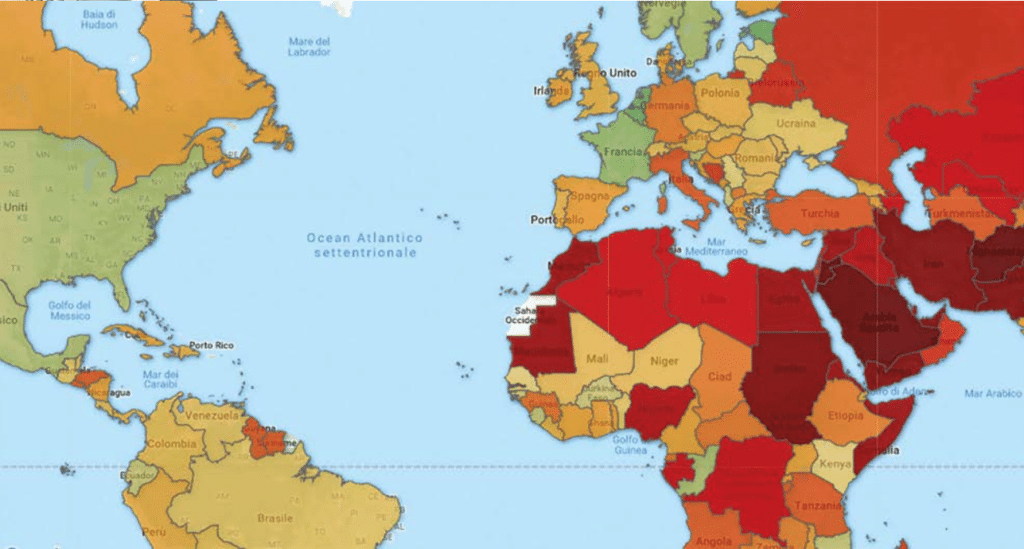È sicuro sapere che il tuo lavoro sarà pagato, in giusta misura, nei tempi concordati, con le garanzie che ti riparano dalla malattia e dalle sventure, con la possibilità di programmare la vita più in là della prossima settimana, con la certezza che qualcuno non lucra sul tuo stipendio per soddisfare un’avidità personale che chiama mercato. Questa è sicurezza.
È sicuro sapere che in giro non c’è uno studente, nemmeno uno, che avrebbe tutti i talenti e tutta la voglia e tutto l’impegno per accedere agli studi e invece non può permetterselo, non possono permetterselo i suoi genitori che se ne vergognano sottovoce alla sera prima di addormentarsi. Questa è sicurezza.
È sicuro avere dei genitori che non diventino scarti appena smettono di essere produttivi. È sicuro un Paese in cui invecchiare diventa un diritto, ammalarsi cronici non è uno stillicidio, in cui lo Stato si occupa di evitare che i figli si occupino dei padri e che i padri siano il sostentamento economico dei figli. È sicuro un Paese in cui ci si prenda addirittura il diritto di ammalarsi e confidare di guarire. Questa è sicurezza.
È sicuro un Paese in cui i fragili non vengano schiacciati. In cui fallire e quindi trovarsi in difficoltà non sia una colpa che comporti il nascondimento se non addirittura l’eliminazione. È sicuro un Paese che sa che le difficoltà capitano a tutti e che no, non sono solo i nostri successi a determinare il nostro spessore. È sicuro un Paese in cui chi più ha più paga e chi non ha niente perché abbia il diritto di rialzarsi. Si chiama patto sociale. Sembra una cosa vecchia. E invece è sicurezza.
È sicuro un Paese in cui le opportunità non dipendano semplicemente dalla contiguità al potere, un Paese in cui un’idea, una gran bella idea, possa girare indisturbata senza trovare nessuno con la bava alla bocca che le chieda “da dove vieni, a chi appartieni”?
È sicuro un Paese in cui non uccide il freddo, la fame non strema, la strada non vale come casa, la guerra non si sconta ancora una volta fuggiti. È un Paese sicuro quello che aiuta senza distinzioni di lombardi o terroni, neri o gialli, a casa nostra o a casa loro: un Paese che aiuta per rivendicare il diritto di essere aiutato. Un Paese in cui la vendetta è una soddisfazione da gretti, in cui la cattiveria è qualcosa da curare o da punire se infrange la legge, in cui seguire la Costituzione non significhi essere buoni. Cittadini. Appunto. Questa è sicurezza.
È sicuro un Paese in cui la classe dirigente, soprattutto quella pubblica, ancora di già quella politica, non abbia il tempo di curare la propria igiene propagandistica personale, indaffarata com’è dal mantenere sicuro il Paese. È un Paese sicuro il Paese in cui la pubblicità si paga, si dichiara, con la scritta messaggio promozionale anche sotto alla faccia dei politici mentre dicono cazzate, mentre fanno gazzarra. Questa è sicurezza.
È un Paese sicuro quel Paese in cui non ci si deve difendere da soli da rischi troppo spaventosi, assassini troppo vicini addirittura famigliari, perché è il Paese a dover essere sicuro, non qualcuno che ha indovinato la giusta congiuntura di luoghi, persone o status sociale. Questa è sicurezza.
È sicuro un Paese che ha memoria perché la memoria è l’inventario dei rischi corsi e da cui ci siamo salvati. Cosa c’è di meglio, per essere al sicuro?
Buon giovedì.