«Le novità possono mettere a repentaglio le Repubbliche e gli Stati, e allora chi ha il potere, che è ignorante, diventa giudice e piega gli intelligenti». Questa nota vergata da Galileo Galilei sulla copia del suo Dialogo da cui non si separava mai, ci ricorda che la vita dello scienziato in Italia non è mai stata facile. Rivela inoltre quanto lui fosse consapevole dei rischi cui andava incontro sposando la nuova cultura scientifica rinascimentale. Quella nata tra il ‘500 e il ‘600 all’esterno delle università e fondata sull’idea del confronto, della «disputa attorno a qualsiasi cosa». Sia essa su matematica, fisica o ingegneria. Era una cultura pubblica, democratica quella che affascinò Galileo. Ed è nel suo tempo che iniziava a diffondersi il metodo secondo cui chi sostiene una teoria viene invitato a esporre pubblicamente le ragioni per cui pensa che ciò che sta dicendo è vero. Un metodo di pensiero e di confronto talmente attuale e “scomodo” che 400 anni dopo il “processo Galileo” c’è chi – pur senza minacciare più roghi – continua a gettare sabbia dentro il motore della creatività per tentare di piegare la ricerca e la cultura della ricerca a ideologie o logiche di guadagno che con la scienza non hanno nulla a che fare. Pensiamo al caso Stamina, che Left ha seguito sin dalla prima denuncia nel 2009. Nonostante gli appelli e le dettagliate informazioni prodotte dalla comunità scientifica mondiale, un ministro della Repubblica firmò un decreto per consentire la sperimentazione dell’intruglio sponsorizzato da un esperto di marketing (poi condannato per truffa) su dei bambini malati terminali in un ospedale pubblico. In un sol colpo il ministro della Salute Balduzzi ha gettato discredito sulla scienza “ufficiale”, negando 400 anni di storia del metodo scientifico. È in situazioni come questa che trovano ulteriore campo aperto ciarlatani, fattucchiere e sedicenti guaritori. Facendo leva sulla “crisi” del pensiero critico e cavalcando la credulità popolare, particolarmente diffusa in Italia. Venendo all’oggi, per esempio, come ci si può difendere dagli anti vaccinisti e dalle loro “teorie” antiscientifiche? Qual è l’antidoto giusto? Senza dimenticare che nel nostro Paese il rapporto tra opinione pubblica e mondo della ricerca rimane vivo – lo testimoniano i numerosi e affollatissimi festival scientifici di levatura internazionale lungo tutta la penisola -, nelle pagine che seguono, per contribuire a fare chiarezza sull’importanza e sul ruolo sociale della scienza, abbiamo rivolto queste domande a degli esperti che hanno dedicato la vita alla ricerca e alla divulgazione “per amor di verità”: la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, la neonatologa e psicoterapeuta Maria Gabriella Gatti, lo storico della medicina Andrea Grigolio, il gastroenterologo e saggista Giorgio Dobrilla e i divulgatori Piero Angela e Sam Kean. (ft)
Senatrice Cattaneo, durante la discussione del ddl sulle vaccinazioni lei ha detto che questa «è una delle più importanti leggi di sanità pubblica della legislatura, quella che più di tante altre migliorerà le prospettive di salute dei cittadini italiani». Eppure la norma è stata approvata non senza “reazioni avverse”. A tal proposito Piero Angela dice in queste pagine che forse più della scienza è sotto attacco il metodo scientifico, la linearità del pensiero che innerva il metodo scientifico. Lei cosa ne pensa?
Sono d’accordo con Piero Angela ed è grosso modo quello che anch’io sostengo da quando ho iniziato a interessarmi ai rapporti fra scienza e politica. Il metodo scientifico rimane lo strumento conoscitivo più portentoso che l’umanità abbia a disposizione, da alcuni secoli, per controllare i fatti e riconoscere il vero dal falso, procedendo attraverso la progressiva riduzione degli spazi di incertezza e tenendo a bada i nostri pregiudizi e le errate percezioni. È il primo strumento di difesa a presidio della razionalità delle scelte e decisioni. E ci porta delle prove. Non credo sia un caso che esso sia quotidianamente svilito e frainteso. Ad esempio, in decine di anni e studi sperimentali sui vaccini sono state raggiunte evidenze oggettive circa la loro efficacia. Considerarli pericolosi non è quindi un’opinione come un’altra. È solo una falsa credenza, una convinzione soggettiva e ideologica, che viene alimentata per raggiungere obiettivi diversi da quelli dichiarati. È questa la “post-verità” tanto in voga, cui almeno linguisticamente ci siamo arresi, e che non è altro che la difesa fanatica del “falso”, del “non empiricamente controllato”, promosso a “verità alternativa”.
Le reazioni “avverse” sono avvenute sia fuori che dentro l’aula.
Incredibilmente durante il dibattito sui vaccini da una (piccola) parte del Parlamento abbiamo ascoltato strampalati interventi nei quali, ad esempio, l’innocuo (etil)mercurio è stato confuso con il mercurio, il vaccino della pertosse dato per non protettivo verso la trasmissibilità del patogeno (è esattamente il contrario), erano citate inesistenti morti da vaccino e non ricordate le morti (vere) causate dai patogeni. Tutte cose false ma che costituiscono una verità di comodo perché congeniale agli interessi di chi la narra (e alle aspettative di chi la ascolta).
Come è possibile che nel 2017 in un Paese evoluto e laico ci siano ancora addirittura uomini delle istituzioni ostili nei confronti della cultura (e della storia) della scienza?
Ritengo che lo spieghi bene Andrea Grignolio, storico della medicina, nel suo libro Chi ha paura dei vaccini (ne parliamo a pag. 46, ndr): il cervello di Homo sapiens non compie scelte razionali, in altre parole spesso sbagliamo di fronte a decisioni in cui compaiono il rischio, la probabilità e le previsioni a lungo termine. Il nostro cervello ha avuto una lunga storia evolutiva durante la quale le scelte da compiere erano relative al presente (e con una aspettativa di vita intorno a 30 anni) e limitate al singolo individuo. L’uomo non si è selezionato per affrontare i temi di cui stiamo parlando, emersi solo recentemente. Diamo quindi maggior peso a informazioni che suggeriscono alti rischi anche se irrilevanti statisticamente, mentre sottostimiamo i benefici e le informazioni a basso rischio, sebbene siano forniti da istituzioni scientifiche e sanitarie. La scoperta e soprattutto la conoscenza di questi processi mentali, sono comunque utili non solo quando si intende fare una buona divulgazione scientifica ma anche per chiunque si trovi a dover mediare tra il mondo della scienza e quello della società, della politica e delle istituzioni. Possono essere tra gli elementi di conoscenza e consapevolezza necessari per capire perché ci sia questa resistenza a inserire nel contesto legislativo le competenze tecnico-scientifiche, ma anche per comprendere come, per fare un esempio recente, il Parlamento abbia potuto considerare attendibile, e materia su cui legiferare (salvo poi correggersi), il cosiddetto “metodo Stamina”.
In una intervista il medico e divulgatore Salvo Di Grazia ci ha detto: «L’ignorante di cento anni fa, era ignorante perché non aveva nessuna informazione, gli mancavano del tutto le notizie. Quello di oggi è ignorante perché ha troppe informazioni e gli mancano i mezzi per selezionarle». Qui sono chiamate in causa indirettamente le politiche scolastiche che non mettono (più) in grado i futuri cittadini di sviluppare il senso critico e quella sensibilità necessaria per distinguere ciò che è coerente con la realtà da ciò che non lo è. Cosa può fare lo Stato per contrastare questa sorta di ignoranza 2.0?
L’“ignoranza 2.0”, nasce dall’“ignoranza classica”, quella che vede il Paese con percentuali di analfabetismo di ritorno impressionanti, cui è difficile porre rimedio se non con programmi di incentivo alla formazione permanente, così come da performance scolastiche che non smettono di descrivere – con le dovute eccezioni – un Paese a più velocità nord/sud. Per altro verso, la rivoluzione digitale in corso, impone anche un ripensamento degli obiettivi propri della formazione, che dovrebbe mirare, non più e non solo al possesso delle nozioni, quanto al senso critico con cui riconoscere e gestire ogni informazione. Nel campo scientifico ad esempio, ancor prima della scoperta, è fondamentale far conoscere il procedimento e le modalità con cui si è arrivata a validare quella scoperta, senza tacere gli innumerevoli fallimenti che accompagnano ogni sfida alla conoscenza. Si tratta proprio di insegnare il metodo scientifico nelle sue fondamenta. Inoltre, in campo scientifico si sperimenta l’ignoranza anche della popolazione più acculturata cui spesso sfuggono alcune nozioni elementari, quali ad esempio la mera conoscenza del processo che da una molecola porta ad un farmaco, le fasi di sperimentazione etc. Si tratta di buchi conoscitivi propri di una classe dirigente che finiscono col lasciare aperte autostrade a chi su questa ignoranza voglia fare leva per interessi particolari.
Il diritto alla conoscenza, a essere informati, è un diritto costituzionale. È garanzia di democrazia. Questo basterebbe a spiegare perché è importante fare corretta/equilibrata informazione e divulgazione scientifica. Pensando anche alle sue ricerche sulla Corea di Huntington, perché questo concetto fa fatica a passare?
L’Huntington è una malattia ereditaria e neurodegenerativa. Il gene mutato può essere trasmesso di generazione in generazione e quando presente la malattia purtroppo accadrà. Vi sono intere discendenze colpite, con più casi per famiglia. Molti anni fa, in assenza di scienza e conoscenza, la malattia veniva ritenuta segno della presenza del “demonio” per i sintomi cognitivi e motori, caratterizzati da movimenti a scatti, bruschi, incontrollabili, del corpo, delle braccia e delle gambe, che alteravano anche la gestualità espressiva e la mimica facciale. Ai tempi dei nazisti l’Huntington era una malattia da eliminare, i malati e familiari venivano sottoposti a sterilizzazione obbligatoria e poi alle camere a gas. Ancora oggi c’è uno stigma da combattere, perché si tende a discriminare ciò che non si conosce, lo si ritiene diverso, posizionandolo in una scala inferiore. Le scoperte scientifiche su questa malattia, come su altre, ne hanno spiegato la biologia, dato riconoscibilità e visibilità al problema medico, fornito alcuni farmaci per combattere i sintomi, una forma di assistenza (anche se mai sufficiente), un test genetico e quindi la possibilità di operare in modo autonomo scelte di vita. La scienza può quindi insegnare a essere cittadini migliori rispettosi delle evidenze e insofferenti di fronte agli abusi. La democrazia è quella che riconosce e offre opportunità a tutti sulla base delle prove che si rendono disponibili.
Di recente un bimbo di 7 anni è morto per un’otite curata con l’omeopatia. Nel 2015, la rivista Nature ha inserito l’omeopatia in una speciale classifica dei nove falsi miti “medici” duri a morire. Lei cosa ne pensa?
In sistemi sanitari pubblici universalistici come il nostro, per cui le terapie di ciascuno sono sostenute dalle tasse di tutti, nessun atto medico o cura che non sia “evidence based”, fondato sulle prove, dovrebbe farvi ingresso. A ciascuno – adulto e capace di intendere e volere – la libertà di curarsi (o non curarsi) come preferisce, senza però pensare che questa libertà sia esercitata a spese di altri. Sul merito del tema omeopatia non posso che fare mio il documento del Comitato nazionale di bioetica (Cnb) dello scorso 20 aprile, predisposto da Cinzia Caporale, in cui si giudica criticamente che i preparati omeopatici in commercio in Italia non rechino specifiche indicazioni sull’etichetta, che invece dovrebbero comparire per trasparenza. Andrebbe cambiata la denominazione da: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate” con “Preparato omeopatico di efficacia non convalidata scientificamente e senza indicazioni terapeutiche approvate”. Se la libertà di scegliere se e come curarsi resta indiscussa rimane il dovere di aiutare i cittadini a fare chiarezza e di eliminare ogni ambiguità tra ciò che ha un senso scientifico e ciò che non è mai stato dimostrato averne. A tal proposito è da rilevare una deprecabile timidezza sul tema dell’omeopatia da parte dell’Ordine dei medici. In occasione del voto sul documento del Cnb il rappresentante dell’Ordine si assentò. Né si possono dimenticare dichiarazioni cerchiobottiste in occasione della tragica morte di quel bambino.
Pensiamo al caso Stamina. Se un esperto di marketing laureato in scienza della comunicazione arriva a testare un intruglio su dei bambini malati terminali in un ospedale pubblico grazie a un decreto ministeriale, è chiaro che c’è una responsabilità da spartire tra diversi soggetti.
Sul caso Stamina si è assistito ad un colossale deragliamento dalla ragionevolezza mediatica, parlamentare e giudiziaria. Di tutta questa terribile vicenda resta il danno fatto alle persone, ai malati ingannati, ai cittadini abusati nella loro credulità su argomenti che masticano a fatica. Resta anche il danno culturale dovuto al dileggio della medicina, della cultura, delle competenze, dei giovani che nelle aule universitarie si ribellavano all’idea che la propria preparazione potesse essere messa, dalle massime istituzioni nazionali, sullo stesso piano delle chiacchiere di un ciarlatano.
Come può un normale cittadino difendersi da questi ciarlatani e da chi li sostiene?
É sulle spalle di tutti l’onere di informarci per difenderci da chi semplifica e banalizza i temi politici, ma è altrettanto vero che studiare per associarci e dialogare con gli eletti è una buona pratica. Solo se saremo informati e consapevoli dei fatti potremo capire se essere insoddisfatti di chi ci rappresenta, consentendoci di concorrere direttamente all’attività politica, partecipando a costruire la democrazia e, nel caso, determinarci nel «premere o addirittura sostituirci» a chi eventualmente riteniamo essere mediocre.
A cosa serve la scienza?
Ad ancorare un Paese alla realtà delle prove accertabili, a rafforzare le premesse di una democrazia matura, a migliorare la vita di sempre più persone, ad affrontare il futuro e gli eventi avversi della natura con capacità, realismo e conoscenza, ad allontanarci dai riti magici, dalle superstizioni e dai ciarlatani di cui il mondo continua ad essere popolato. A volte faccio un esperimento con i miei interlocutori, presentandomi come ricercatrice o come scienziata. Le reazioni sono completamente diverse. Alla parola “scienziato” seguono spesso sorrisi e parole divertite, che richiamano l’immaginazione del pazzo studioso da sottoscala tra alambicchi e provette fumanti, sempre pronto a far saltar per aria un bancone di laboratorio. In Germania, Gran Bretagna o Stati Uniti alla parola scienziato si associano spesso frasi di riconoscimento sociale, di ammirazione, di consapevolezza degli anni di studio, di colui che indaga per tutti. Il secondo errore a livello di opinione pubblica è l’abbaglio che la ricerca scientifica serva a generare “prodotti” da vendere. E che quindi sia degna di considerazione solo quella che “cura domani”.
E qui torniamo al ruolo sociale svolto da chi fa divulgazione.
La ricerca, in tutti gli ambiti del sapere, anche ovviamente quello umanistico, serve a renderci capaci di interrogare tutto ciò che ci circonda, a prepararci moralmente e intellettualmente alle risposte magari diverse da quelle attese, a spingere i nostri pensieri oltre ciò che a prima vista “ci sembra” (basti pensare a come era “trattato” l’Huntington solo un secolo fa), sviluppando un metodo di indagine condivisibile e controllabile, cioè che riproduca lo stesso risultato una volta date le stesse condizioni sperimentali, e su questa oggettività affinare la nostra capacità di convivenza sociale, nel frattempo sviluppando metodi sempre più efficaci per studiare ambiti inimmaginabili, e raggiungere obiettivi imprevedibili. I “prodotti” della scienza sono persino meno importanti e certamente meno duraturi della scienza, perché ogni giorno si aggiornano. Quello che resta per sempre è l’acquisizione di un metodo, l’allenamento al pensiero critico, al fallimento, la consapevolezza della conquista per tutti. Sono acquisizioni che diventano modo di vivere, e dei quali, una volta provati, non ne puoi più fare a meno. Ben poco di questo è di dominio pubblico. Non bisogna raccontare la sublimità delle scoperte e la loro “inavvicinabilità”, diceva il premio Nobel Ramon Cajal. Bisogna parlare degli uomini che le hanno condotte, della loro fatica, dei loro fallimenti, delle tante strade sbagliate. Si scoprirebbe così – scriveva – «che i grandi intellettuali, i grandi studiosi per quanto geniali possano essere, alla fine sono esseri umani, come tutti gli altri». Questo è per me lo scienziato. Credo che si debba raccontare questa scienza.

L’intervista alla senatrice a vita Elena Cattaneo prosegue su Left in edicola
SOMMARIO ACQUISTA








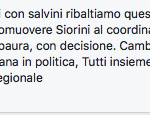

 In Italia, la campagna è stata immediatamente rilanciata dall’associazione per i diritti umani
In Italia, la campagna è stata immediatamente rilanciata dall’associazione per i diritti umani 






