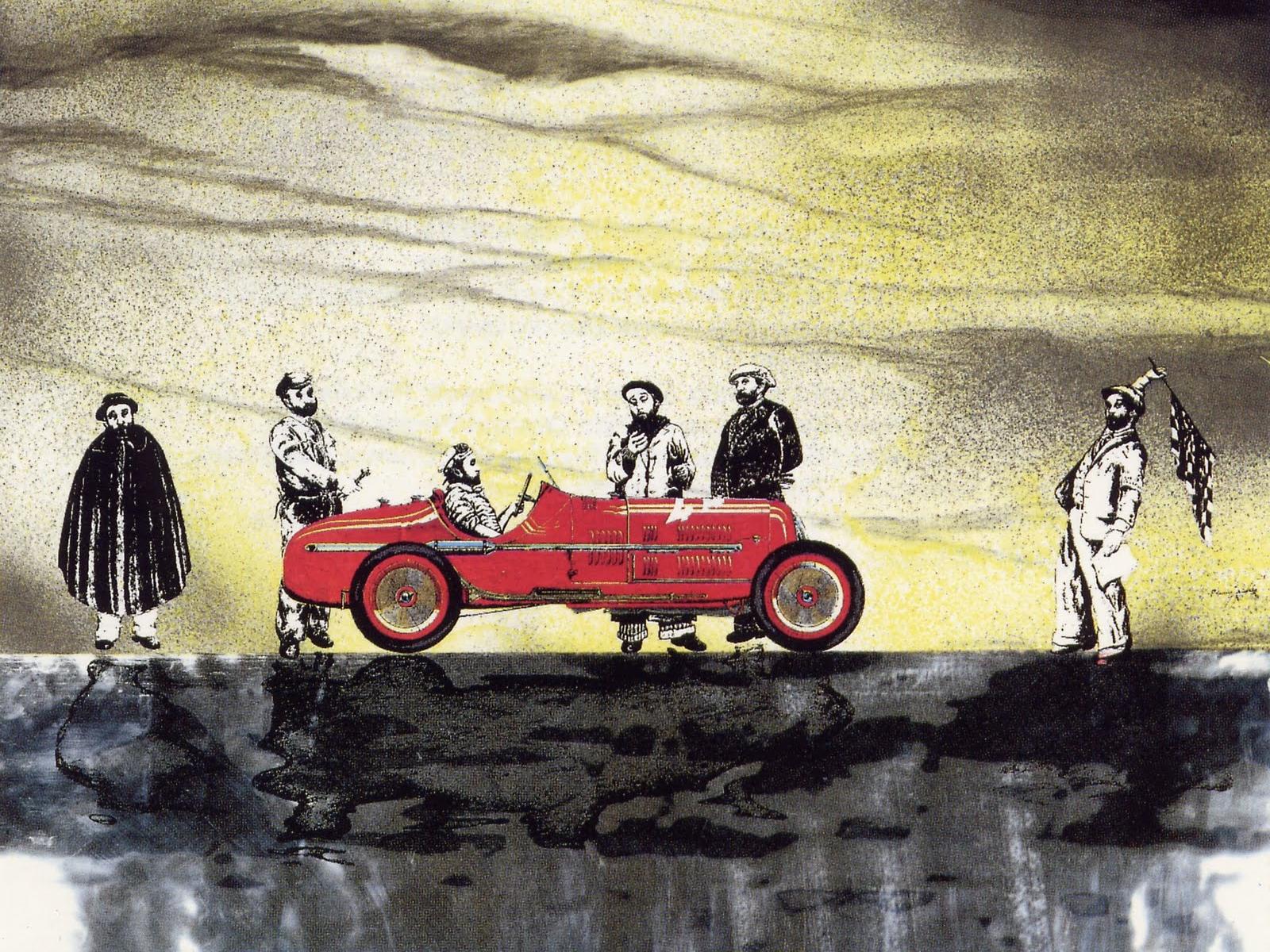In origine fu Paul Manafort. Poi venne Michael Flynn. Il capo della campagna elettorale di Donald Trump e il Consigliere per la sicurezza nazionale sono stati costretti alle dimissioni a causa delle loro relazioni nascoste con il governo russo. Che stavolta tocchi al Segretario alla Giustizia Jeff Sessions? La campagna presidenziale di Donald Trump era evidentemente ossessionata dalle relazioni con la Russia. O viceversa. Fatto sta che i contatti tra figure di primo piano della cerchia ristretta del presidente degli Stati Uniti e uomini del Cremlino hanno avuto contatti continui durante la campagna elettorale. Ad oggi sono sei le figure di cui abbiamo saputo.
L’ultimo in ordine di tempo è appunto Jeff Sessions, neo Segretario alla Giustizia, ovvero la figura che dovrebbe sovraintendere alle indagini relative all’hackeraggio, da parte russa, dei siti della campagna Clinton e del Democratic National Commitee nel corso della campagna elettorale. La novità, grave per Sessions, è che, oltre ad aver avuto quei contatti, non ne ha parlato durante le audizioni per la sua conferma in Senato. Di più, ha mentito. Nel video qui sotto il senatore democratico Al Franken chiede a Sessions: «Se nel suo nuovo incarico venisse a conoscenza di contatti tra il governo russo e la campagna Trump nel corso della scorsa campagna elettorale, cosa farebbe?». La risposta, con un fortissimo accento del Sud, è secca: «Senatore, come sa sono stato spesso definito un sostituto di Trump e non ho avuto alcuna notizia di contatti». Nel gennaio scorso a domanda scritta del senatore del Vermont Patrick J. Leahy «Ha avuto contatti, prima, dopo o durante la campagna elettorale con funzionari russi?». La risposta scritta è stata un inequivocabile «No».
[divider]Leggi anche:[/divider]
L’internazionale nera: tutti i legami tra Trump, Putin e la destra populista europea
La vicenda è importante per due ragioni. La prima riguarda la bugia detta in sede di audizione. Sessions ha mentito davanti alle telecamere e sotto giuramento. È un fatto molto grave. La seconda è più pratica: i democratici chiedono un procuratore speciale nominato apposta per indagare sulla vicenda, che ritengono essere di sicurezza nazionale. L’amministrazione e molti senatori, fino a ieri, hanno sostenuto che non c’è bisogno di nessuna indagine speciale e che l’Fbi può benissimo occuparsene. La cosa aveva già suscitato polemiche perché, a undici giorni dal voto dello scorso novembre, il Federal Bureau of Investigation aveva comunicato al Congresso con una lettera pubblica di aver riaperto le indagini sulle email di Hillary Clinton – allora ne erano state trovate nel computer di proprietà di Anthony Weiner, ex marito della aiutante di Hillary, Huma Abedin.
La cosa aveva destato scandalo perché la lettera sembrava chiaramente un missile terra-aria contro la candidata democratica. Probabilmente lo era. In queste settimane l’agenzia sta indagando sui contatti tra l’organizzazione di Trump e Mosca e non solo non trapela nulla, ma, in un’altra rottura con la prassi, il capo dello staff della Casa Bianca, Reince Priebus, è andato in televisione a smentire un articolo del New York Times nel quale si sosteneva che membri della campagna Trump avevano incontrato funzionari russi prima delle elezioni: «Sono stato autorizzato a dire che l’Fbi sa che quella storia non contiene dati veri, non c’è niente del genere». In questi giorni sono anche circolate voci secondo le quali l’amministrazione avrebbe fatto pressioni sull’agenzia federale affinché smentisse l’articolo del Times. Il caso è clamoroso anche perché l’Agenzia è indipendente e non deve e non può comunicare con l’amministrazione su indagini aperte. Specie se l’amministrazione stessa è coinvolta.
Non è la prima volta che Trump e il suo staff mentono sui contatti con la Russia. «Non ho niente a che fare con la Russia», aveva detto il 16 febbraio in conferenza stampa. Il Wall Street Journal aveva invece scritto di contatti con l’ambasciatore durante un ricevimento privato (il giorno dopo Trump propose la distensione con Mosca). A novembre, il vice ministro degli Esteri russo confermò che «c’erano stati contatti» tra la Russia e la squadra di Trump durante la campagna. E in una conferenza immobiliare del 2008, Donald Trump Jr. il figlio del presidente aveva parlato degli affari russi della Trump Organization. Poi, nelle settimane successive, molti membri dell’amministrazione hanno negato contatti venendo poi smentiti.
I democratici a questo punto, come fecero i repubblicani dopo l’attacco all’ambasciata libica a Benghazi. Diversi senatori e la leader alla Camera Nancy Pelosi ne hanno chiesto le dimissioni. Il senatore repubblicano Graham – che con McCain è quasi all’opposizione – ha detto che se ci fossero elementi sospetti in quegli incontri Sessions deve dimettersi.
Chi è Jeff Sessions, il senatore con simpatie per i suprematisti bianchi

Il primo nome era di quelli quasi certi di entrare nella futura amministrazione Trump: il senatore dell’Alabama Jeff Sessions, destinato al Dipartimento di Giustizia, è infatti tra i primi eletti a schierarsi con il miliardario durante le primarie. Tra i sostenitori del neo eletto presidente, Sessions è tra i pochi a poter dire di avere una qualche esperienza di governo e gestione delle cose a Washington, pur essendo un razzista.
Veterano dell’esercito, Sessions è un membro anziano del Comitato dei servizi armati del Senato. Da venti anni in Congresso, sappiamo già che l’audizione per la sua conferma in Senato sarà furiosa. Nel 1986, il senatore dell’Alabama, forse lo Stato più razzista di tutti, è diventato il secondo candidato giudice federale a non essere confermato del Senato a causa dei suoi commenti razzisti. Aveva chiamato “boy”, ragazzo, un procuratore afroamericano e dichiarato che «quelli del Ku Klux Klan mi andavano bene fino a quando non ho scoperto che fumavano marijuana».
Sessions ha sempre negato – ovviamente – di essere un razzista. Ma ha sostenuto che l’NAACP, la associazione che si batte per i diritti dei neri e la American Civil Liberties Union si possono definire “anti-americane”. Nel complesso un membro dell’estrema destra repubblicana delle peggiori in un posto delicato dopo che i democratici si erano impegnati a una riforma della polizia ed avevano aperto diverse inchieste federali sui casi di afroamericani uccisi da poliziotti.