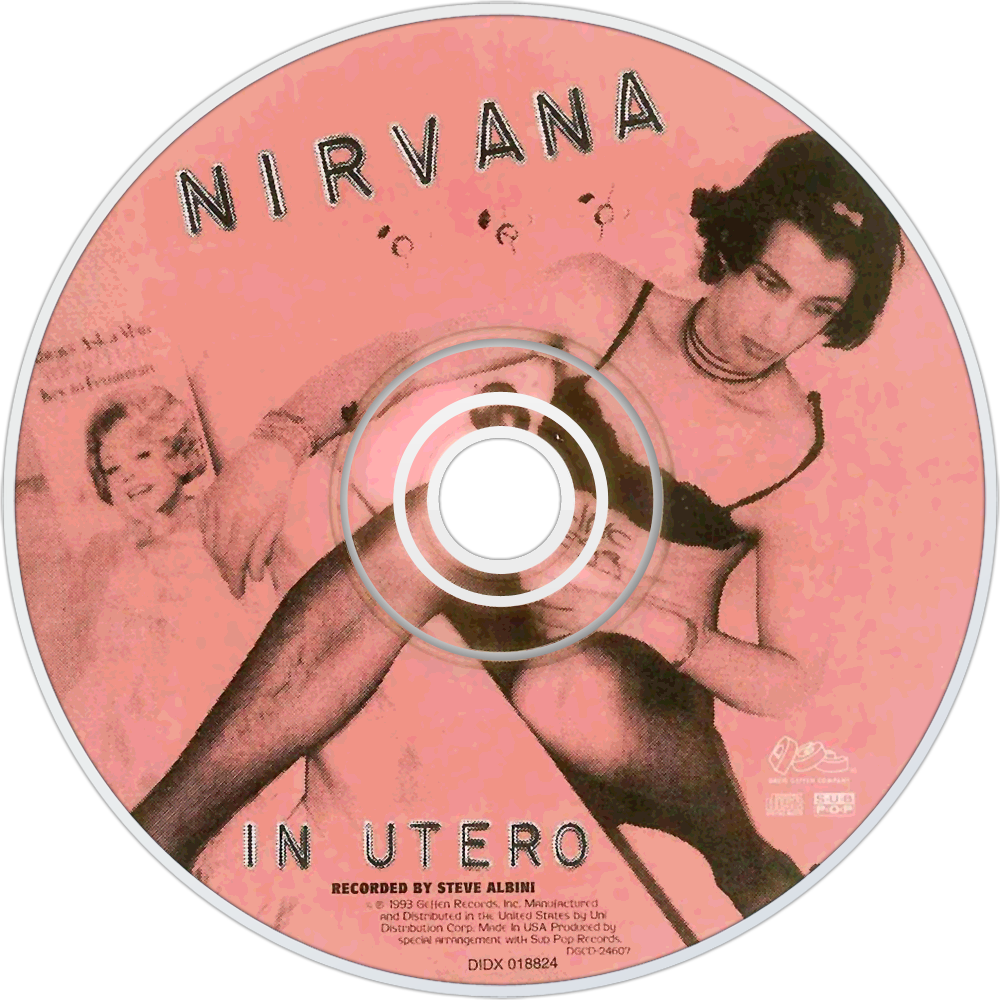Una scenografia povera, nella più brutta e angusta sala del Lingotto, niente filmato, qualche fotografia da Atlante De Agostini sullo sfondo, una colonna sonora minima». Curzio Maltese su Repubblica racconta così il discorso del Lingotto del 27 giugno 2007. Il candidato segretario Walter Veltroni, un po’ pallido e provato, pronuncia a braccio, come al solito in modo impeccabile, le parole che scandiscono il programma del Pd, il nuovo partito che aspira a essere maggioritario, “il partito del nuovo millennio”, la forza che unisce l’Italia, che ridà speranza ai giovani, che colma le diseguaglianze ma che non nega il mercato. Un partito in cui vale il principio “una testa, un voto”, in cui non ci devono essere «i difetti della politica preesistente, con i gruppi e le correnti chiuse in conflitto». «Non si comincia un nuovo viaggio con un equipaggio dilaniato da vecchi rancori e preoccupato di gettare dalla nave chi ad essa si affaccia la prima volta», ammonisce Veltroni, come se presagisse già nubi oscure sul partito che unificava i Ds eredi del Partito comunista e la Margherita, l’ala sinistra della Democrazia cristiana.
Esattamente nove anni dopo Walter Veltroni è di nuovo candidato, ma alla presidenza della Lega calcio. Detto così, sembra quasi uno scherzo o un delirio, ma invece è la realtà. Comunque l’impegno nel calcio per l’ex sindaco di Roma – dimessosi nel 2009 da segretario Pd dopo soli 21 mesi – viene per ultimo: prima si era dedicato alla letteratura, al cinema e alla televisione. E la nave Pd? Sempre nove anni dopo – è del 16 febbraio 2008 il Manifesto dei valori approvato dalla Costituente del Pd – naviga a vista, dopo la botta del referendum del 4 dicembre. E in certi giorni assomiglia al Bounty con gli ammutinati che minacciano scissioni. Che cosa è accaduto? Ma soprattutto che cosa è diventato il Partito democratico?
«Il partito adesso è decisamente in difficoltà perché son venute meno tutte le ipotesi che Renzi avrebbe voluto consolidare attraverso la riforma costituzionale in cui veniva enfatizzato il ruolo del leader», sottolinea il politologo Piero Ignazi. A questo punto, ridotta o sfumata l’ipotesi di cambiamento nel senso renziano, «quella parte del partito che ha seguito più o meno convintamente o coralmente l’impostazione di Matteo Renzi si trova spiazzata, così come lo stesso Renzi del resto», continua Ignazi. La sconfitta al referendum costituzionale, alla distanza, sembra incidere più di quanto non sembrasse al momento, quando il 40 per cento dei Sì veniva sbandierato come un risultato ad appannaggio del solo Pd. L’“implosione” nel partito invece comincia ad avanzare, con una forte impennata dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell’Italicum, la “legge elettorale migliore del mondo”. Ma Renzi si è davvero occupato del partito? «Per nulla», risponde lapidario Ignazi. A tal punto che oggi il Pd secondo lo storico contemporaneo Giovanni De Luna «è una creatura anomala, cresciuta in maniera anomala e adesso che è cresciuta, lo è diventata ancora di più. Una coalizione di feudi tenuti insieme dal potere. Un partito si definisce attraverso un programma, un’identità. Questi non hanno una storia alle spalle: alle primarie del 2012 i candidati segretari citavano nel loro pantheon da Mandela a Papa Giovanni, senza alcuna radice con la tradizione della sinistra italiana.
Questa mancanza di un passato e di un profilo culturale unitario, fa sì che il Pd sia un coacervo di istanze, alcune sono anche positive, ma altre proprio non c’entrano. Credo che a sinistra non ci sia mai stato niente di simile al Pd di oggi» dice amareggiato De Luna. Il “coacervo” si manifestò nel novembre 2013: alle primarie per i segretari provinciali esplosero scandali su scandali a proposito di tessere gonfiate, iscritti fantasma e capibastone che dettavano legge nei territori. Non fu proprio un’immagine edificante. La ricorda un altro storico contemporaneo, Guido Crainz: «Per me quella è stata una fotografia indicativa del Partito democratico. Mentre per le primarie a segretario c’era stata una partecipazione di massa incredibile e un plebiscito per Renzi, quelle fanno molto riflettere». E dopo? «Una volta eletto segretario, Renzi dichiarò di voler cambiare la politica e il Pd, sapeva in modo chiaro che questo era necessario, ma non è stato fatto nulla». Per Crainz questa rinuncia «è stato il fallimento di Renzi, ancor prima della sconfitta alle amministrative del 2015 e del 2016».
L’incapacità di proporre una classe dirigente alternativa però non è solo responsabilità dell’ex premier. «È un fallimento che ha ereditato dal passato, questo è il punto – continua -. Renzi aveva avviato una inversione di tendenza ma il voler agire solo dal punto di vista del governo si è rivelata un’illusione di cambiare la realtà. Non si fa scuola di formazione con i comizi domenicali, è un processo di lungo periodo che significa capacità di amministrare, conoscenza delle regole del gioco». Questa incapacità di formazione della classe dirigente ancor prima della selezione attraversa tutto il Pd. Nel racconto dello storico compaiono alcuni episodi, dalla “non vittoria” di Bersani nel 2013, «frutto dei guasti precedenti» giù giù fino ad arrivare alla deriva dell’Ulivo la coalizione guidata da Romano Prodi che nel 1996 fece vincere il centrosinistra per la prima volta nella sua storia.
Durò solo due anni il governo del professore bolognese, affondato per un voto alla Camera dopo il ritiro dell’appoggio esterno di Rifondazione comunista. Poi presero le redini di Palazzo Chigi D’Alema e Amato. Ma nel marzo 1997 al castello di Gargonza, tra i boschi della Toscana, era andato in scena un incontro che potrebbe considerarsi il nucleo primordiale del Pd. E non andò proprio bene. Il tentativo era quello di allargare la coalizione alla società civile. “Dieci idee per l’Ulivo”, il tema del seminario, con la partecipazione di 10 ministri del governo Prodi, dei leader dell’Ulivo (mancavano solo gli esterni Bertinotti e Dini) e di uno stuolo di intellettuali come, tra gli altri, Luciano Berio, Elvira Sellerio, Paolo Flores d’Arcais, Luigi Nono e Umberto Eco. Quest’ultimo rimase molto colpito dall’atteggiamento di Massimo D’Alema. Lo ha ricordato lo stesso Eco su Alfabeta2 nel 2011, lo cita anche Crainz ne Il Paese reale (Donzelli, 2012). Di fronte alla prospettiva di un coinvolgimento della società civile, D’Alema rivendica il valore della politica “professionale”: «Noi non siamo la società civile contro i partiti. Noi siamo i partiti». E ancora: «L’idea che si possa eliminare la politica come ramo specialistico per restituirla tout court ai cittadini è un mito estremista che ha prodotto o dittature sanguinarie o Berlusconi». Per Eco l’uscita di D’Alema fu «la credenza che un appello alla società civile significasse un appello all’assemblearismo sessantottesco e quindi a una deriva extraparlamentare oppure a una forma di berlusconismo». Crainz nel suo saggio la interpreta come «una vera doccia fredda per chi aspirava a un rinnovamento profondo». La società civile allora – ed eravamo negli anni post Mani pulite – venne respinta da un arroccamento della politica, troppo miope di fronte alla realtà.
Fatto sta che poi il processo innescato nel centrosinistra rallenta, dopo la vittoria del centrodestra nel 2001. Prodi intanto vola alla Commissione Ue che introduce l’Euro, con tutte le conseguenze che ne seguirono.
Dieci anni dopo, nel 2007, dopo una vittoria risicata alle politiche del 2006 della nuova coalizione di centrosinistra, l’Unione, si rompe ogni indugio e inizia l’unificazione dei Ds e Margherita. Fu una scelta opportunistica? Una fusione a freddo? «Credo che sia stata una scelta molto opportunistica – risponde De Luna -. Quando decisero di mettersi insieme Margherita e Ds potevano scegliersi degli antenati, in quale ambito collocarsi. De Gasperi o Togliatti, per esempio, che rispondevano alle loro tradizioni. Ma invece hanno fatto il corto circuito, dicevano “noi siamo nati post, nessuno della nostra generazione sa chi siano quei due”. Non è una questione di lana caprina, scegliersi degli antenati significa definirsi un profilo identitario, rinunciare a scegliere significa accettare di essere un coacervo di spinte diverse e a volte contraddittorie», conclude De Luna. Anche per Crainz quella fusione risulta da «una somma dei partiti precedenti» con una prima fase in cui ognuno è molto guardingo nei confronti dell’altro al punto che prima della riunione comune gli ex Dc e gli ex Pci si ritrovavano ognuno per contro proprio.
Fatto il Pd bisognava fare i piddini, spiega Piero Ignazi. «Quello che caratterizza il Partito democratico non fu tanto una nascita improvvisata quanto una mancata volontà di trovare una identità». Forse anche il crollo del secondo governo Prodi e la sconfitta alle elezioni del 2008 determinarono una battuta d’arresto, ma nemmeno il 2011 con la grande stagione dei sindaci arancioni, i movimenti collettivi come Se non ora quando o i comitati per l’acqua pubblica riuscirono a innescare un movimento, una ricerca politica all’interno del partito democratico che rimase ancora una volta sordo alla società civile. Testimone entusiasta della vittoria di Giuliano Pisapia a Milano, Umberto Eco nel 2011 si augurava sempre su Alfabeta 2 che il tempo perduto da quel lontano 1997 fosse finalmente riannodato, altrimenti, scriveva, andranno sprecati i prossimi quindici anni… Poi venne il governo Monti e stare obtorto collo sotto lo stesso tetto con il centrodestra mentre si decidevano scelte inique come la legge Fornero o il pareggio in bilancio, ingessò il Partito democratico, spalancando le porte al trionfo del M5s del 2013 e, appunto, alla “non vittoria” di Bersani. Se i luoghi hanno un significato, nel giorno della chiusura della campagna elettorale a Roma, mentre Grillo parlava in una piazza San Giovanni affollatissima, Bersani si era rifugiato al teatro Ambra Jovinelli tra vecchi militanti e un Nanni Moretti che non era più quello dei girotondi quando incalzava D’Alema con il celebre “Di’ qualcosa di sinistra”.
Il resto è storia nota. Ma tornando alle origini, tra le parole chiave del Pd c’erano “libertà e dignità”. Di fronte alla politica economica del governo Renzi che ha cancellato l’articolo 18 e ha codificato il lavoro precario con il Jobs act, oppure di fronte alla Buona scuola che ha impoverito l’istruzione pubblica, che ne è di una forza di sinistra che dieci anni fa, in piena crisi economica, ci teneva a presentarsi attenta alle fasce più deboli? «Da allora il Pd ha perso molte cose, non sa bene dove andare – dice Ignazi -. È stato un po’ preda dell’idea che doveva dimostrare di essere un bravo partito riformatore e una specie di costola sinistra del mainstream liberale. Questo è stato veramente il disastro». Il politologo ricorda ancora oggi un video in cui il premier in maniche di camicia irrideva i sindacati. «Oggi si sta facendo una precipitosa marcia indietro – fa notare – sia con i voucher che con la scuola. Finalmente ci si rende conto che una forza di sinistra deve avere un dialogo anche se critico con i sindacati». “Ma abbiamo fatto le unioni civili”, è il mantra del Pd renziano. È vero, non c’era riuscito nessuno prima, nei due governi Prodi, per esempio. Ma dall’aver prodotto una norma che riconosce le coppie di fatto (anche per gli omosessuali) al passare tout court per paladini dei diritti civili, ce ne corre. Le molte leggi “incompiute” che giacciono in un cassetto ne sono una prova. Come quella sul testamento biologico che ancora arranca in aula ma in una forma depotenziata, oppure quella sulla cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati nel nostro Paese. Era un cavallo di battaglia di Bersani nella campagna elettorale del 2013, quella dell’Italia bene comune. Nonostante interessi oltre un milione di minori, italiani a tutti gli effetti, è rimasta lettera morta, ferma al Senato. Il sospetto rimane lo stesso: concedere alcune libertà non ha preoccupato troppo il Pd, realizzare l’uguaglianza di tutti, Sì.
(la versione originale di questo articolo è stata pubblicata su Left n.6 dell’11 febbraio)