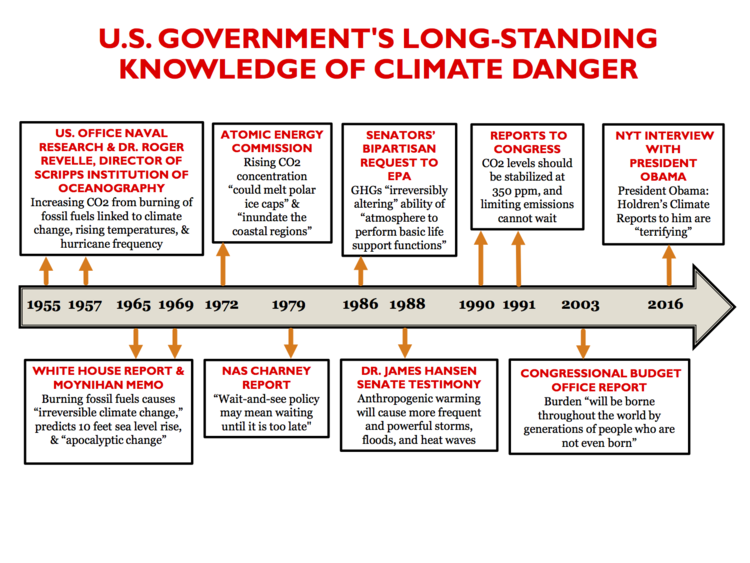La amministrazione Trump comincia a prendere forma. Una brutta forma. Se ci sono ancora speranze che per quanto riguarda la politica estera il neo presidente scelga qualche figura autorevole e minimamente equilibrata – in agenda c’è un incontro con Mitt Romney, suo arcinemico in campagna elettorale – i primi nomi sono pessimi. E confermano l’idea che Trump preferisca circondarsi di fedelissimi e non di figure capaci – quando si vince un’elezione, si cerca, nel proprio partito, la gente migliore, non solo quella ideologicamente affine.
Il primo nome era di quelli quasi certi di entrare nella futura amministrazione Trump: il senatore dell’Alabama Jeff Sessions, destinato al Dipartimento di Giustizia, è infatti tra i primi eletti a schierarsi con il miliardario durante le primarie. Tra i sostenitori del neo eletto presidente, Sessions è tra i pochi a poter dire di avere una qualche esperienza di governo e gestione delle cose a Washington, pur essendo un razzista.
Veterano dell’esercito, Sessions è un membro anziano del Comitato dei servizi armati del Senato. Da venti anni in Congresso, sappiamo già che l’audizione per la sua conferma in Senato sarà furiosa. Nel 1986, il senatore dell’Alabama, forse lo Stato più razzista di tutti, è diventato il secondo candidato giudice federale a non essere confermato del Senato a causa dei suoi commenti razzisti. Aveva chiamato “boy”, ragazzo, un procuratore afroamericano e dichiarato che «quelli del Ku Klux Klan mi andavano bene fino a quando non ho scoperto che fumavano marijuana».
Sessions ha sempre negato – ovviamente – di essere un razzista. Ma ha sostenuto che l’NAACP, la associazione che si batte per i diritti dei neri e la American Civil Liberties Union si possono definire “anti-americane”. Nel complesso un membro dell’estrema destra repubblicana delle peggiori in un posto delicato dopo che i democratici si erano impegnati a una riforma della polizia ed avevano aperto diverse inchieste federali sui casi di afroamericani uccisi da poliziotti.
Mike Pompeo, 52 anni, diventerà invece direttore della CIA. Eletto in Congresso nel 2010 durante la rivolta del Tea Party è un critico virulento dell’accordo con l’Iran e ha sostenuto che tutti i musulmani sono potenzialmente complici degli attacchi terroristici. Non solo, ha definito un fuorilegge Snowden ed era parte dell’inutile commissione su Bengasi che ha interrogato Clinton per due volte.
Il consigliere per la sicurezza nazionale sarà invece il generale in pensione Michael Flynn ex direttore della Defense Intelligence Agency dalla quale venne licenziato nel 2010 in circostanze poco chiare. Lui ha sostenuto che la sua linea dura contro l’Isis non piacesse alle mammolette della Casa Bianca. Molti parlano di una gestione caotica e di maltrattamenti al personale. In una mail uscita via Wikileaks, l’ex Segretario di Stato e generale Collin Powell scrive: «Ho parlato con gente della DIA…mi hanno detto che maltrattava lo staff, lavorava contro le indicazioni dell’amministrazione e gestiva male. Dopo di allora è diventato una specie di strano personaggio destrorso». Flynn ha sostenuto la vicinanza con la Russia contro l’Isis e al Nusra e, tra le altre cose, consigliato via twitter il libro del suprematista bianco Mike Cernovich, uno dei membri del movimento di destra alt-right (ne parleremo domenica su questo sito).
PS: In questi dieci giorni dalle elezioni gli incidenti razzisti di vario ordine e grado sono aumentati a dismisura, segnala il Southern Poverty Law Center. Le nomine non contribuiranno a calmare il clima.