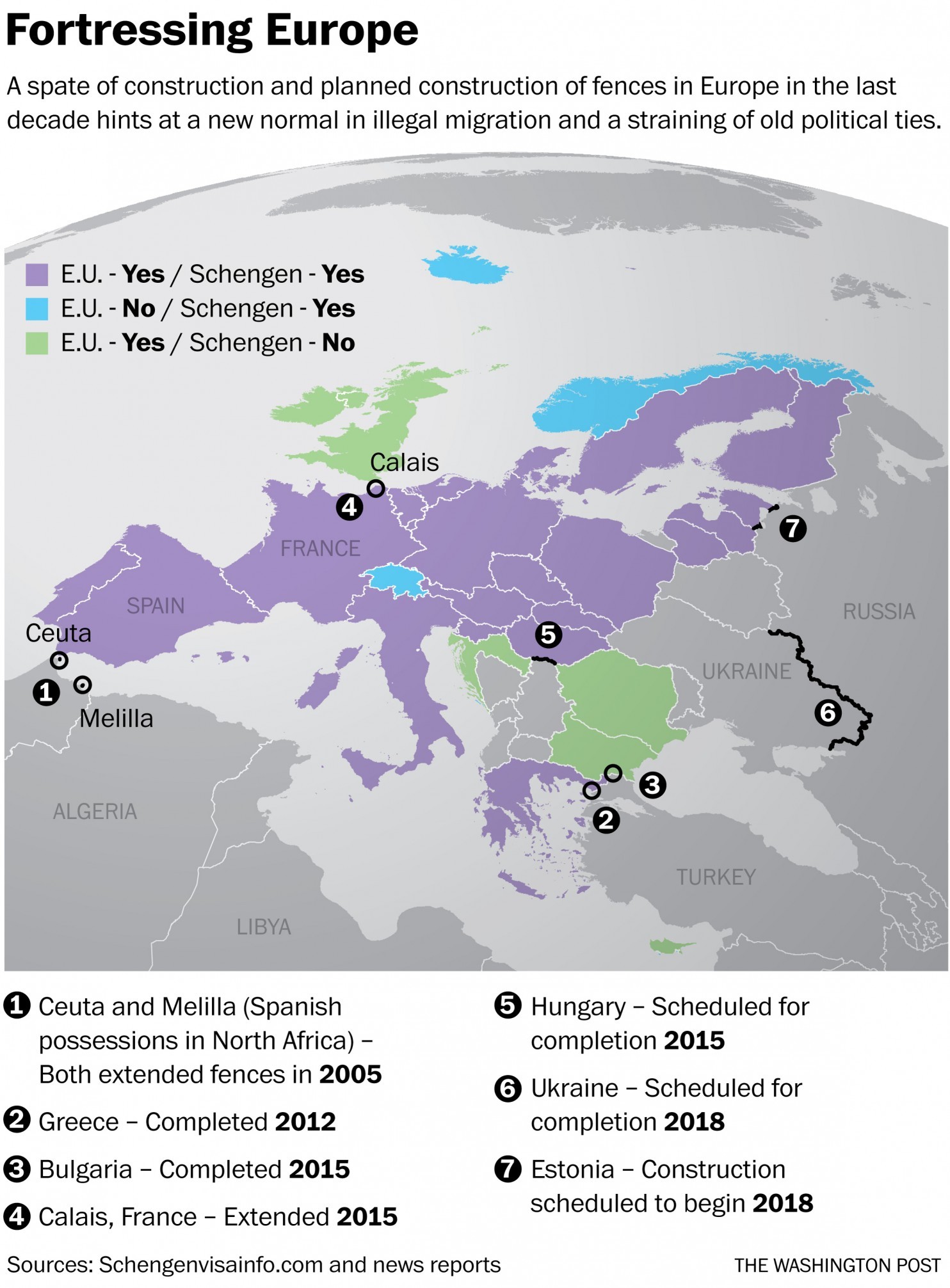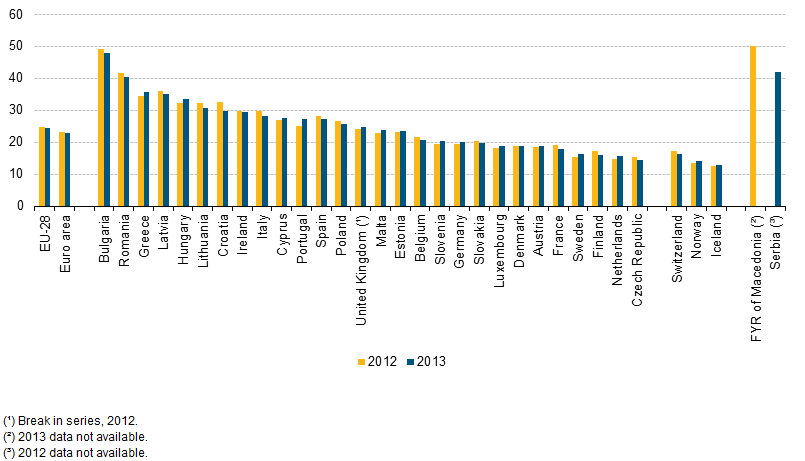La desaparición non è soltanto un ricordo del passato. Messico, 2015. Corpi disintegrati si ammucchiano nella Valle Bonito. Per dire “sciogliere” i corpi nell’acido i narcos scelgono un verbo che non richiama affatto la paura: pozolear, come cucinare pozole, la zuppa a base di mais con pollo. Ma nel gergo dei narcotrafficanti pozolear indica l’azione precisa con cui si disintegrano i corpi già inermi. A Valle Bonito come in molti altri luoghi pieni zeppi di corpi, se provi a interrare una delle croci in terra vedi uscire un liquido vischioso e rossastro, e capisci che «sono esseri umani mescolati insieme dopo essere stati disciolti nell’acido», racconta a Left Fernando, padre di un desaparecido. I periti non possono neanche più recuperare il Dna dei desaparecidos. Per questo Guadalupe, altro padre in cerca del figlio scomparso, chiede «che questo posto si trasformi in mausoleo».
Siamo lontani anni luce dal paradiso delle spiagge caraibiche e dalla culla della cultura Maya. Qui ci sono posti in cui non è più possibile neanche camminare. Come Guerrero, nel nordest, uno dei 32 Stati che compongono la Repubblica federale messicana, dove il 26 settembre di un anno fa 43 studenti di una scuola rurale sono scomparsi perché manifestavano per avere una mensa scolastica e libri su cui studiare. Una tragedia che ha segnato un prima e un dopo nella storia di violenza che attraversa il Paese dal 2006, da allora si vive nella consapevolezza che a scomparire può essere chiunque: un ingegnere, un giornalista, il tuo compagno di banco.
#Mexiconosurge è un appello promosso in reazione alla morte e sparizione dei giornalisti che denunciano la collusione tra criminali e autorità politiche e di polizia. Ne parliamo qui
Per questo si tenta di reagire: in ogni Stato sorge una sede di Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos (Fuundec), un’organizzazione fondata dai familiari delle vittime di sparizioni forzate. Dove l’aggettivo “forzate” vuole evidenziare le responsabilità dello Stato, che agisce spesso in collusione col crimine organizzato, permettendo che si facciano sparire le persone o dando sostegno logistico e operativo. Quello che chiedono i familiari è che i loro cari non scompaiano per la seconda volta: nell’inefficienza e nel silenzio delle istituzioni. «Non a caso sono proprio i familiari delle vittime che iniziano le indagini», spiega Fernando F. Coronado Franco, che ha dato vita alla sede di Fuundec nello Stato di Coahuila, ai confini col Texas. «Cercano prove, raccolgono dati e testimonianze, rifiutano la versione ufficiale secondo cui quelli che scompaiono o vengono uccisi fanno parte del crimine organizzato e quindi “un po’ se lo meritavano”». La maggior parte degli scomparsi negli ultimi due anni sono persone che possedevano competenze informatiche: elettricisti, ingegneri informatici, o persone che conoscono più di una lingua. «Questo ci fa ipotizzare che i gruppi criminali organizzano una rete parallela di comunicazione e che hanno bisogno di professionalità differenti», prosegue Fernando. «Si procacciano manodopera a costo zero, per poi disfarsene quando non gli è più utile».
L’escalation di violenza affonda le sue radici nel quinquennio 2006-2011, durante la presidenza di George W. Bush negli Usa e di Felipe Calderón in Messico, quando si diede il via al Plan México: un programma da 400 milioni di dollari per la lotta al narcotraffico. Una parte dei fondi dovevano andare alle associazioni che lavoravano in difesa dei diritti umani, ma non sono mai stati assegnati. E nello stesso buco nero sono scomparse le risorse previste per lo sviluppo economico e il miglioramento delle infrastrutture. Mentre il punto centrale della strategia, la militarizzazione della frontiera Messico-Stati Uniti, ha comportato l’aumento del 200% della violenza.

(Mauro Pagnano)
Giornalisti e ricercatori provano a raccontare cosa succede in Messico. Come Temoris Greko, giornalista di Città del Messico, che è riuscito a entrare a Chilapa, uno dei villaggi principali di Guerrero dove, racconta, «dopo l’uccisione dei 43 studenti, solo da settembre a giugno, mese delle elezioni locali, sono state uccise più persone che in tutto il 2014». Temoris sottolinea un dato fondamentale: «Stiamo assistendo non solo a un incremento quantitativo, ma soprattutto a un cambiamento qualitativo della violenza. Le forme e i metodi con cui assassinano le persone diventano sempre più feroci». Se prima venivano uccise e appese ai ponti, ora i loro volti sono prima sfigurati, poi avvolti da un panno stretto con una corda intorno la testa, lanciati e lasciati ai bordi delle strade, nelle città così come lungo le autostrade. Così las matanzas immobilizzano nel terrore la popolazione, mentre «da parte dello Stato c’è una totale incapacità di controllare la situazione», riprende il giornalista. «Chilapa è stata occupata per una settimana da un gruppo di contadini mobilitati da un cartello di narcotrafficanti, Los Ardillos, che contende a Los Rojos il controllo del territorio.
Casa dopo casa facevano irruzione alla ricerca di potenziali affiliati al gruppo nemico. Alla fine dell’assedio, si sono contate 30 persone scomparse e quattro corpi sfigurati. Polizia ed esercito c’erano, ma non sono stati capaci di frenare l’occupazione». Una situazione fuori controllo in cui le responsabilità sono chiare. «Non c’è volontà politica. Da un lato è come se le istituzioni si fossero arrese, dall’altro molti di questi gruppi godono dell’appoggio diretto dello Stato», denuncia Greko. «I capi di Los Ardillos, Celso e Antonio Ortega Jiménez, sono i fratelli di Bernardo Ortega, attuale presidente del Congresso dello Stato di Guerrero».
La frontiera tra legalità e illegalità, tra Stato di diritto e criminalità organizzata, è saltata. La giornalista Alma Guillermoprieto, inviata di Newsweek in Sudamerica, ha analizzato a fondo i rapporti tra criminalità e politica in Messico, disegnando una geografia a “macchia di leopardo” del territorio, in cui ogni cártel funziona come una cellula che stabilisce zona di controllo diretto o indiretto, crea alleanze orizzontali con le comunità, costruisce reti di comunicazione “affidabili” e stabilisce strategie e pratiche seguendo una logica di militarizzazione. Le cellule devono saper essere autonome, auotorigenerarsi, assumere differenti dimensioni a seconda delle circostanze, ma non devono mai dissolversi. In un solo decennio hanno così dato vita a un corpo\cártel che ha invaso, fino ad assorbire, tutto un Paese: le macchie di leopardo si sono dilatate e ampliate all’infinito. Non si può più parlare di stati di eccezione, ma di zone di impunità che si espandono e svuotano di legittimità l’ordine istituzionale vigente.

(Mauro Pagnano)
Non ci sono statistiche precise di quante fosse comuni a cielo aperto ci siano oggi in Messico, ma un dato è certo: la Procuraduría General de la República, sotto l’incalzare delle richieste di Amnesty International, ha ammesso che dal primo ottobre 2014 si sono scoperte 60 fosse comuni nel solo Stato di Guerrero, con i resti di almeno 129 persone.
Usare l’arma della desaparición nel 2015 significa creare un clima di paura sotterranea, in cui non si vede nulla ma si sente tutto. Non si vedono i corpi, non si possono seppellire i morti, non si può denunciare il delitto. Per il giornalista e scrittore Sergio Gonzalez Rodriguez lo scenario è cambiato drammaticamente a partire dal 2012, «con la vittoria alle elezioni presidenziali del Partito rivoluzionario istituzionale del giovane e telegenico presidente Enrique Peña Nieto, da allora viviamo in un andirivieni tra realtà e fantasia: se da un lato il Paese reale non cambia, dall’altro si costruisce a livello comunicativo una terra promessa che vedrà trasformazioni straordinarie». Secondo le stime ufficiali, negli ultimi anni sono scomparsi più di 25.700 persone, quasi la metà dal 2012 a oggi, ovvero durante la presidenza di Enrique Peña Nieto.
In Messico i dati sono un’arma politica: se un fenomeno non si registra, non esiste. E tra i desaparecidos ci sono alcuni più vulnerabili di altri, come i migranti che attraversano il Paese per raggiungere gli Usa. L’Instituto nacional de migración ha riconosciuto che a oggi i casi di persone migranti desaparecidas sono 1.681. Nel 90% dei casi non se ne conosce la nazionalità, ma in gran parte sono messicani. Perciò, Amnistía internacional en América per voce della direttrice generale Erika Guevara-Rosas chiede «l’urgente creazione di un database con il Dna e un registro degli scomparsi».

(Mauro Pagnano)
«La tortura e la desaparición forzada sono gli strumenti scelti per limitare il flusso migratorio», dice Rosy, portavoce delle 45 donne che hanno dato vita alla Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes, partita da Città del Guatemala per arrivare in Messico e dire che ci sono migliaia di desaparecidos in Centroamerica che non devono essere dimenticati. «Non è più un problema di crimine organizzato ma di crimini autorizzati, perché le stesse autorità statali sono coinvolte. Se non hai sufficiente denaro per pagare i polleros (che organizzano e gesticono i viaggi dei migranti) o il ricatto di pubblici ufficiali, il rischio è di ritrovarli in una delle tante fosse comuni a cielo aperto».
Una costellazione sempre più forte di movimenti sociali, associazioni, giornalisti, studenti e accademici, tenta costantemente di ricomporre un corpo sociale che rischia la deflagrazione. In prima fila, le donne che dalla fine degli anni Novanta lottano contro i femminicidi, ennesima versione di desaparición da queste parti. Secondo molte organizzazioni civili, fra cui Nuestras Hijas de Regreso a Casa, prima ong nata per difendere le donne vittime di femminicidio, le tecniche messe in campo contro la sparizione e l’uccisione delle donne a Ciudad de Juarez, sulla frontiera Usa-Messico, sono le stesse messe in campo per silenziare la denuncia e la risoluzioni degli episodi di desaparición di oggi. Anche in questi casi si ritrovano dati manipolati, prove fatte scomparire direttamente dagli archivi della polizia, capri espiatori per deviare indagini importanti. E, soprattutto, le tecniche di tortura usate contro i corpi delle donne sono quelle riscontrate in molte vittime. In Messico si dice todo pasa, pero todo se queda, tutto passa ma tutto rimane. Tutto brucia, ma la puzza resta.

Questo reportage e il fotoreportage che lo accompagna è tratto dal numero 33 di Left, in edicola da sabato 29 agosto e acquistabile online qui