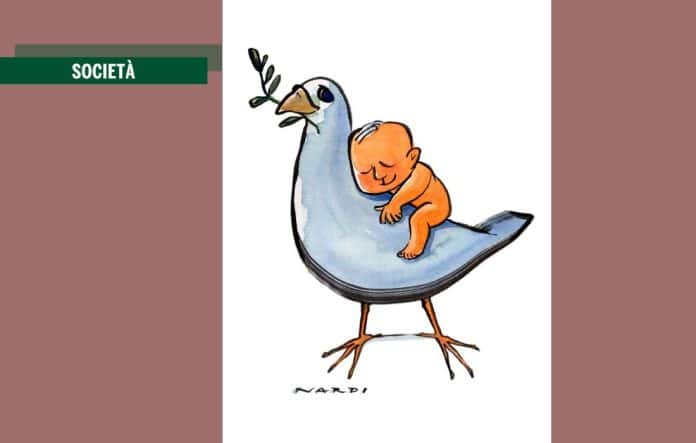Henry Moore e le piccole Veneri, arte e identità umana è l’ultima opera di Francesca Borruso, un libro bellissimo, frutto di una lunga e appassionata ricerca. Esso nasce dal contrappunto di tre temi: l’arte paleolitica in particolar modo quella mobiliare, la biografia e le opere di Moore e infine, la teoria della nascita e la concezione dell’identità umana di Massimo Fagioli. Il risultato è un intreccio virtuoso, una narrazione avvincente e convincente «che risuona e ci riempie» come ha detto qualcuno. Nel dicembre del 2019 fu dato alle stampe il saggio di Francesca Borruso edito dalla casa Editrice Espera, specializzata in tematiche legate all’archeologia. Recentemente è uscita una traduzione inglese frutto dell’ottimo lavoro di Marcella Matrone grazie anche all’interessamento della Fondazione Henry Moore. Uno dei temi che colpiscono maggiormente nel libro è quello dell’idiosincrasia mostrata dallo scultore inglese per i critici che da giornali, come il Morning Post nel 1929 lo avevano attaccato pesantemente definendo le sue opere «revolting» cioè immorali e disgustose: la sua colpa, oltre al “bolscevismo” sarebbe stata quella di aver scolpito una statua in un blocco di cemento dal titolo Sucking child nella quale per la prima volta nella storia dell’arte il protagonista assoluto era il lattante. Lo scultore era molto diffidente non solo nei confronti di artisti che parlano troppo di sé stessi in termini razionali ma anche di una critica fatta solo di parole vuote da parte di persone senza sensibilità artistica. Comunque Moore era abilissimo nell’uso del linguaggio e della comunicazione, come affermò la figlia: lo testimoniano i suoi interventi teorici e critici che coprono più di trecento pagine. Le sue analisi artistiche toccano vertici insuperabili come quelle sull’opera di Giovanni Pisano o sulla Pietà Rondanini di Michelangelo.
La sinistra e l’identità delle donne
Illustrazione di Fabio Magnasciutti
La sinistra saprà rispondere in maniera efficace alla sfida culturale che propone la destra con la formula Dio, Patria e Famiglia? È possibile immaginare un mondo che condivida le risorse, e con rapporti sociali non basati sulla sopraffazione e la violenza: quest’ultima deve essere considerata una componente inevitabile degli esseri umani? In un periodo storico complesso come questo che stiamo vivendo, con forze che spingono per un cambiamento contro governi teocratici, come succede in Iran e in tutto il Medio oriente, ma anche con focolai di guerra che si aprono in più punti, è importante che la sinistra abbia la forza di proporre una cultura nuova, un modo di vivere i rapporti umani senza crudeltà e prevaricazioni fisiche e psichiche. Sono le nuove generazioni a chiedere questo cambiamento e lo vediamo nelle piazze e sui social. Nei regimi teocratici, per definizione non democratici, sono soprattutto le donne a rischiare la propria vita, se si ribellano alle autorità religiose che le vogliono schiave degli uomini e senza alcun diritto né umano né civile. Sono donne senza volto, che spesso perdono definitivamente la loro vita, se osano affermare la propria identità. Possiamo proporre ancora alle nuove generazioni una cultura avvelenata dalla violenza e dalla intolleranza? È questa la verità e il pensiero dell’essere umano? Considerazioni e domande che è impossibile non fare e non porsi, in un momento storico durante il quale teniamo il fiato sospeso per il timore dell’espansione delle guerre.
Dobbiamo cercare l’origine culturale di un pensiero, che strutturato sulla razionalità, vede solo la sopraffazione e la logica della vendetta, dell’occhio per occhio, l’unica legge che governa la socialità.
Far risalire i salari nell’Europa diseguale
La pandemia da CoVid-19, con i suoi drammatici impatti su salute, economia, società e politica, ha costretto l’establishment politico europeo a rivedere drasticamente le sue posizioni in materia di intervento degli Stati nazionali e dell’Unione europea in campo economico e sociale. Un cambiamento che non ha solo prodotto un aumento dei deficit nazionali, il programma Sure, (un regime paneuropeo temporaneo di sussidi contro la disoccupazione da 100 miliardi di euro) e il Next generation Ue (da 750 miliardi di euro), ma ha anche momentaneamente rimesso al centro della politica della Commissione e del Parlamento europeo il Pilastro europeo dei diritti sociali (approvato dai capi di governo al vertice del novembre 2017 a Göteborg) per costruire «un’Europa sociale» (auspicata da Jacques Delors per promuovere la solidarietà transnazionale fra i popoli e favorire la convergenza), portando la Commissione ad elaborare numerose direttive e un Piano d’azione discusso nel vertice sociale di Porto del 7 maggio 2021. La pandemia aveva dunque aperto un possibile processo di revisione delle regole della governance economica che sembrava essere diretto ad assicurare una «crescita economica inclusiva e sostenibile» (in linea con gli articoli 2 e 3 del Trattato di funzionamento Ue), superando il dogma neoliberista dell’austerità.
«Le sentenze della Cassazione sul salario minimo: il ritorno ai principi inderogabili»
Con Giuseppe Bronzini, già presidente della sezione lavoro della Corte di Cassazione e segretario generale del Movimento europeo, approfondiamo il tema delle sentenze della Suprema Corte in merito ai “salari indecenti”, come li ha definiti in un suo recente saggio su LavoroDirittiEuropa.
Dottor Bronzini, le 4 sentenze della Cassazione sul salario minimo costituzionale rappresentano una svolta storica dal punto di vista del diritto del lavoro?
Secondo me sì, perché prima la giurisprudenza era molto rispettosa della contrattazione collettiva e tendeva a valorizzare i contratti, ad estenderne l’applicazione, non ad annullarli. Sappiamo che non c’è l’erga omnes, il Ccnl vincola solo gli aderenti alle associazioni che l’hanno stipulato. Quindi la precedente giurisprudenza della Cassazione tendeva ad applicare il Ccnl anche quando le parti non avessero stabilito uno specifico contratto, oppure quando era applicato un contratto inidoneo, tale da non garantire la sufficienza della retribuzione e tendeva a sceglierne un altro. Con queste sentenze in sostanza viene dichiarata la nullità dei contratti anche se sono stati stipulati dai sindacati più rappresentativi. E in tutti e 4 i casi i sindacati erano quelli, si dice, comparativamente più rappresentativi, il giudice dichiara la nullità dei contratti e poi dovrebbe integrare i trattamenti minimi scegliendo una serie di parametri.
Il prezzo di una vita libera e dignitosa
Negli ultimi mesi si è parlato molto del salario minimo che in Italia è stato argomento tabù per molto tempo, nonostante gli allarmi lanciati via via negli anni sul degrado progressivo delle condizioni dei lavoratori, richiamando la necessità di una misura che è presente in quasi tutta Europa. Il dibattito è stato soprattutto politico, dopo la presentazione a luglio della proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo a 9 euro e la successiva bocciatura a settembre dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) a cui si era rivolto il governo Meloni per trarsi d’impaccio di fronte a una discussione in Parlamento che avrebbe messo in cattiva luce chi si proclama come “destra sociale”, attenta al “popolo”. Mentre la politica ribolliva, si è levata un’altra voce, quella del diritto, in difesa del “salario minimo costituzionale”. E le sentenze della Cassazione del 2 ottobre stanno già facendo giurisprudenza nei tribunali.
Intanto, una premessa. In Italia ci sono 3 milioni di lavoratori poveri che percepiscono un salario inferiore ai 9 euro. La stima è del rapporto Svimez di luglio che si basa sugli ultimi dati Istat disponibili: un milione sono al Sud e due al Centro nord, il 17,2% dei lavoratori dipendenti (esclusa la Pubblica amministrazione). A ciò si aggiunge l’aumento vertiginoso dell’inflazione che ha tolto potere d’acquisto ai già magri salari, insufficienti a garantire quella «esistenza libera e dignitosa», diritto sancito dall’articolo 36 della Costituzione. Questa la fotografia di un mondo del lavoro frammentato tra contratti a termine prolungati per anni, part time involontari, esternalizzazioni e subappalti. Turismo, servizi, lavoro domestico e agricolo i settori più fragili (con paghe anche di 5 euro all’ora).
La svalutazione del lavoro
Nel 2021 durante la fase più dura della pandemia, la Fondazione Di Vittorio, istituto di ricerca storica, economica, sociale e di formazione sindacale della Cgil, promosse un dialogo sui temi del lavoro e delle sue trasformazioni tra Alain Touraine, che ci ha lasciati da poco, e alcuni ricercatori della sua scuola, che abbiamo il privilegio di avere come nostri collaboratori e interlocutori da molti anni.
In quel tempo abbiamo pensato che fosse arrivata l’occasione per rideterminare il nostro punto di vista su ciò che effettivamente è accaduto negli ultimi trent’anni per trarne un bilancio, partendo da una ricostruzione dei processi sociali ed economici, dal lavoro e dalle sue trasformazioni. Touraine, come altri grandi maestri della sociologia, tra i quali Accornero, Pizzorno, Gallino, dall’analisi del lavoro ha tratto suggestioni fondamentali per comprendere gli itinerari e le tendenze delle democrazie moderne e delle loro ripetute crisi. Nello stesso tempo, attraverso l’analisi del lavoro grazie al metodo dell’inchiesta, i sociologi hanno consentito alle organizzazioni dei lavoratori di costruire un punto di vista autonomo sui cambiamenti in atto, contribuendo alla costruzione di una coscienza collettiva. È questa la storia della ricerca.
L’inchiesta che presentiamo fa emergere le richieste dei lavoratori nei confronti delle controparti ma anche le aspettative nei confronti del sindacato. Rinvio ai materiali che saranno resi disponibili e consultabili a breve nella loro interezza e a quelli che abbiamo già anticipato in rete per i suoi contenuti. Ne riprendo solo una che mi è utile a collegarmi nel breve spazio a disposizione in questa sede ad una questione enorme che negli anni è stata via via sempre più sottovalutata, quella del salario. Per chi osserva in modo onesto la dinamica salariale del nostro Paese, che ci si trovi di fronte ad una gigantesca questione è chiaro da tempo, almeno da 15 anni. La questione salariale è questione sindacale, questione sociale, economica, questione politica generale per l’entità della sua dimensione, per le sue cause profondamente intrecciate con i nodi di fondo della lunga crisi italiana. Ciò che è nuovo dopo il faticoso percorso che ci ha portato all’ingresso nella moneta unica è il riaffacciarsi dell’inflazione. I salari italiani sono sostanzialmente fermi al 1993, anzi siamo l’unico Paese che nel trentennio 1990-2020 registra una perdita del potere d’acquisto della remunerazione media annua del lavoro dipendente contro incrementi del 33,1 nella media Ocse.
Poveri, dequalificati e sfruttati
Siamo in un’epoca di profonda trasformazione nella quale enormi possibilità di emancipazione si confrontano con l’affermarsi di processi di sfruttamento sempre più feroci, vecchi e nuovi, dal lavoro schiavo nelle piantagioni al platform work. L’obiettivo di questa inchiesta, promossa dalla Cgil nazionale e condotta dalla Fondazione Di Vittorio, è stato quello di ascoltare il punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori, per comprendere le loro condizioni e le aspettative per migliorare l’azione del sindacato. Per l’inchiesta è stato utilizzato un metodo di ricerca-intervento fondato sulla partecipazione e l’inclusione. Un gruppo di ricerca inter-disciplinare ha collaborato con le strutture sindacali per l’elaborazione di ogni fase, dal questionario alla disseminazione che è avvenuta online e nei luoghi di lavoro. Il questionario era rivolto a tutte le lavoratrici e lavoratori, con qualsiasi tipologia contrattuale e professionale, in ogni settore pubblico e privato, considerando anche il lavoro autonomo e i disoccupati. Hanno partecipato all’inchiesta circa 50mila persone e i questionari validi sono stati 31.014.
In particolare, l’inchiesta restituisce il punto di vista di una platea di riferimento numericamente rilevante per l’organizzazione sindacale (core membership) con una forte presenza di imprese medie e grandi, una maggiore concentrazione nel Centro e Nord Italia, un’elevata incidenza di iscritte/i e rappresentanti sindacali. Considerando queste caratteristiche del campione, emerge un racconto del lavoro che riporta meno il punto di vista dei più esclusi, di chi lavora nelle imprese più piccole, nel Sud Italia, dei migranti così come dei più giovani: soggetti e contesti nei quali l’azione sindacale necessita di essere rafforzata, e dove l’inchiesta stessa ha avuto maggiori difficoltà nella diffusione. Comunque, l’inchiesta ha intercettato tutti i settori e le professioni e mostra l’ampia varietà di condizioni, sistemi d’impresa, biografie individuali, con cui si confronta l’azione sindacale.
«La mia voce per chi è senza voce»
Patrick Zaki era uno studente come tanti altri, ma la sua vita è stata stravolta quando nel febbraio 2020 è stato arrestato all’aeroporto del Cairo al suo ritorno da Bologna, dove frequentava l’università. La sua detenzione di 20 mesi è stata un periodo di prove inimmaginabili, caratterizzato da interrogatori, isolamento e torture. Tuttavia, è riuscito a trovare la forza nella speranza, nell’affetto di chi ha lottato per lui e nel potere dei libri. Oggi proprio con un libro, Sogni e illusioni di libertà. La mia storia edito da La nave di Teseo, Zaki racconta la sua incredibile storia. Left lo ha raggiunto e intervistato.
Patrick Zaki, nel titolo del tuo libro ci sono le parole “sogno” e “illusione”. Due parole evocative, perché le hai scelte?
Ho scelto le parole “sogno” e “illusione” perché le considero molto significative. Molto spesso ci troviamo ad avere sogni che si trasformano in incubi. Un esempio tangibile è rappresentato dalla rivoluzione egiziana del 2011, che è iniziata come un sogno e si è poi trasformata in un incubo. Sognavo di vedere la democrazia fiorire, di assistere a una maggiore apertura e a una promozione dei diritti umani, ma tali speranze si sono progressivamente rivelate essere incubi. Sognavo di studiare a Bologna, ma questa aspirazione è diventata un incubo quando mi sono ritrovato in prigione. La mia storia è un racconto di sogni e incubi che hanno permeato la mia vita. Non sono mancate neanche molte illusioni, come quando ho trascorso due anni dietro le sbarre e, ad ogni udienza, nutrivo la speranza di essere rilasciato, ma finivo comunque per rimanere imprigionato. Il mio libro mira a illuminare questi sogni, incubi e illusioni che ho vissuto.
La nonviolenza è natura umana
Illustrazione di Marilena Nardi
L’essere umano non ha dentro di sé, per sua natura, la violenza. E quindi, di conseguenza, la violenza non è qualcosa di naturalmente, fisiologicamente, presente nell’umano. Sebbene la credenza che l’essere umano sia naturalmente violento abbia radici lontane migliaia di anni, esse non occupano l’intera storia dell’uomo. Al mito di Edipo (al quale si attribuisce l’origine del pensiero del logos occidentale) che racconta di una natura umana perversa e naturalmente portata alla violenza e alla distruzione e quindi alla guerra, si contrappone un mito ancora più antico: la storia d’amore tra due adolescenti che in una dialettica sviluppano la propria identità. In “Amore e Psiche” il racconto delle sorelle invidiose di un mostro che emerge dal buio è una bugia cattiva. In questa favola mitologica ritroviamo, inoltre, la paura dello sconosciuto e una mancanza di fiducia nel proprio sentire, ma non una violenza articolata a eliminare la vita dell’altro. Non esiste alcuna prova certa della presenza di qualche forma di violenza nel paleolitico e le pitture rupestri non mostrano scene di violenza (vedi U. Tonietti, L‘arte di abitare la terra).
I primi conflitti fra i popoli sembrano comparire dopo che i gruppi di cacciatori nomadi sono diventati stanziali, hanno iniziato a accumulare beni e hanno sviluppato un’organizzazione sociale che deputava ad alcune figure la gestione di tali beni, per cui queste quindi erano in grado di gestire una certa forma di potere. Sembra che in questo ambito sia nato anche il potere religioso e che le diverse popolazioni si siano distinte sulla base delle differenti radici religioso culturali. Ciononostante la credenza dell’essere umano come naturalmente violento rimane molto diffusa, anche se mai è stata dimostrata e che anzi viene contraddetta da un numero crescente di ricerche. Spostiamo ora l’attenzione dal piano antropologico a quello più prettamente psicologico, di cui, facendo la psichiatra, mi occupo quotidianamente. Un problema che si osserva frequentemente è quello relativo alla confusione tra opporre un rifiuto, cioè dire un “No”, ed essere violenti. Questo riguarda un po’ tutti, ma in particolare le donne che più frequentemente possono confondersi e sentirsi in colpa o angosciate pensando di essere violente se si trovano a dire di no e opporre un rifiuto. Come se non essere sempre e comunque accondiscendenti (o sottomesse come in alcune culture religiose) implicasse automaticamente una lesione e quindi una violenza sull’altro.
Quella geniale domanda di Einstein contro la guerra
La domanda è: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?». A porla non è certo uno qualunque, ma Albert Einstein il 30 luglio del 1932 in una lettera scritta da Potsdam a Sigmund Freud. Lo scienziato aveva scelto il padre della psicoanalisi come suo interlocutore quando la Società delle Nazioni si era rivolta a lui per promuovere un dibattito epistolare su temi di interesse generale fra gli intellettuali di spicco dell’epoca. Einstein, in quel 1932, a un passo dall’ascesa al potere di Adolf Hitler, decide di interpellare colui che si vantava di aver scoperto l’inconscio per discutere di una questione non da poco, su cui i filosofi da secoli avevano dibattuto senza però arrivare a una risposta esauriente ed esplicativa: la necessità o meno della guerra nella risoluzione dei conflitti. Freud riceve la lettera nell’agosto e, anche se considera quel dibattito «noioso» e «sterile», manda il mese successivo la sua risposta, in cui, dopo una lunga argomentazione, conclude «non c’è speranza di poter sopprimere le tendenze aggressive degli uomini».
Di lì a breve il nazi-fascismo imperante in Europa e lo scoppio della seconda guerra mondiale confermeranno le parole di Freud che gela le speranze dello scienziato che, invece, auspicava l’istituzione di un organismo politico sovranazionale che intervenisse nelle contese tra gli Stati.
Il confronto Freud-Einstein rimanda a un altro confronto che è possibile stabilire tra altri due “colossi” del pensiero occidentale: Immanuel Kant (1724-1804) e Friedrich Hegel (1770-1831). Il primo, con un libretto scritto nel 1795 (Per la pace perpetua), all’indomani del “periodo del terrore” della Rivoluzione francese, delineava tre condizioni affinché i Paesi riuscissero a convivere pacificamente: la forma repubblicana come governo; un organismo sovranazionale per mettere d’accordo in caso di contesa; infine un sentimento di cosmopolitismo che induca gli uomini a considerare il mondo una patria universale.
Secondo il filosofo illuminista gli individui hanno sì istinti bestiali ed egoistici che li conducono verso guerre e violenze – e così anche gli Stati – ma detengono anche la ragione, la quale potrà dirimere i contrasti e trovare soluzioni, garantendo l’uscita dallo “stato di guerra” hobbesiano. Sarà dunque la ragione a indurre gli uomini al mantenimento della pace.