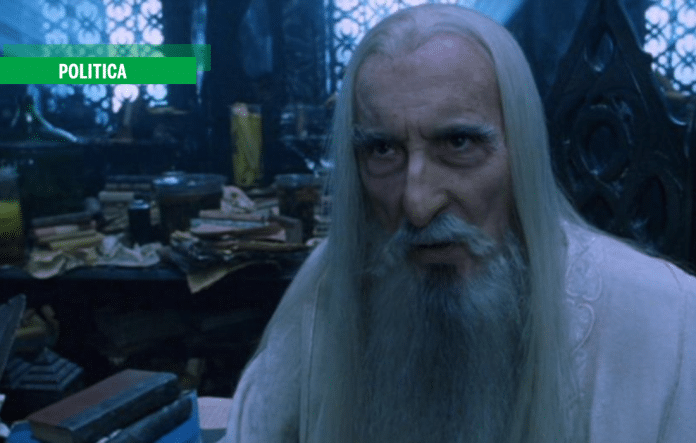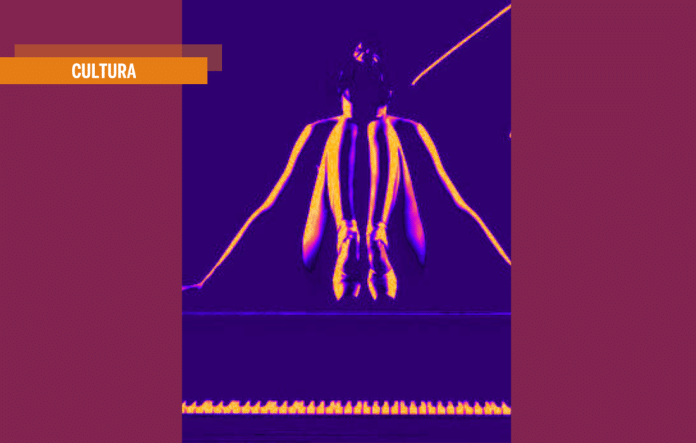Ecco il denso e importante intervento del giurista Domenico Gallo che oggi ha introdotto il convegno “Guerra o pace?”, che potete seguire integralmente su Radio Radicale
Vincere! Nel nostro tempo drammatico questa parola d’ordine è ritornata in auge, emergendo dalle nebbie del passato. Ora come allora, essa trasvola e accende i cuori delle élite politiche, attraversa l’Atlantico, l’Oceano indiano, il Mar Baltico, il canale della Manica, il Mar Nero. Si trasmette da Stoltemberg (segretario Nato) a Von der Layen (presidente della Commissione Europea), da Metsola (presidente del Parlamento europeo), a Michel (Presidente del Consiglio europeo), a Borrell (alto rappresentante Ue per gli affari esteri). Plana a Strasburgo, infiammando i cuori dei deputati europei, che esortano gli Stati membri ad incrementare con sistemi d’arma sempre più performanti l’assistenza militare al governo ucraino per avvicinare l’ora della “vittoria”.
La guerra, iniziata il 24 febbraio 2022 con l’aggressione russa, si deve concludere necessariamente con la vittoria dell’aggredito e la sconfitta dell’aggressore. Per vittoria si intende la capacità dell’Ucraina di “riacquistare il pieno controllo su tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale”, cioè di recuperare manu militari i confini del 1991. Solo in questo modo, secondo la vigente narrazione a reti unificate sarà possibile pervenire ad una “pace giusta”, che ristabilisca il primato del diritto sulla forza. Questa pretesa di ottenere la pace attraverso la “vittoria”, esclude ogni possibilità di negoziato, che Zelensky ha addirittura vietato per legge. La mediazione non contempla vittorie, ma è, per antonomasia, la conciliazione di interessi geopolitici contrapposti, a cui si deve dare identica legittimità.
Il fondamentalismo religioso, lo sappiamo tutti, è fonte di conflitti e di violenze perché indurisce dei principi e li rende assoluti, scagliandoli sulla testa delle persone, incurante del danno che produce. Il fondamentalismo politico di quello che è stato chiamato l’Occidente collettivo non è meno dannoso del fondamentalismo religioso. Le scelte fin qui compiute dalla Ue e dalle Cancellerie di paesi europei a rimorchio di Usa e Gb, sono dettate da una sorta di fondamentalismo cieco: si agitano sopra la testa dei popoli dei principi ammantati di assolutezza, che vengono impugnati strumentalmente, secondo ragioni di opportunità politica, per essere poi rinnegati e messi da parte, quando non più utili. Non è un caso se buona parte dei paesi del Sud del mondo, non si sono fatti influenzare dalle nostre posizioni e non partecipano alla crociata della Santa alleanza occidentale contro la Russia. Quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si fanno paladini del principio del divieto dell’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato (art. 2, par. 4 Carta Onu), non possiamo ignorare come abbiano calpestato impunemente questo principio con l’aggressione all’Irak nel 2003.
Quando la Nato, vuole farsi paladina dell’integrità territoriale dell’Ucraina, non possiamo dimenticare che ha aggredito la ex Jugoslavia nel 1999 e l’ha bombardata per 78 giorni, con l’effetto di modificarne le frontiere, separando il Kosovo dalla Serbia. Il fondamentalismo politico della santa alleanza occidentale si basa sulla negazione totale degli interessi geopolitici della Russia e sulla cancellazione del passato. Tutti i documenti delle fonti occidentali parlano di ”unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine”. Indubbiamente la c.d. “operazione militare speciale” iniziata il 24 febbraio 2022 è un’azione ingiustificata perché non è ammissibile nell’ordinamento internazionale la legittima difesa preventiva (sebbene contemplata nelle dottrine militari degli Stati Uniti), quindi costituisce un atto di aggressione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Carta dell’Onu, e un crimine internazionale, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto della Corte penale internazionale. Né si può addurre a giustificazione il fatto che questa operazione sia stata presentata all’opinione pubblica come un intervento umanitario a difesa delle popolazioni del Donbass, sulla falsariga di quanto aveva fatto la Nato per giustificare l’intervento per il Kosovo. Il veleno in questa formula, ripetuta come un mantra, sta nell’aggettivo unprovoked, che annulla tutti gli antecedenti dell’aggressione, fino al punto di falsificare la storia. Il nostro ex ministro degli Esteri (1996-2001) Lamberto Dini in un’intervista a Milano Finanza del primo marzo 2022, ha testimoniato:” Come ministro degli esteri ho partecipato a numerosi incontri con i ministri Primakov e Ivanov ed il Segretario di Stato americano Madeleine Albright e posso affermare che il pensiero dei russi non è mai cambiato. Avere delle basi Nato lungo i 1.500 km del confine ucraino per la Russia è sempre stato inaccettabile. Da qui nascono le richieste di Putin, che invece sono state ritenute irricevibili dagli Usa. Gli Stati Uniti non hanno mai dato spiegazioni sul perché considerassero inaccettabile un’Ucraina neutrale. Si sono limitati a dire che la questione non era all’ordine del giorno, ma per anni hanno continuato ad armare l’Ucraina.
Ora si è scatenato un conflitto assurdo, ma mi domando se Stati Uniti ed Europa non ne siano collettivamente responsabili insieme alla Russia”. Peccato che neanche un granello della saggezza di Dini sia penetrato nella testa dei suoi successori, anzi la sua testimonianza è stata immediatamente rimossa dal dibattito pubblico. Da oltre venti anni gli Stati Uniti hanno coinvolto l’Europa attraverso la camicia di forza dell’Alleanza atlantica, in una insensata politica di scontro con la Russia, che ha sostituito la cooperazione con l’emarginazione, il dialogo con l’intimidazione, col risultato di provocare una pericolosa rinascita dell’orgoglio nazionale russo. A questo disastro ci ha portato la pretesa di trasformare l’Ucraina nella lancia della Nato nel costato della Russia. Mettere il coltello alla gola di una grande potenza non è il modo migliore per assicurarsi la convivenza pacifica. Quando divenne chiaro il disegno dell’amministrazione Clinton di espandere la Nato ad est, il diplomatico americano George Kennan, uno dei massimi interpreti della guerra fredda, lanciò un grido d’allarme, in un articolo sul New York Times del 7 febbraio 1997, osservando che: “ la decisione di espandere la NATO sarebbe il più grave errore dell’epoca del dopo guerra fredda. Una simile decisione avrebbe l’effetto di infiammare le tendenze nazionalistiche antioccidentali e militariste nell’opinione pubblica russa, pregiudicherebbe lo sviluppo della democrazia in Russia, restaurerebbe l’atmosfera della guerra fredda nelle relazioni est ovest, spingerebbe la politica estera russa in direzioni a noi decisamente non favorevoli.” Sottolineare il ruolo negativo dell’espansione della Nato ad est, non significa giustificare le azioni della Russia o condonarle. Si tratta di spiegarle, alla ricerca di una via d’uscita pacifica dalla guerra e di una pace duratura. Significa rendersi conto che il conflitto era prevedibile e, per ciò stesso, prevenibile. Anche da ultimo si sarebbe potuto evitare, ove si consideri che il 15 dicembre 2021 la Russia consegnò le sue proposte di accordo, pubblicate sul sito del Ministero della difesa russo, articolate in due bozze di accordo: uno multilaterale con la Nato, in 9 punti, e uno bilaterale con Washington, in 8 punti. Al centro di queste proposte vi era l’impegno a non espandere la NATO al territorio dell’Ucraina e a effettuare misure di riduzione degli armamenti. Se si fosse aperto un dialogo su queste proposte, difficilmente la Russia avrebbe commesso l’azzardo di muovere i suoi carri armati. Invece irresponsabilmente abbiamo chiuso porte e finestre alle richieste di sicurezza della Russia, invocando il preteso diritto sovrano dell’Ucraina di aderire alla Nato, come se fosse un principio non negoziabile, una sorta di dogma di fede. Salvaguardare il dogma atlantico è stato ritenuto dagli irresponsabili leaders europei molto più importante che sventare il ritorno della guerra sul suolo europeo. Se deve essere condannata l’illegale e ingiustificata aggressione della Russia, uguale biasimo deve essere rivolto a coloro che l’hanno provocata.
Chiamato a testimoniare in una seduta del Consiglio di sicurezza dell’Onu, l’8 febbraio 2023, Roger Waters ha osservato: “L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa è stata illegale. La condanno nei termini più forti possibili. Non si può dire però che non ci sia stata una provocazione dietro a questa invasione; quindi, condanno anche i provocatori nei termini più forti possibili”. La pretesa di ignorare, fino al punto di cancellarli, gli interessi geostrategici della Russia, come ha creato le condizioni per lo scoppio del conflitto, così ha determinato il suo prolungamento e adesso impedisce alla diplomazia di aprire un negoziato che presuppone, pur sempre, qualche forma di mediazione degli interessi in campo. Se si esclude ogni mediazione, ogni riconoscimento degli interessi altrui, la guerra non può finire con un compromesso, l’unica soluzione è la vittoria finale di uno dei due schieramenti e l’annichilimento dell’altro. Ma siamo sicuri che l’ora della vittoria sta per arrivare? In un intervista pubblicata dal Corriere della Sera del primo maggio 2022 l’economista americano Jeffrey Sachs, docente della Columbia University, osserva: “Il grande errore è credere che la Nato sconfiggerà la Russia, tipica arroganza e miopia americana. Difficile capire cosa significhi sconfiggere la Russia dato che Vladimir Putin controlla migliaia di testate nucleari. I politici americani hanno un desiderio di morte? Conosco bene il mio Paese i leaders sono pronti a combattere fino all’ultimo ucraino: meglio fare la pace che distruggere l’Ucraina in nome della sconfitta di Putin.”
Il fondamentalismo politico che guida le Cancellerie occidentali non ammette altra soluzione che la sconfitta e l’umiliazione della Russia di Putin, ma in questo modo è stata cambiata la natura della guerra, che da resistenza legittima ad un’aggressione ingiusta, si è trasformata in qualcosa di molto diverso. Ovviamente non possiamo ignorare, il “diritto naturale di autotutela nel caso abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni unite, riconosciuto dall’art. 51 della Carta dell’Onu. Lo Statuto dell’Onu riconosce il diritto di resistenza con le armi a fronte di un’aggressione in atto, ma ciò non legittima una guerra senza fine e senza limiti. Infatti il diritto di resistenza è valido: “fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”(art. 51). In questo caso, in mancanza di un intervento autoritativo del Consiglio di sicurezza, tutti gli attori internazionali, a cominciare dai contendenti, devono attivarsi per restaurare la pace, poiché la guerra – secondo il preambolo della Carta – resta, pur sempre un flagello che procura indicibili afflizioni all’umanità. Invece noi sappiamo (ce l’ha rivelato l’ex premier israeliano Bennet) che, dopo nemmeno due settimane dall’inizio del conflitto, il 5 marzo le parti stavano per concludere un accordo di pace.
Il 16 marzo 2022 il Financial Times svelava un piano di pace in 15 punti, fondato sulla conciliazione dei diversi interessi in campo, che le parti avevano concordato nel corso dei negoziati russo-ucraini in Turchia. Adesso sappiamo che le indiscrezioni del Financial Time erano più che fondate: l’accordo di pace era stato raggiunto. Il 17 giugno, ricevendo la delegazione dei leaders africani, guidata dal Sudafrica, il presidente russo Vladimir Putin ha reso noto che durante le trattative tra le delegazioni ucraina e russa svoltesi a Istanbul a fine marzo 2022, si era raggiunto un accordo molto dettagliato che prevedeva come punto centrale la neutralità dell’Ucraina e che, a seguito del ritiro delle truppe russe che circondavano Kiev, la guerra sarebbe finita. Putin ha mostrato il documento, denominato “Trattato sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina”, con la firma del capodelegazione dell’Ucraina. Subito dopo l’avvenuto ritiro delle truppe da Kiev e Charkiv, secondo Putin, l’accordo è stato stracciato dagli ucraini e gettato “nella pattumiera della storia”. Ebbene quella possibilità concreta di restaurare la pace nella regione è stata sventata dal veto di Biden e Johnson, che hanno istigato l’Ucraina a respingere ogni mediazione, incoraggiandola a puntare sulla sconfitta militare della Russia, con la garanzia del massiccio sostegno finanziario, militare e di intelligence di Usa, Gb, Ue e di altri Paesi occidentali. Questo veto, altrettanto criminogeno quanto l’aggressione, ha cambiato il volto della guerra. Dalla fine di marzo del 2022, il conflitto ha perso la natura di una resistenza legittima dell’Ucraina ad un’aggressione altrui, ma è diventata una guerra in cui un’alleanza di 30 Stati cerca di infliggere una batosta militare alla Russia, utilizzando il sangue degli ucraini. Una resistenza militare ad un’aggressione si è trasformata in una guerra di posizione, come la Prima guerra mondiale, in cui i belligeranti cercano di distruggersi a vicenda. Sono proprio gli esperti a richiamare il dramma della Prima guerra mondiale. Il capo di Stato maggiore Usa Mark Milley, il già 15 giugno dello scorso anno, ebbe a dichiarare: «L’avanzata russa in Ucraina si è trasformata in una “guerra di attrito” quasi come la Prima guerra mondiale.” Cosa vuol dire una “guerra d’attrito”? Il richiamo alla Prima guerra mondiale fa emergere dalle nebbie del passato la dimensione di uno stallo fra eserciti potenti contrapposti che si consuma in una strage insensata e senza fine. La Prima guerra mondiale dovrebbe averci insegnato che, a fronte di un conflitto così violento, spietato e prolungato nel tempo non esiste la “vittoria”, perché una tale guerra è un male in sé, è una procedura che produce sofferenze indicibili a tutte le parti in conflitto, che nessun obiettivo politico può giustificare. Nel caso del conflitto in Ucraina, il prolungamento della guerra, che ha già provocato centinaia di migliaia di morti, è doppiamente assurdo perché nessuna parte può prevalere sull’altra, come ci ricorda lo stesso gen. Milley, da ultimo, in un’intervista al Financial Times del 16 febbraio di quest’anno. Quando si accetta che la guerra debba continuare per consentire all’Ucraina di recuperare tutti i territori compresi nei confini del 1991 si invoca a sproposito ed in modo strumentale, un principio, quello dell’inviolabilità delle frontiere, solennemente proclamato nell’atto finale della conferenza di Helsinky sulla sicurezza e cooperazione in Europa. Il principio dell’inviolabilità delle frontiere è strumentale al mantenimento della pace, serve ad evitare che gli eventuali conflitti politici sui confini possano degenerare in uno scontro armato. I confini possono essere modificati e lo sono stati più volte dopo l’atto di Helsinky soltanto con l’accordo di tutte le parti interessate, com’è avvenuto con la riunificazione della Germania e la divisione della Cecoslovacchia. Tuttavia anche il principio dell’inviolabilità delle frontiere non deve essere declinato in modo fondamentalista, altrimenti finirebbe per attizzare dei conflitti, invece che prevenirli. Soprattutto non può essere declinato a prescindere dalla realtà determinata da fatti concreti e dalla volontà dei popoli coinvolti. L’inviolabilità delle frontiere può essere difesa di fronte ad una aggressione esterna, ma è molto più difficile da rispettare quando gli Stati si rompono dall’interno per fenomeni di secessione o di guerre civili. Pretendere che l’Ucraina ristabilisca i confini del 1991 è tanto assurdo quanto sarebbe la pretesa di ricostituire la Jugoslavia sulla base dei confini del 1991.
Non possiamo ignorare che i confini sono cambiati dal 2014 per effetto della guerra civile, che ha portato alla secessione di alcune parti del Donbass, e per effetto della dichiarazione d’indipendenza dall’Ucraina, votata all’unanimità dal Consiglio supremo della Repubblica di Crimea. Scelta confermata il 16 marzo del 2014 da un referendum popolare (a cui partecipò l’83,1% degli aventi diritto al voto), che approvò l’annessione alla Russia con il 96,77% di voti favorevoli. Da oltre nove anni la Crimea costituisce una Repubblica autonoma inserita nella Federazione Russa. L’Ucraina non ha mai riconosciuto l’indipendenza della Crimea, come la Serbia non ha mai riconosciuto l’indipendenza del Kosovo. Ma si tratta di situazioni di fatto consolidate che non possono essere modificate con le armi. Se la Serbia invadesse il Kosovo per restaurare la propria sovranità, questa operazione sarebbe qualificata come un atto di aggressione perché non è consentito l’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, lo stesso vale per l’Ucraina. L’obiettivo del governo Zelensky di smembrare la Federazione russa, occupando militarmente la Crimea, esula dalla legittima difesa e trasforma la legittima resistenza militare ad un’aggressione in corso, in una guerra offensiva. La pretesa di pervenire alla pace attraverso la “vittoria”, frutto del fondamentalismo della ragione politica, sta dimostrando tutta la sua tragica impotenza, alimentando una strage insensata e senza fine e danni ambientali incommensurabili, che hanno fatto parlare di “ecocidio”3 E’ in virtù di questa pretesa che la NATO e l’UE hanno bocciato ogni proposta di cessate il fuoco e hanno respinto il piano di pace cinese e, da ultimo, quello indonesiano, chiudendo la porta ad ogni negoziato. Non è questo il modo migliore per manifestare solidarietà al popolo ucraino martoriato dalla guerra. Come ha osservato il generale Mini: “Vedere un paese europeo disastrato, una popolazione europea decimata e offrire la prospettiva di ulteriori distruzioni e massacri non è solidarietà, così come non è patriottismo far annegare la Patria in un mare di sangue per compiacere il più forte, piuttosto che discutere del proprio destino e dei propri interessi”4. Delineare come soluzione del conflitto soltanto l’intensificazione della guerra, comporta un prezzo incalcolabile in termini di perdita di vite umane e di devastazione dell’ambiente e rende massimo il rischio di una catastrofe nucleare. Se le forze armate ucraine dovessero dilagare in Crimea, insidiando la base della marina russa a Sebastopoli, chi ci può assicurare che la Russia si arrenderà, e accetterà di essere smembrata, senza porre mano all’arsenale nucleare? Pretendere di sconfiggere ed umiliare una superpotenza dotata di 6.000 testate nucleari è come giocare a scacchi con la morte. Il fallito push tentato da Prigozhin il 24 giugno, dimostra quanto sia pericolosa l’eventuale implosione della Russia, che consegnerebbe le armi nucleari nelle mani di gruppi criminali ed incontrollabili. Senza volerlo e senza vederlo ci stiamo avviando sulla via per Armageddon dove, secondo l’Apocalisse, gli spiriti maligni partoriti dalla Bestia radunarono i Re di tutta la Terra: «per la battaglia del gran giorno del dio onnipotente». L’apocalisse segnerà la fine della storia, ma noi vogliamo fermamente che la storia continui.
L’autore: Il magistrato Domenico Gallo è stato presidente di sezione della Corte di Cassazione. Già senatore della Repubblica, fa parte del comitato esecutivo del Coordinamento per la democrazia costituzionale