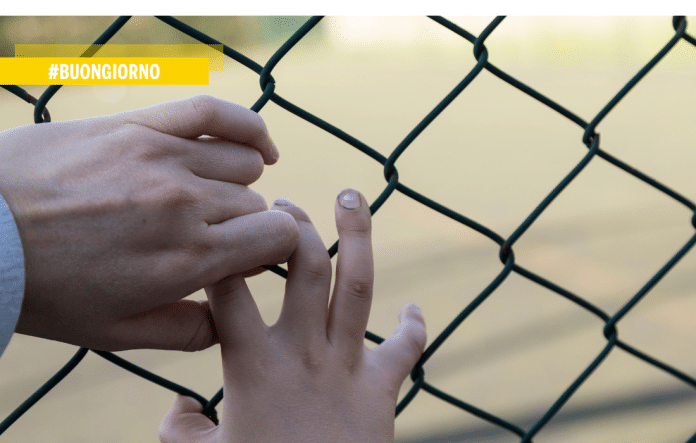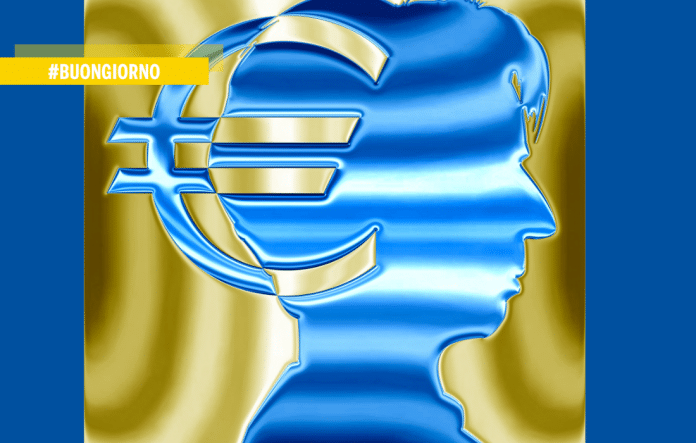Lotta al caporalato e allo sfruttamento, miglioramento del condizioni di lavoro nei campi, a che punto siamo? Lo abbiamo chiesto al segretario della Flai Cgil Giovanni Mininni (da poco riconfermato con percentuali “bulgare”) che stigmatizza i nuovi provvedimenti securitari del governo Meloni riguardo all’immigrazione ma apre sul decreto flussi: «Apprezziamo la volontà di tornare ad un piano triennale di programmazione degli ingressi (2023/2025), fatto che non avveniva da molto tempo anche se dovrebbe costituire la prassi di un approccio sistemico».
Segretario Mininni, ci aiuti a fare un quadro, cosa sta cambiando nel mondo del lavoro agricolo?
Il mondo agricolo cambia in continuazione. Rispetto al precedente congresso Flai Cgil attorno ad alcune battaglie come quelle contro caporalato e sfruttamento registriamo miglioramenti. C’è maggiore consapevolezza fra chi lavora e aumentano le imprese più attente a non ricorrere ai caporali. L’irregolarità resta alta ma viene maggiormente attenzionata da forze dell’ordine e ispettorato del lavoro. Gli ispettori sono aumentati col precedente governo, hanno fatto formazione e ora dovrebbero essere operative alcune centinaia. Ancora pochi rispetto al numero delle aziende. Di recente è partito un Programma di azione dell’ispettorato del lavoro che mette al primo punto le condizioni di sfruttamento che sono presenti non solo in agricoltura, dovute al modello economico che si è affermato.
Con il Decreto Cutro il governo prova a legiferare sul tema abusato dell’immigrazione. Trovate qualche novità di rilievo?
Purtroppo c’è da registrare la stessa impostazione di sempre. Neanche la strage di Cutro è servita a dare almeno un moto di umanità. La sola notizia positiva degna di nota è nella volontà di tornare ad un piano triennale di programmazione degli ingressi (2023/2025), fatto che non avveniva da molto tempo anche se dovrebbe costituire la prassi di un approccio sistemico. Sembra di scorgere la volontà di pianificare e di non agire sempre sulla base di emergenze. Però ci sono elementi poco chiari nelle nuove normative. Ad esempio si riconoscono quote di ingressi maggiori per i Paesi che promuovono campagne mediatiche con l’obiettivo di scoraggiare le partenze. E qui ci trovo un’assurdità ripresa anche dal Presidente del Consiglio.
Vale a dire?
La premier dice che si tratta di far conoscere i rischi che si corrono a partire ma di far comprendere a chi emigra in Italia che questa è una scelta sbagliata, che debbono restare a casa. Come se chi parte decidesse, da un momento all’altro di venirsi a fare una gita per vedere il Colosseo o per fare turismo. Non servono geni per capire che chi parte è spesso costretto a farlo per guerre, per crisi economiche, catastrofi ambientali, povertà senza prospettive di sviluppo. Ci leggo la volontà di far percepire la scelta di abbandonare il proprio Paese come una colpa capovolgendo la realtà. Anche fra chi rientra nei “decreti flussi” poi si scontra col fatto che i datori di lavoro spesso non sottoscrivono i contratti promessi. Col risultato che i lavoratori finiscono a lavorare al nero e nei ghetti. Noi le proposte per impedire che questo accada le abbiamo. Ma questo, come i precedenti governi, ha emanato i decreti senza prima cercare nessun confronto con le parti sindacali. Col precedente governo, grazie al ministro Orlando, qualche timido segnale era giunto legato al fatto che il dicastero che ricopriva si occupava di politiche sociali. Ma si è tornati al fatto che l’approccio è unicamente securitario, che l’interlocutore è un “ministero di polizia” e che il tema è la lotta, con nuovi strumenti alla “clandestinità” e la deroga per aprire nuovi centri permanenti per i rimpatri. Il loro approccio è questo.
Che cosa sta cambiando con la maggiore automazione del lavoro nei campi. penalizza i lavoratori o li solleva della maggiori fatiche, quelle più usuranti?Aumentano gli interventi di modernizzazione nella raccolta persino nelle campagne foggiane e di tutto il Meridione. Le macchine, per ora solo leggermente, fanno diminuire la necessità di manodopera soprattutto nelle grandi raccolte. Ma il progresso tecnologico non cancella il caporalato. In Emilia-Romagna c’è un “polo del pomodoro”, che è meccanizzato da anni, utilizza meno lavoratori rispetto al Sud dove prevale la raccolta manuale, ma questo non risolve lo sfruttamento. Parlo ovviamente di industria agricola in cui i prodotti vengono trattati, ci sono realtà di agricoltura 4.0 in poche aziende e questo mette ancora più in evidenza l’arretratezza di altre realtà. Secondo i dati dell’ultimo censimento c’è una crescita dimensionale delle aziende e una concentrazione inedita rispetto al passato che potrebbe tradursi, con l’avvento della digitalizzazione, in un’importante diminuzione della forza lavoro necessaria che ancora oggi non appare in maniera completa e significativa. Ci sono ancora poche aziende strutturate nelle quali l’avvento della digitalizzazione ha prodotto diminuzione di manodopera ma che necessariamente è più qualificata. Come sindacato dobbiamo lavorare nella formazione ma anche alla necessità difendere l’occupazione. C’è il rischio dell’espulsione di vecchi lavoratori in cambio dell’assunzione di nativi digitali. Il nostro è stato finora un processo lento. Arriva la meccanizzazione quando negli altri settori la digitalizzazione è già il presente.
Che impatto avrà l’impiego dell’intelligenza artificiale?
Fra una rivoluzione industriale e la successiva ora passa sempre meno tempo, a breve vedremo gli effetti di quella legata all’intelligenza artificiale su cui poche imprese stanno investendo. Il settore più interessante e avanzato nei nostri ambiti è quello vinicolo. Ci sono aziende che investono sui filari gestiti dai computer che per anni raccolgono informazioni sui microclimi, sui colori del vino da ottenere e sul grado zuccherino preferito. Arriveremo presto al fatto che sarà il computer a sostituire l’agronomo, decidendo ora e giorno migliore per la raccolta, potendo elaborare milioni di dati. I piccoli robot cingolati che girano fra i filari imporranno una redistribuzione del lavoro con una settimana corta. A questo dobbiamo prepararci.
Si ha l’impressione che la politica, come il mondo dell’informazione non si rendano conto appieno dell’importanza fondamentale che riveste per il Paese il vostro settore. È così?
Sì ed è per certi versi incredibile. Con la guerra è partita una speculazione enorme sul grano. Noi siamo autosufficienti per quanto riguarda quello duro, importiamo solo quello morbido ma la liberalizzazione ha permesso di aumentare i prezzi quasi senza reazione. Accade perché secondo me non si comprende l’importanza e il valore dell’industria alimentare in Italia che divenuta la seconda manifatturiera dopo la metalmeccanica. Nel 2022 c’è stato un fatturato di oltre 180 mld di euro. Il cibo produce ricchezza che, secondo la Federalimentare è cresciuta in valore del 14%, questo si traduce in occupazione e parliamo di industria non di agricoltura. Il cibo che si produce muove il mondo.
Al vostro congresso il ministro Lollobrigida ha posto al centro della politica la sovranità alimentare. Come leggete questa espressione?
Se il senso diventa quello della “via campesina” siamo d’accordo. Si traduce nell’accesso al cibo buono e di qualità, nella scelta di garantire soprattutto con l’aumento della povertà. C’è la necessità di contrastare la massificazione della qualità. McDonald’s e altre multinazionali vendono cibo a tutto il mondo uniformando i gusti e abbassandone la qualità. Invece l’Italia è un esempio di varietà di prodotti e le aziende devono garantire una loro molteplicità che risponda alle biodiversità presenti in agricoltura. Recentemente si è cominciato a fare il pane solo col grano tenero perché ha maggior resa. Eppure eravamo il Paese che vantava 700 tipi di grano mentre ora ne restano fondamentalmente una decina. Mi sembra giusto che ogni Paese decida la qualità che vuole mantenere e in tal senso potremmo anche intendere la sovranità come difesa del cibo italiano. Ma questo dal nostro punto di vista va coniugato con la sicurezza e la certezza che questa qualità sia accessibile a tutti, non solo ai ricchi. Quindi ci stiamo alla sfida di produrre cibo sano e giusto che non provenga dallo sfruttamento dei lavoratori.
Intanto anche per chi in agricoltura lavora in regola, la condizione salariale è fra le peggiori d’Europa. Cosa propone come Flai Cgil?
Il tema dei contratti si è esasperato negli ultimi 2 anni a causa anche dell’inflazione. L’anno scorso il rinnovo ha permesso un aumento del 4,2% a fronte di un inflazione dichiarata del 12%, la più alta d’Europa. Sarà difficile avere un rinnovo perché dovremmo avanzare la richiesta di una redistribuzione della ricchezza prodotta. Molte imprese hanno trovato il modo per mettere al riparo i profitti dall’inflazione. I governi che si sono succeduti hanno aiutato più le imprese che i lavoratori. Siamo titolati a chiedere la redistribuzione della ricchezza prodotta non solo perché deve proteggere il potere d’acquisto ma lo faccia crescere. Il salario poi è definito in base a contratti provinciali. Col risultato che in molte aree del Paese chi lavora in agricoltura è sotto la soglia di povertà. I salari devono crescere ovunque più dell’inflazione reale. Per questo serve con urgenza una vera riforma fiscale che permetta questa redistribuzione intervenendo a favore della classe lavoratrice. Gli interventi fatti finora sono stati insufficienti: sul cuneo fiscale si doveva tagliare di 5 punti si è giunti a 2; la promessa tassazione delle rendite finanziare è bassa e inferiore a quelle da lavoro dipendente e potrei continuare.
Nonostante i miglioramenti al sud ma non solo è forte la presenza di manodopera immigrata, con pochissimi diritti e in condizioni di vita inaccettabile nei ghetti come Borgo Mezzanone e San Ferdinando. Come dovrebbero intervenire sindacato e politica?
Occorre la politica ma anche lo Stato che preveda una serie di azioni da parte di istituzioni, le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. Ne dovrebbero far parte le associazioni datoriali, i sindacati, l’Inps, l’Inail, le forze dell’ordine, l’Ispettorato del lavoro ed altri attori, per svolgere un lavoro di prevenzione.
Che ne è della legge 199 sul caporalato?
Sta funzionando riguardo all’attività repressiva attraverso il monitoraggio e non passa settimana senza che ci siano arresti. Ma manca la prevenzione. Le sezioni di cui parlavo, su base provinciale, dovrebbero esistere dappertutto dal 2016 ma ad oggi sono attive solo in metà delle Province. Queste sezioni dovrebbero garantire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, fare da collocamento pubblico, garantire le politiche di accoglienza, offrire il trasporto dei braccianti. Questo va fatto territorio per territorio perché significa garantire quelle peculiarità finora offerte dal caporalato. Se ci si riesce si toglie l’acqua ai caporali. Quando lo Stato non presidia arrivano loro. Non avviene anche a causa delle resistenze dei detrattori di questa legge che pongono ostacoli soprattutto alla prevenzione. A volte le sezioni che nascono non funzionano bene, anche perché capita che le associazioni datoriali non si schierino con decisione per ripulire l’economia agricola da quelle imprese che fanno concorrenza sleale. Ci aspettiamo che siano loro a decidere senza equivoci quali imprese vogliono difendere. In questo quadro i lavoratori immigrati, in particolare quelli irregolari sono l’anello più debole della catena, quello più ricattabile e vulnerabile.
Il “decreto Rilancio” del giugno 2020, nella parte riguardante l’emersione del lavoro nero proposta dall’allora ministra Bellanova è stato un fallimento, soprattutto per chi lavora in agricoltura. Al di là delle carenze che conteneva, cosa si potrebbe fare oggi?
Il problema originario resta nella Bossi Fini che ha creato un pregiudizio e stigmatizzato l’immigrato considerato “soggetto illegale”. Se non cambia non ne usciremo mai. Le regolarizzazioni che si sono succedute, sotto il governo Monti e a seguire hanno lasciato appesi senza prospettiva tantissimi lavoratori. All’ultimo tentativo ha lavorato un ottimo sottosegretario, Matteo Mauri, ma è rimasto il fatto che deve essere il “clandestino” a chiedere al datore di lavoro di poter emergere, ovviamente pagando. Ora fra un lavoratore in nero e un datore di lavoro, dal punto di vista liberale, chi ha maggior forza? È difficile trovare un datore di lavoro che si autodenunci. In compenso si trovano tanti faccendieri che regolarizzano facendo pagare prezzi spropositati. Per come la vediamo noi deve essere il datore di lavoro che avanza la regolarizzazione guadagnandone attraverso meccanismi di premialità. Invece così tutto viene pagato da chi già è sfruttato. E poi c’è il vulnus, sempre della Bossi Fini del legame fra contratto di lavoro e permesso di soggiorno. Il risultato è una legge profondamente razzista che non fa neanche incontrare regolarmente domanda e offerta di lavoro. Se non cambia il quadro di riferimento, la legge, le regolarizzazioni non bastano.
Con la pubblicazione del vostro ultimo rapporto avete allargato la ricerca alla filiera delle carni?
È un ambito dove regnano appalti, subappalti e cooperative illegali. Accade anche nella logistica, nella ristorazione, nell’edilizia. Si tratta di un modo per le aziende di competere sui mercati che comprime i diritti e i salari di chi lavora danneggiando anche le aziende che rispettano i contratti. Si tratta di concorrenza sleale.
In Italia, come accade in altri Paesi europei, servirebbe un sindacato più determinato e protagonista, capace di confrontarsi tanto col governo che con i datori di lavoro?
Nel nostro Paese, la crisi dei corpi intermedi si è manifestata nei partiti ma anche nel sindacato che cerca di difendersi più o meno bene. Avvertiamo malessere anche nei nostri confronti e dobbiamo assumere la consapevolezza di essere stati sconfitti sul piano politico e culturale. Come i partiti rischiamo anche noi di divenire marginali. Questo è il risultato delle politiche liberiste che in 30 anni hanno portato a tentare di distruggere ogni forma di organizzazione sociale. Riusciamo a rialzarci quando, al pari dei partiti, riconquistiamo in toto la credibilità, mettendo a frutto il fatto che, a differenza di molti abbiamo le radici ben piantate. Nelle nostre sedi ci sono Case del Popolo, sto per andare a inaugurarne una nell’entroterra tarantino dove lo Stato arretra. Per troppo tempo siamo andati nei luoghi di lavoro parlando solo di contratti. Quando ero giovane da me il sindacato veniva a parlare di legge finanziaria, delle tasse, coinvolgeva delegati e iscritti ad essere protagonisti di un cambiamento sociale. Dovremmo riaffermare questo approccio, rendere le persone con cui parliamo partecipi di un sistema di valori, proponendo una visione di società al pari dei partiti anche se con compiti diversi. Noi abbiamo scioperato tanto contro il governo Draghi, sostenuto da forze di centro-sinistra che contro il governo attuale. E i nostri sono stati entrambi scioperi politici perché non condividiamo manovre di stampo neoliberista. La politica europea non è cambiata e il liberismo serve per togliere risorse ai poveri per darle ai ricchi, un Robin Hood al contrario che non possiamo condividere. Se non ricostruiamo un legame forte con i nostri iscritti per realizzare cambiamenti, soffriremo come i partiti politici di astensionismo o del fatto che tutto venga delegato.
Fra i vostri iscritti quanto è alta l’astensione alle elezioni?
Nelle assemblee capita di vedere persone stanche e passive, senza una visione di società che noi non riusciamo a volte a proporre. Non generalizzo ma nella sinistra sconfitta di cui parlo ci siamo anche noi e dobbiamo prestare attenzione a questo. Anche la politica deve aprire una riflessione seria. Se non capiamo, non ricostruiamo e continuiamo a riproporre soluzioni organizzative che non risolvono i problemi. Non basta candidarsi alle elezioni. Infatti il nostro elettorato di riferimento è astensionista, magari molti restano anche iscritti alla Cgil ma nel rapporto col sindacato non sono sufficienti i buoni contratti. Dobbiamo raccontare il mondo, sono rare le assemblee in cui diciamo quale è la società in cui vorremmo vivere. Un nostro dovere perché altrimenti non avrebbero ragione di esistere le nostre battaglie per la giustizia sociale. Un tempo il rapporto fra Cgil e Pci era di discussione nell’autonomia. Ma ai partiti politici molti lavoratori oggi dicono “basta”, sono disillusi e spaesati, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Quindi non votano ed è sempre più difficile chiamare ad uno sciopero, soprattutto su questioni grandi come la sanità, la scuola, l’immigrazione. Guardando il flusso dei voti del settembre 2022 in molti sono andati a votare per il centro-destra perché, chi ci va, è arrabbiato. La maggioranza si è astenuta e si tratta di un problema nostro. Non è tutto così, nelle grandi fabbriche ancora teniamo e si riesce a garantire partecipazione agli scioperi, nelle altre realtà meno. Come sinistra penso che dovremmo, per tenere botta alle politiche neoliberiste, stare nelle piazze e contemporaneamente ricostruire la presenza nelle classi che vuoi rappresentare.
Per questo si siete riorganizzati anche come “sindacato di strada”?
Sì, stare fra gli ultimi, nei ghetti in cui vivono gli ultimissimi ma anche fra chi ha un contratto regolare o è impiegato. La Flai Cgil deve tenere insieme braccianti immigrati, forestali, pescatori, operai dell’industria alimentare. In quest’ultima che a volte è di eccellenza ci sono anche buone retribuzioni e premi di partecipazione. Il nostro compito è quello di tenere tutti insieme al di là delle tipologie contrattuali. L’unità salta perché sono troppo forti le differenze materiali e le condizioni di vita fra ognuno. Noi dobbiamo lavorare per piattaforme contrattuali che riguardino tutti contrastando lo sfruttamento, la piaga del sotto-salario che passa travestito dal divenire socio di pseudo cooperative.
Proprio per ottenere questo occorre maggiore radicalità?
Avendoci sbattuto il muso ti dico che non sono d’accordo. La radicalità non paga né i partiti né i sindacati. Da noi, non c’è la cultura come in Francia, degli scioperi ad oltranza. La nostra base di riferimento è tramortita dal neoliberismo che ci ha colonizzato la cultura, la psicologia, ci ha fatto entrare in testa che nella società si è soli. Mi capita di incontrare giovani che fanno fatica, come delegati Flai, perché sono poco politicizzati, non sanno praticare azione collettiva. Dobbiamo aprire una scuola politico sindacale, insegnare, affrontare la sconfitta culturale. Anche i nostri delegati sono bombardati dall’individualismo. Dobbiamo proporre valori come quello della solidarietà, poco raccontato perché altrimenti ti chiedono: “cosa mi porta lo sciopero?”. E forse dovremmo tornare a parlare dei fondamentali, cercando chiavi di lettura per questa società che è diversa da quella raccontata dalla comunicazione mainstream. Il sindacato se ne deve occupare, non diamo per scontato che i nostri delegati abbiano il nostro background e quindi vanno individuate anche le giuste modalità di comunicazione. Ma, tornando al rapporto fra radicalità politica e sindacale, se non realizzi la portata della sconfitta subita, scioperi ad oltranza e/o candidature, non producono altro che indifferenza. La nostra ambizione deve essere quella di non sostituirci ai partiti ma di avere i piedi ben radicati nelle classi sociali che dobbiamo organizzare, essere strumento utile per chi lavora. Io sono entrato nel sindacato criticando aspramente, ma quando sono finito in cassa integrazione senza sindacato sarei stato divorato. Questo valore va riscoperto anche dalle nostre burocrazie – termine a cui non do connotazione negativa – che devono riscoprire il proprio ruolo di essere al servizio di chi lavora.
Il Congresso nazionale della Cgil che ha ricevuto molte attenzioni e creato anche polemiche. Ha pesato troppo sul tono della kermesse?
Traggo un bilancio molto positivo dal nostro Congresso nazionale per diversi aspetti e non solo per la conferma del Segretario Generale. Ha avuto grande visibilità. Guardandomi indietro e pensando ai congressi passati, non c’era mai stata tanta attenzione da parte della società italiana. Anche nel congresso precedente eravamo molto più centrati su una riflessione che guardava noi stessi. C’era uno scontro fra gruppi dirigenti e non lo dico con una accezione negativa. Semplicemente l’organizzazione era più impegnata in un confronto interno che in un incontro con quanto avveniva fuori. Questo è stato intanto un congresso fortemente unitario in cui gli scontri sono stati sul merito. Lo Spi ha detto cose nette sulle pensioni, noi della Flai abbiamo espresso il nostro giudizio sulla guerra ecc…E poi abbiamo costretto le opposizioni in Parlamento a confrontarsi con noi rispetto ai temi del lavoro. Gli esponenti intervenuti non si sono potuti comportare come in un talk show, Maurizio Landini li ha chiamati a confrontarsi sul merito dei temi in discussione.
Riguardo alla partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni?
Non è stata cosa da poco. Meloni è stata la prima, dopo il secondo governo Prodi, a venire al nostro congresso e questo va apprezzato. Lo abbiamo considerato come il riconoscimento di una grande organizzazione sindacale con cui il governo ha soprattutto punti di divergenza, ma quelli di centro-sinistra o i “tecnici”, non sono mai venuti. Io vorrei che ci riflettessimo con meno spocchia e guardando ai fatti. Noi abbiamo un ruolo nel Paese e abbiamo richiamato alle responsabilità tutti i partiti dell’opposizione parlamentare che non riescono spesso a convergere. Ma per un sindacato che deve difendere chi lavora non può valere una pregiudiziale ideologica. I ministri Lollobrigida e Urso ci hanno convocato per discutere della questione dello sviluppo del settore agroalimentare. Dobbiamo andare a discutere con loro per risolvere i problemi di coloro che vogliamo difendere. Non siamo un partito politico. Ora c’è il “decreto pesca” e il fermo biologico che imporrà una contrazione del settore. Con chi dobbiamo andare a discutere di ammortizzatori sociali? Con una fantomatica opposizione divisa che non ha mai interloquito con noi? Credo che oggi non abbia più senso parlare di governo amico e governo nemico. Noi siamo autonomi dai partiti, rivendichiamo la nostra autonomia sia rispetto a governi di centro-destra che di centro-sinistra. E voglio ricordare che l’articolo 18 ce lo ha tolto Renzi, i tagli ai patronati che ci hanno fatto chiudere in alcune aree interne, sono serviti a colpire stupidamente il sindacato e nascono dai governi di centro sinistra col Pd.
Quanto al rispetto alla pregiudiziale antifascista?
Questo governo ha giurato sulla Costituzione. La contraddizione casomai ce l’hanno loro, di certo noi no. Nel Paese ci sono post fascisti e post comunisti e questi ultimi, bisogna dirlo, non si sono poi dimostrati tanto amici dei lavoratori. Noi siamo un soggetto politico perché abbiamo una nostra visione della società fondata sulla giustizia sociale, sui principi di solidarietà, ma non ci vogliamo sostituire ai partiti. Aggiungo che questo governo ha una contraddizione al proprio interno. La “destra sociale” deve dimostrarsi più sensibile al lavoro ma non esce in campo. Il risultato, per fare un ultimo esempio è la flat tax con cui si toglie ai poveri per dare ai ricchi. Proveranno ad aggiustare i prelievi per quanto riguarda le aliquote più basse ma alla fine ai lavoratori e alle lavoratrici lasceranno solo spiccioli. Se ne avvantaggerà chi ha redditi più alti. Noi dobbiamo parlare di questo e affrontare tali nodi se vogliamo incidere nella società e riprovare a cambiarla. Anche per questo credo che avremo una Cgil capace di assolvere ai compiti per cui è nata.
Con una percentuale che un tempo avremo definito “bulgara” (97,8%) al termine di un affollato congresso che si è chiuso il 9 febbraio scorso, lei Giovanni Mininni è stato confermato segretario generale della Flai Cgil. La 3 giorni congressuale è stata aperta con l’intervento di due donne, provenienti dall’Iran e dall’Afghanistan. Un segnale importante.
L’idea è nata dal fatto che bisognasse dare una scossa iniziale all’assemblea delle delegate e dei delegati. Nessuno fuori ne era al corrente e nessuno si aspettava che da un uomo partisse tale iniziativa. Loro sono state straordinarie ma a me è sembrato semplicemente necessario il loro intervento duplice sia perché oggi si parla di Iran ma l’Afghanistan è quasi dimenticato e poi perché le loro testimonianze non possono restare relegate nelle assemblee e nei luoghi delle donne. Io non voglio che il nostro sindacato sia compartimentato in file: donne, caporalato, lavoro nero ecc.. Quando discutevamo il documento della Cgil sulla questione delle pari opportunità io ho insistito anche attraverso gesti apparentemente solo simbolici come quello che hai visto, perché di tale questione si facciano carico anche gli uomini. Ritengo importante l’assemblea delle donne ma voglio che anche gli uomini prendano parola per rivedere sé stessi e i rapporti di potere che si stabiliscono anche nel sindacato. E vorrei che si ragionasse anche su quante volte, anche le donne riproducono le stesse modalità di gestione del potere, e di quanto si subisca la fascinazione del potere dominante. Bisogna essere franchi, da noi il potere esiste e bisogna trovare il modo di esercitarlo in maniera diversa, non prevaricatoria.