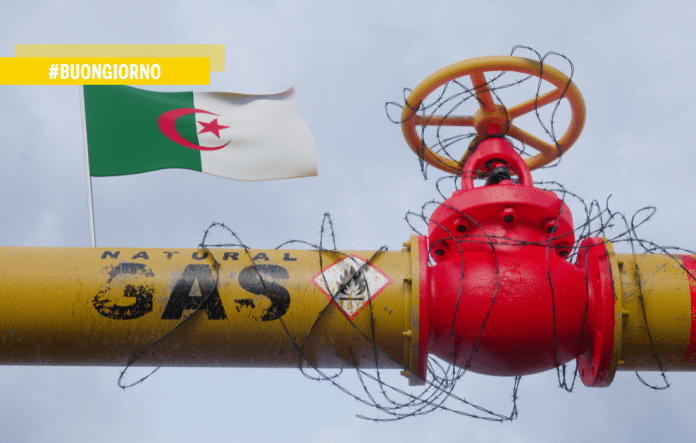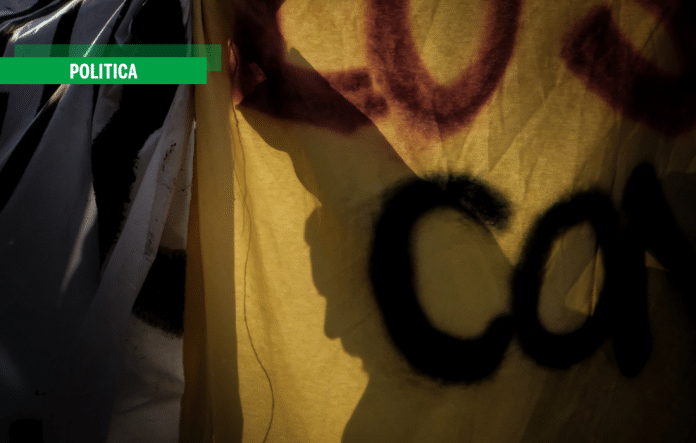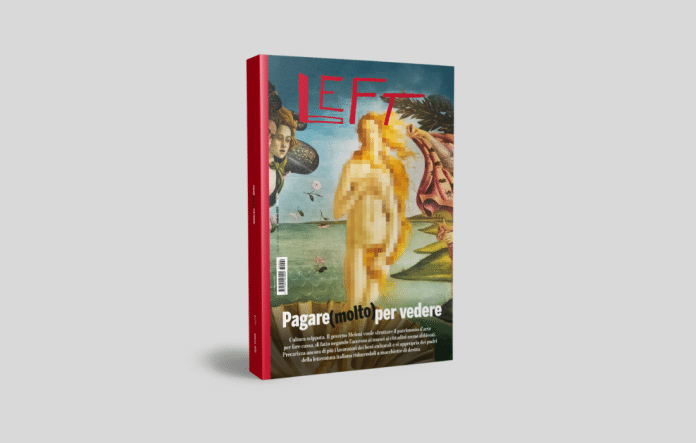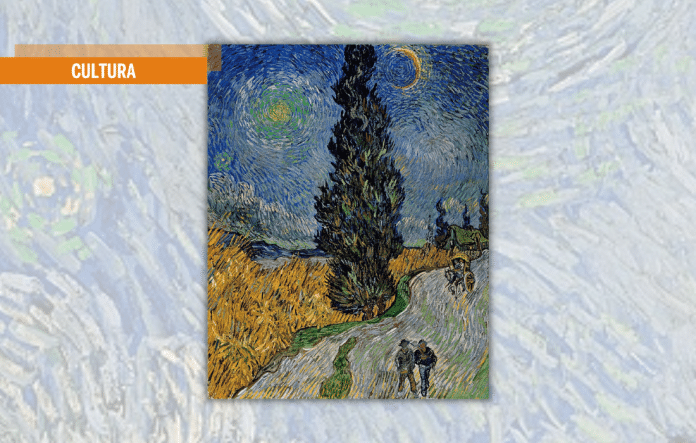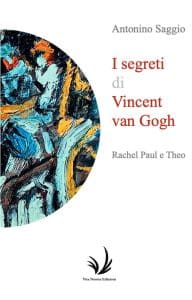In una fredda giornata abbiamo avuto il piacere di incontrare Alessandro Bergonzoni, di passaggio a Roma per portare in Auditorium le ultime repliche del suo spettacolo Trascendi e sali, e la performance artistica Tutela dei beni: corpi del (c)reato ad arte (il valore di un’opera, in persona). Con lui abbiamo discorso a lungo sui temi del linguaggio, dell’arte e dell’impegno civile.
A dicembre hai portato in Auditorium, nella cornice inusuale del Museo Aristaios, una tua performance molto potente sul dramma di Stefano Cucchi. Puoi parlarci di come è nata?
Si tratta di un’altra mia incursione, ma non sulla parola, poiché qui c’è solo la mia voce fuori campo. È un’istallazione, in cui proietto la dissolvenza e “assolvenza” di un’immagine: dalle parole assolvere e dissolvere, perdonare e far andare in nulla. Parallelo al teatro è sempre andato avanti in questi anni il mio lavoro artistico di installazioni: lavoro col ferro, col vetro, con la materia. Così sono arrivato alla forma performance in un periodo in cui c’era un acuirsi dei drammi del carcere. Questo lavoro tratta di beni, opere d’arte, sotto la soprintendenza delle Belle arti, e di beni, opera uomo, sotto la soprintendenza del ministero di Giustizia: quindi tutela, conservazione e preservazione di questi beni, che vanno difesi, sia opera uomo che opera d’arte. La performance la porto in musei sotto l’egida dello Stato, come l’Aristaios all’Auditorium parco della musica, o come ho fatto agli Uffizi o a Brera e in altri musei. Non in galleria, perché la galleria non è sotto la sovrintendenza dello Stato. Il mio scopo è rapportarmi al tema artistico, non tanto politico o sociale, della detenzione: dell’arte e della bellezza di opere d’arte uomo e del filo che le collega. A completare il tutto c’è poi l’impatto di questa performance, di cui non posso svelare l’immagine, racchiusa in 20 minuti: è un po’ la punta dell’iceberg del mio lavoro artistico in questi anni.
Un impegno civile dell’arte?
Sì, mai strettamente politico però. Mi è stato chiesto di partecipare, di iscrivermi a movimenti politici. La scelta è di essere ancora, insieme a Riccardo Rodolfi, due battitori liberi, di non avere una squadra per la quale si lavora. L’impegno civile e sociale degli ultimi anni mi ha portato a – parola che non sopporto – battaglie che preferisco chiamare “condivisioni”. Condivisioni molto forti, partecipazioni sul tema della malattia. Per esempio, sono testimonial della Casa dei risvegli da vent’anni. Mi occupo di sensibilizzazione sul tema del coma, degli stati vegetativi, della coscienza; fino anche ad arrivare a parlare della pazzia, della follia, del rapporto con il proprio corpo, fino alla disabilità, e agli annegati, proprio perché “bisogna esporsi”. Siamo tutti un’opera, un’opera operante, che deve operare, con un’esposizione che non sia soltanto mettere un quadro in una galleria o fare una performance, ma esporsi nelle scuole, nelle piazze, nelle radio, e sui giornali.
Di recente collabori molto con i giornali.
Ho iniziato una fortissima partecipazione giornalistica negli ultimi dieci, quindici anni, con due rubriche, una sul Venerdì, da cui è nato il libro che si chiama Aprimi cielo, e poi la rubrica su Robinson tutti i sabati da più di tre anni. Ha avuto un impatto anche sul mio modo di scrivere. Per quella di Repubblica sono sei parole, tre parole, una parola, e questo mi ha portato a diventare quasi un haiku del senso, a sunteggiare, a stringere, levare, come per una scultura. Per me che di solito amo la mole, amo la massa, amo l’eccesso, è il colmo; e poi il lavoro della scrittura mi ha portato fino agli incontri, con due persone che mi hanno parlato e confrontato al Finnegans wake di Joyce, ad esempio, ma prima che io lo leggessi, dicendo che con lui avevo affinità. Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, importanti e noti traduttori, mi hanno coinvolto in più eventi per parlarne.
Beh, tu sei in un certo senso un Joyce italiano.
Ringrazio loro, e te che lo ricordi, lusingato e responsabile. Le sue opere me le sono andate a vedere, mi sono letto, tra virgolette, Finnegans wake, a Dublino l’abbiamo “incontrato” e festeggiato e ci sono delle cose che ci uniscono. Se poi, a morte avvenuta, il mio lavoro possa essere tradotto, come è stato tradotto Finnegans wake da chi altamente ci è riuscito, io questo non lo so, lo spero. Mi piace pensare che forse si possano tradurre anche cose mie (è il mio limite e la mia frustrazione attuale col teatro). La mia parola l’ho portata di recente all’Istituto di cultura italiana a Parigi, a Salamanca, all’università, ad Amburgo, per poter, lì sì, parlare del mio lavoro in italiano con gli studenti di italiano. La grande novità è questa: poter lavorare il più possibile con i madrelingua stranieri che studiano la mia lingua, come ad esempio ad Oxford con gli studenti che studiavano italiano e che hanno fatto incontri con me per parlare di vita, scrittura, surrealtà, arte.
Cosa pensi che l’arte dovrebbe fare in questo momento storico e cosa non dovrebbe fare?
Sono ancora uno studente da un punto di vista di conoscenza artistica. Lo sa la mia compagna, figlia del pittore Pirro Cuniberti, che ha anche un po’ illuminato le mie lacune nel leggere l’arte, anche se l’istinto e l’impatto, diciamo così, percettivo possono permettermi di lavorare, e ricercare, come mi hanno detto alcuni galleristi. Vedo che ora però il mercato è diventato molto “finanziario”, è un mercato vero e proprio, è vendita, è scambio, è prodotto. E mi accorgo che c’è la finanza anche dietro l’arte: un tema che mi perplette. Indubbiamente per me l’arte ha innanzitutto sempre un rapporto con la parte spirituale, visionaria, con la parte immaginifica, con la parte ad oltranza, ossessiva, che sicuramente fa vedere quello che c’è dietro l’opera: tutto quello che non vedi, dell’opera, quello che ti fa mistero, non la sola rappresentazione materiale. Questo mi interessa: andare a cercare nelle biennali, andare a vedere nelle mostre, nei musei, cercare l’arte contemporanea, l’arte moderna, e cercare di lavorare anche con la scrittura, con il segno, col tratto, per cavare fuori qualcosa. Di solito nel teatro, nella scrittura, carico, riempio, ma nell’arte mi piacerebbe invece arrivare all’essenza, pulire, rendere un oggetto o una particolare installazione talmente secca e asciutta da cercare di far intravedere un assoluto quasi fino alla cellula stessa.
L’arte come mistero, dunque?
Spesso cerchiamo il significato di un’opera d’arte. Io mi lascerei molto più andare, mi affiderei anche al buio, al mistero, all’arcano, al sacro. Anche questo è un tema che mi coinvolge molto: in certi luoghi, come le carceri, gli ex manicomi – e io i manicomi li ho frequentati per andare a trovare amici o persone che mi avevano coinvolto nelle loro vite – fare opere, presenziare, fare gesti, “fare voce”, fare suoni già parte di un’opera artistica. Dentro le quattro mura di una cella di due metri per tre, dentro un luogo che vedeva una volta i letti di contenzione, tutto quello che prima della legge Basaglia era stato tortura, devastazione, vessazione, violenza: lì dentro si devono continuare a portare arti ed arte. Ora sto, per esempio, preparando un’installazione legata alla guerra ma non solo: il tavolo delle trattative. Un grandissimo tavolo, sostenuto non dalle sue gambe, ma da arti artificiali, le gambe delle persone che hanno perso gli arti perché nessuno si è seduto al tavolo delle trattative. Quando dicono che la guerra c’è sempre stata, è vero, ma non per questo io non chiedo la pace. Vorrei interrompere questo ciclo, pretendo queste interruzioni. (L’idea è piaciuta molto anche a Emergency). Sono tantissime le immagini che abbiamo visto grazie a Gino Strada di tutte queste persone mutilate e successivamente salvate attraverso appunto arte ed arti. Che siano, questi, un simbolo che sostiene un’operazione che non si è fatta e che si deve fare.
Stai pensando ad altre opere di questo tipo?
L’altra opera è un podio infinito. In una piazza. Il podio infinito è un podio che comincia dal quarto posto e non finisce: perché non c’è un primo, un secondo e un terzo. Non vince nessuno, ma molto spesso perdono tutti, quando non vincono tutti. Ribalta completamente il tema dell’agonismo, del suprematista, del prevaricare. Un’altra installazione può essere un’altalena, un’altalena da muro, contro il muro. Tu la puoi spingere ma il bambino va a sbattere con la schiena. Così anche uno scivolo che va a finire contro le macerie, un gioco che c’è, ma il bambino non si può più divertire perché qualcosa lo impedisce; lo blocca una guerra, lo blocca una bomba, un palazzo distrutto, lo blocca la povertà. Come mi piacerebbe fare per il tema del riscaldamento climatico, una lapide con scritto: “Terra: terrà?”. Un’opera? Ma anche uno slogan. Scrittura che fissa. Questa versatilità mi ha portato ad un’altra frase per i migranti che passarono quel delirante numero di giorni in mare, nella Diciotti, in quelle condizioni. Scrissi: “la miglior difesa è l’attracco”. In quella frase che cosa c’era? Salvezza e invocazione? Forse tutto, senza eccezioni.
In apertura: Alessandro Bergonzoni, foto di Chiara Lucarelli