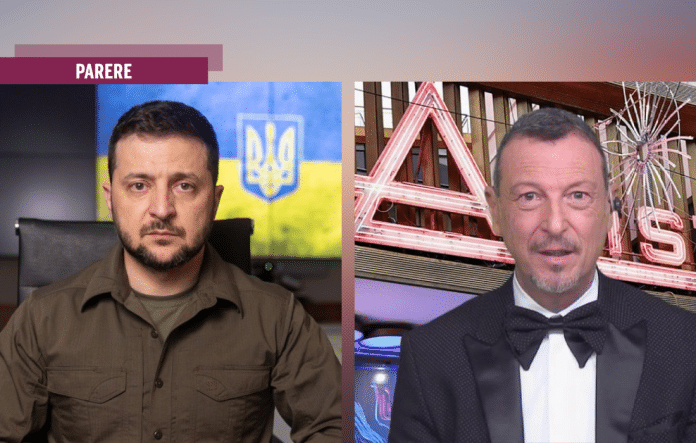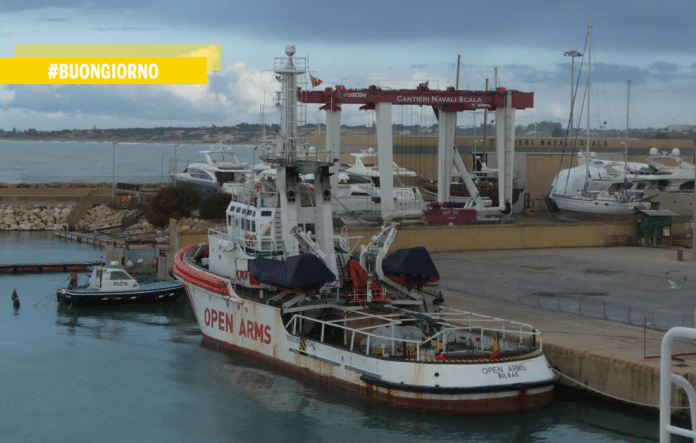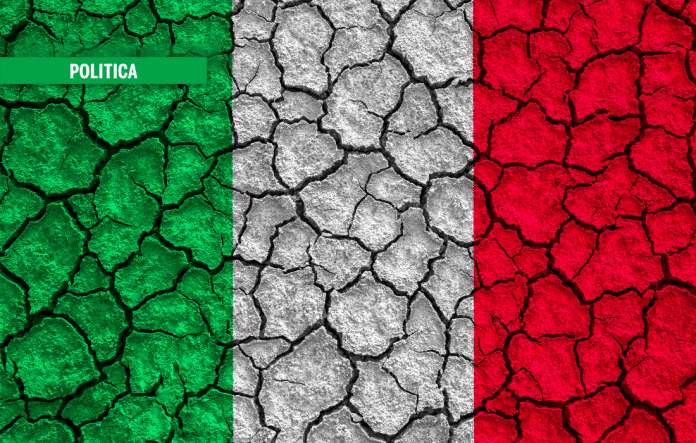Nel fiume quasi ininterrotto delle esternazioni che i nuovi vertici politici del Collegio Romano hanno prodotto dal momento del loro insediamento e pur nella contraddittorietà e confusione di molte dichiarazioni, un elemento comune è subito emerso con grande chiarezza: il nostro patrimonio culturale ha un valore economico che occorre sfruttare. E poiché l’Italia è una «superpotenza culturale mondiale» (Sangiuliano dixit), questa rendita economica dovrà finalmente essere commisurata a tale importanza culturale.
Da questo punto di vista, ciò che i nuovi inquilini del Ministero proclamano a gran voce, non è poi così distante dalla visione affermatasi nell’era Franceschini: magari espressi con maggiore rozzezza rispetto all’abilità da politico navigatissimo del precedente ministro, ma obiettivi di fondo e anche armamentario retorico si collocano in linea di perfetta continuità con quella stagione politica nella quale, con significativa accelerazione negli ultimi anni, il nostro patrimonio culturale è sostanzialmente stato utilizzato come palcoscenico privilegiato per le liturgie del potere, nell’abbandono sostanziale di ogni politica di governo del paesaggio, vale a dire del territorio nazionale.
E infatti, nessuna revisione dell’impianto delle così dette riforme Franceschini è minimamente all’orizzonte, e anzi tutto sembra procedere piuttosto verso la radicalizzazione di taluni orientamenti.
A partire dai musei. Di fronte a uno dei più clamorosi fallimenti dell’era Franceschini, quel Sistema museale nazionale che avrebbe dovuto finalmente superare la cesura fra musei statali e musei pubblici di enti locali e musei privati e soprattutto cercare di allineare gli standard delle nostre istituzioni museali a livelli europei, l’unico requisito cui aspira adeguarsi il nuovo corso è quello del costo dei biglietti. Via libera quindi agli aumenti (in taluni casi fino al raddoppio) perché «se una cosa ha un valore storico, artistico, culturale, deve anche essere pagata, come del resto i turisti pagano gli hotel» (il ministro Sangiuliano, 10 gennaio 2023): così da marzo prossimo, visitare i soli Uffizi costerà 25 euro, senza Pitti e, naturalmente senza il corridoio vasariano, già in predicato per diventare uno dei luoghi più costosi del nostro patrimonio culturale.
Difficile trovare un’espressione più chiara della visione tardo-neoliberista di questa destra governativa: assodata la riduzione a merce del patrimonio culturale e il suo uso turistico come fine unico, l’obiettivo è quello di rincorrere il privato (gli albergatori) sul piano della capacità di sfruttamento della risorsa.
In questa direzione, l’attenzione politica e mediatica, come già negli ultimi anni, si concentra sulle grandi istituzioni e in particolare sulle solite galline dalle uova d’oro – dal Colosseo, agli Uffizi, a Pompei – le più economicamente e iconicamente significative, cui si cerca di aggiungere ora il Pantheon, reso appetibile, per lo sfruttamento turistico, dai milionari accessi di visitatori, che saranno presto costretti a pagare un biglietto di ingresso. La giustificazione di un allineamento con altri Paesi europei è apparsa peraltro subito risibile: il biglietto per il Louvre (il più grande museo occidentale) costa oggi 17 euro, mentre British Museum e National Gallery sono a entrata libera, ma soprattutto queste istituzioni offrono tutte, da anni, un livello di servizi al visitatore – online e on site – in termini di informazione, accoglienza, iniziative formative, eventi e via elencando, di livello incomparabilmente maggiore.
La decisione della direzione del Louvre, resa pubblica recentemente, di limitare gli accessi a un numero di visitatori che possa consentire una esperienza migliore del patrimonio esposto e facilitare il lavoro degli operatori del museo, testimonia, anche per una istituzione ormai vocata prioritariamente all’utenza turistica, un atteggiamento ben più rispettoso nei confronti di chi visita il museo parigino, e di uno spirito di servizio che sa superare anche le ragioni puramente monetarie. In Italia, al contrario, è proprio il Ministero ad abbracciare, coûte que coûte, un trend “sviluppista” il cui indicatore principale è solo quello quantitativo, mentre gli unici, deboli (e talora ignorati) limiti numerici all’accesso di alcuni dei più affollati luoghi della cultura sono quelli – invalicabili – legati alle norme di sicurezza e incolumità.
In una decisione di questo tipo, l’atteggiamento – gravissimo – di indifferenza politica nei confronti di una situazione del Paese economicamente difficilissima, a un passo dalla recessione, con il livello delle disuguaglianze che aumenta a dismisura è l’altra faccia della medaglia rispetto a una concezione del patrimonio culturale cui non si sa trovare alcun altro scopo se non quello di divertissement esclusivo per turisti. Di questa visione a dir poco ristretta sulla funzione del nostro patrimonio culturale e dei musei in particolare, sono parte integrante le modalità autocratiche, in stile che potremmo definire Ancien régime, che connotano la loro gestione. Al di là di ciò che riguarda gli aspetti tecnici legati ad esempio alla conservazione degli oggetti o alla manutenzione degli allestimenti, infatti, quanto pertiene alla visione espressa attraverso il racconto degli oggetti esposti, mai neutrale, ma frutto di scelte più o meno esplicite, dovrebbe essere il risultato di un confronto ampio e articolato.
Il museo pubblico non è una collezione di oggetti, ma uno strumento culturale al servizio di una comunità più o meno ampia di visitatori e sarebbe quindi opportuno che soprattutto le scelte che vanno a modificare assetti, finalità, concezioni allestitive fossero illustrate nel dettaglio, non solo con un pubblico di addetti ai lavori e non solo “a cose fatte”.
È evidente che proposte e decisioni finali non possano che rimanere nelle mani di chi dirige e opera all’interno dell’istituzione, ma come momento iniziale e finale di un processo di condivisione che renda l’istituzione finalmente più aperta all’esterno e attivi quelle forme di partecipazione tanto spesso declamate in convegni e conferenze stampa, quanto negate nella pratica dei fatti o, ancor peggio, ridotte ad operazioni cosmetiche, dai sondaggi social ai questionari una tantum. Eppure anche Icom, l’organizzazione internazionale punto di riferimento per il mondo degli operatori museali, nella recente nuova definizione di museo (cfr. Left n. 30/2022), pur se drasticamente edulcorata, proprio per la pressione dei comitati nazionali più “tradizionalisti” fra cui quello italiano, ha sottolineato l’importanza della partecipazione della comunità alla vita del museo.
Al contrario, la norma, per i nostri musei, è che ogni decisione su allestimenti, esposizioni, iniziative culturali, in pratica la vita del museo stesso, venga decisa da un ristrettissimo numero di persone che spesso non includono neppure i Comitati scientifici, se non come semplice informazione.
Questo modus operandi, oltre che espressione di una visione museologica profondamente attardata, diventa tanto più grave quando rischia di stravolgere un assetto istituzionalmente e culturalmente importante come è quello della museografia archeologica della Capitale.
L’autrice: Archeologa classica, Maria Pia Guermandi è responsabile dell’Osservatorio beni e istituti culturali della Regione Emilia-Romagna e di numerosi progetti europei. Con Tomaso Montanari dirige la collana Antipatrimonio di Castelvecchi