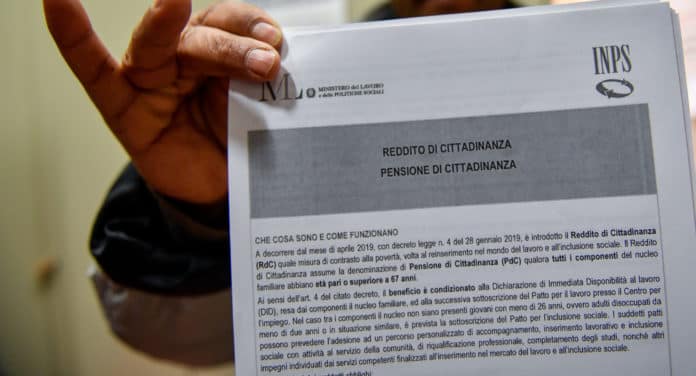Nell’anno della pandemia, il 13,5% del totale dei bambini e ragazzi presenti in Italia è in povertà assoluta. Una popolazione di 1 milione e 337 mila minori che non accede a un paniere di beni e servizi considerato essenziale per garantire uno standard di vita minimamente accettabile. Più di un bambino su dieci si trova in questa condizione e vive quindi in famiglie che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena.
La pandemia ha contribuito a peggiorare ulteriormente la condizione infantile e questo non solo dal punto di vista materiale: nell’ultimo anno e mezzo bambini e ragazzi hanno sperimentato una condizione di deprivazione educativa e culturale senza precedenti. La sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia, la chiusura delle scuole (totale nella prima fase e a macchia di leopardo nella seconda), quella di molte attività ricreative (es. cinema, teatri, biblioteche) ha prodotto una condizione di povertà educativa che è destinata ad avere effetti di lungo periodo sull’apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze.
l circolo vizioso della povertà educativa
Con il termine povertà educativa Save the children fa riferimento al processo che limita il diritto dei bambini a un’educazione e li priva dell’opportunità di imparare e sviluppare competenze di cui avranno bisogno da adulti. Povertà educativa e povertà materiale sono legate da un circolo vizioso: i bambini che provengono da famiglie svantaggiate hanno più probabilità di conseguire peggiori risultati a scuola, hanno meno possibilità di partecipare ad attività sociali, culturali e ricreative, di svilupparsi emotivamente e di realizzare il proprio potenziale. Una volta diventati adulti, questi bambini incontrano poi maggiori difficoltà ad attivarsi nella società e a trovare lavori di qualità. La povertà materiale di una generazione si traduce spesso nella privazione di possibilità educative per quella successiva, determinando nuova povertà materiale e di rimando altra povertà educativa, e così via.
Povertà materiale e povertà educativa sono quindi saldamente legate e, prima di ragionare sulle strategie che possono contribuire a spezzare questa dinamica, è necessario guardare all’evoluzione della povertà (materiale) dei bambini per avere contezza del già drammatico quadro in cui la pandemia ha impattato.
Lo spartiacque della crisi del 2008
La povertà infantile ha iniziato a crescere in maniera significativa in conseguenza della crisi economico-finanziaria del 2008. Prima di tale crisi, la quota di minori in povertà assoluta era pari a quella della popolazione complessiva (3,1%). Negli anni successivi la povertà minorile è cresciuta più rapidamente rispetto a quella della popolazione generale e, nel 2020, lo scarto fra la povertà dei minori (13,5%) e quella della popolazione complessiva (9,4%) ha superato i 4 punti percentuali.
Questo trend è ancora più evidente se confrontiamo i tassi di povertà relativa (calcolata sulla base del reddito medio) di bambini e anziani. Alla fine degli anni novanta, questa forma di povertà interessava circa il 12% dei minori; negli anni successivi tale valore è cresciuto continuamente, arrivando a superare il 20% nel 2020. Nel caso degli anziani, invece, il trend è inverso. Alla fine degli anni novanta l’incidenza della povertà fra gli over 65 si attestava attorno al 16%, successivamente si è progressivamente ridotta fino a dimezzarsi nel 2020 (8,1%). Nel 2008, dunque, il livello di povertà relativa nei due sottogruppi era sostanzialmente simile e solo successivamente è andato a divergere così fortemente. A dimostrazione del fatto che la crisi economica-finanziaria ha ridefinito il profilo della povertà. Se alla fine degli anni novanta gli anziani costituivano tradizionalmente una categoria particolarmente fragile, più esposta ai rischi della povertà, oggi tale fragilità è tipicamente dei minori.
Ma perché la povertà infantile è cresciuta così prepotentemente? I minori in povertà hanno spesso genitori che partecipano in maniera debole al mercato del lavoro; ad esempio perché hanno contratti temporanei, percepiscono un salario inferiore alla media, sono sottoccupati o lavorano (involontariamente) part time. Tutte tendenze che si concentrano sulle nuove generazioni piuttosto che sulla forza lavoro più anziana e che hanno portato a scaricare i costi della crisi economico-finanziaria del 2008 sui giovani adulti (e sui loro figli). I loro redditi infatti, al contrario di quelli da pensione, non hanno retto l’impatto della crisi.
Pandemia e conciliazione
In questo impietoso scenario, è poi è arrivata la pandemia. Così negli ultimi due anni bambini e ragazzi hanno sperimentato (anche) una condizione di deprivazione educativa senza precedenti. Che ha colpito soprattutto quelli già in condizioni di fragilità. Quali strategie si possono mettere in campo per sostenerli?
Bisognerebbe sostenere l’occupazione femminile attraverso l’erogazione di servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti a bambini e ragazzi. In sostanza, un serio investimento sulle cosiddette “politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” permetterebbe di aumentare il reddito di molte famiglie e sarebbe strategico per ridurre la povertà materiale ed educativa di bambini e ragazzi.
Sul fronte della povertà materiale è infatti noto che le politiche di conciliazione promuovono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e questo chiaramente contribuisce a ridurre la povertà materiale dei minori dato che le famiglie monoreddito hanno un rischio di povertà notevolmente superiore rispetto a quelle in cui i redditi sono due.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante in questo momento storico. Infatti, mentre le recessioni “tradizionali” hanno colpito settori caratterizzati da una più alta incidenza dell’occupazione maschile le misure di distanziamento legate alla pandemia da Covid-19 hanno impattato soprattutto sul terziario, che vede occupate in misura maggiore le donne rispetto agli uomini. Inoltre, l’iniqua distribuzione del lavoro di cura all’interno delle famiglie è stata esasperata dalla sospensione delle attività educative/scolastiche e dal ricorso alla didattica a distanza.
Secondo una ricerca realizzata dall’Inapp, con la fine del primo lockdown (marzo-maggio 2020), quando nelle coppie con figli è stato possibile scaglionare i rientri al lavoro, sono state perlopiù le donne a rimanere a casa. Uno stop che in alcuni casi è stato temporaneo, mentre in altri ha preceduto la decisione di dimettersi definitivamente per esigenze familiari.
Benefici bidirezionali
Puntare sulla conciliazione avrebbe un effetto significativo anche sulla povertà educativa. Infatti, se la conciliazione si sostanzia in servizi educativi, ricreativi e culturali il beneficio per bambini e ragazzi è evidente. Un esempio lampante in questo senso è quello dei nidi di infanzia. L’accesso a servizi educativi di qualità nei primi anni di vita può promuovere la rottura del legame negativo fra povertà educativa e materiale. Nella primissima infanzia, infatti, lo sviluppo delle reti neurali che costituiscono l’architettura cerebrale e le basi delle competenze avviene a una velocità elevatissima, che non si riprodurrà mai più nel corso della vita. Tale processo andrebbe quindi sostenuto da opportunità educative precoci rivolte soprattutto ai bambini più vulnerabili.
Purtroppo però, allo stato attuale le cose funzionano esattamente al contrario e i nidi sono di fatto un “servizio d’elite”. I dati Istat mostrano infatti che nelle famiglie i cui bambini frequentano un nido sono sovrarappresentate le coppie in cui entrambi i genitori lavorano, i redditi superiori alla media e i titoli di studio più elevati.
In conclusione, è ampiamente riconosciuto che le politiche di conciliazione giocano un ruolo di primo piano nel promuovere l’occupazione femminile e, di conseguenza, lo sviluppo economico. Ma, nella fase attuale, è utile focalizzare l’attenzione anche sul ruolo che queste politiche possono giocare nel promuovere un miglioramento della condizione infantile.
* L’autrice: Chiara Agostini, ricercatrice in Analisi delle politiche pubbliche, fa parte di Percorsi di secondo welfare, un laboratorio di ricerca legato all’Università degli Studi di Milano che si propone di ampliare e diffondere il dibattito sui cambiamenti in atto nel welfare italiano

L’articolo prosegue su Left del 5-11 novembre 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO