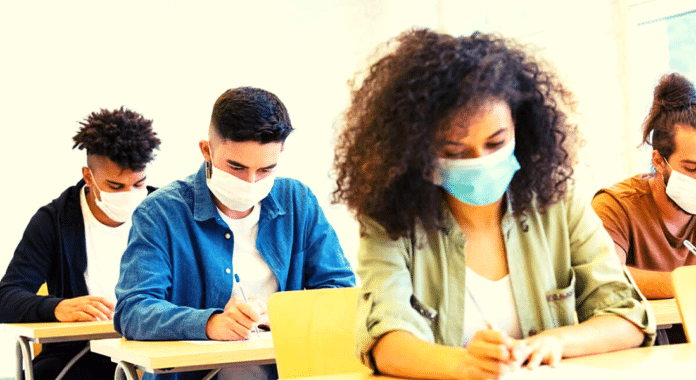Venire a conoscenza di una petizione per abolire le prove scritte dell’esame di maturità, soprattutto nel constatare l’enorme seguito che ha suscitato (oltre 25mila adesioni), ha destato in me, logopedista, alcune domande.
Le motivazioni che hanno dichiarato i maturandi, tengono conto delle difficoltà ulteriori cui è andata incontro la scuola a causa della pandemia (chiusure imposte, Dad ecc), che hanno certamente aggravato una situazione già critica.
Questi ragazzi si sentono penalizzati dal confronto con gli alunni degli anni precedenti, per i quali considerano un’agevolazione l’aver affrontato l’esame di maturità in piena pandemia. Ma perché l’idea di affrontare gli esami in forma scritta ha mosso alcuni studenti ad organizzare una petizione?
In un’epoca in cui si viene valutati in base alle competenze e le performances sono associate all’esposizione e all’utilizzo della tecnologia digitale fin dalla prima infanzia, è possibile che gli alunni, non riescano ad acquisire e a consolidare nel tempo la capacità di scrittura?
Che cosa significa scrivere, produrre un elaborato?
Scrivere è un atto creativo, per realizzare il quale, bisogna coniugare competenze visuo-grafo-motorie con contenuti del pensiero. Produrre la linea sul foglio ed esprimere le proprie idee, necessita di fantasia, assolutamente personale, che conduce l’individuo, nel tempo, a rendere la scrittura un atto originale.
La scrittura si differenzia dal linguaggio articolato perché viene appresa, non viene acquisita naturalmente dal bambino.
L’apprendimento della scrittura, necessita, quindi, di grande esercitazione e di tempi lunghi, per poter diventare una espressione personale.
A conclusione dell’ultimo ciclo scolastico, si suppone che l’apprendimento della scrittura, almeno negli aspetti esecutivi, sia giunto a completamento. Con la progressiva maturazione dell’esperienza di ciascuno, la scrittura personale si arricchisce di maggiori contenuti.
Prima di arrivare all’esame di maturità, questi ragazzi hanno attraversato gli ordini di scuola precedenti.
Possiamo ipotizzare che la richiesta di abolizione di prove scritte sia il frutto, non soltanto degli ultimi due anni di pandemia, che, certo, ha ulteriormente impoverito il sistema scolastico, ma di un percorso di apprendimento della scrittura pervaso di difficoltà di varia natura. Imparare a scrivere è un percorso lungo e complesso che richiede molto allenamento, è quindi necessario dedicarsi precocemente, già a partire dall’asilo nido e dalla scuola dell’infanzia, a far sperimentare ai bambini, con tutto il corpo, gesti, manipolazioni, movimenti che saranno fondamentali per coordinare, più avanti, l’occhio e la mano con il pensiero.
Dove queste esperienze risultano mancanti, in particolare nella scuola primaria, le difficoltà che ne seguono possono sfociare nei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Questi disturbi interessano selettivamente la lettura (dislessia), la capacità di manipolare la lingua scritta (disortografia), le capacità di calcolo e problem solving (discalculia), corredati o meno, in modo trasversale, dalla disgrafia, difficoltà di eseguire fisicamente la scrittura (esito di un pregresso disturbo della coordinazione motoria).
Attualmente i dati a disposizione, pre-pandemici, rilevano la presenza di una diagnosi di Dsa nel 3,2% della popolazione scolastica (scuola pubblica), con una maggiore incidenza nel Centro-Nord e con una percentuale inferiore nel Sud, territorio, com’è noto ad alta dispersione scolastica, (il che fa supporre anche una minore probabilità che gli alunni vengano segnalati ai Servizi sanitari).
Restiamo in attesa di pubblicazioni più attuali, consapevoli che la pandemia ha aumentato il gap tra i diversi strati sociali in tutto il territorio italiano, per cui la previsione è di un aumento sia della dispersione scolastica sia delle segnalazioni (e certificazioni) per Dsa.
Ma ci sono davvero così tanti alunni con disturbi di apprendimento fin dalla scuola primaria? O non stiamo piuttosto assistendo ad un processo di medicalizzazione dei bambini che “restano indietro” negli apprendimenti, perché si intravede, nel perseguire la strada dell’assistenza sanitaria, un accessibile supporto alla pluri-depauperata istituzione scolastica?
Certo è che la dedizione e l’impegno dei professionisti che gravitano intorno a questi bambini e alle loro famiglie, può fare la differenza. Di fronte alle prime difficoltà di acquisizione della scrittura, sarebbe opportuno non arrendersi, cedendo alla facile soluzione di sostituire il gesto visuo-grafo-motorio con un dispositivo digitale, ma insistere, affinché questi alunni non perdano la possibilità di tracciare linee sul foglio, esprimendo autonomamente il loro pensiero, portatori di una calligrafia originale.
Come auspicato il 7 ottobre scorso dagli esperti durante il Convegno nazionale 2021 dell’Associazione italiana disgrafie (“Scrivere ancora a mano nel Terzo millennio”), prima di inserire questi bambini e ragazzi in un circuito sanitario abilitativo, con approfondimenti diagnostici ed eventuale diagnosi, bisognerebbe consentire loro di affrontare un periodo di potenziamento didattico-pedagogico, allo scopo di favorire l’inclusione scolastica e ridurre i falsi positivi con il progredire dell’età.
Come documentato più volte nelle pagine di Left, gli insegnanti italiani si trovano ormai da decenni, ad affrontare difficoltà su vari livelli, dovute alla dequalificazione della scuola pubblica.
In ambito didattico-pedagogico è ormai assodata l’importanza della relazione nel processo di insegnamento-apprendimento, non soltanto della scrittura, in cui la partecipazione attiva docente-discente alimenta la motivazione di entrambi ad acquisire (e far acquisire) nuove conoscenze.
Considerato il lungo periodo che la scuola occupa nel corso della vita degli individui, è sempre più indispensabile rimodulare il sistema scolastico nel senso di rispettare i tempi di apprendimento di ciascuno e adeguare le modalità di istruzione, per rendere concreta un’idea di bambino come essere pensante e sociale fin dalla nascita, per attuare davvero una prevenzione verso i disturbi del neurosviluppo.
Avere una fisiologica paura ad affrontare l’esame di maturità è più che legittimo, non unicamente per la natura delle verifiche da sostenere, ma soprattutto in quanto esso rappresenta l’ineluttabile passaggio all’età adulta: è compito di noi adulti di riferimento mettere in condizione bambini e ragazzi di poter affrontare le prove della vita nel modo più adeguato possibile, fin dalla tenera età.
Foto di free stock photos from www.picjumbo.com da Pixabay

L’editoriale è tratto da Left del 5-11 novembre 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO