«In mancanza di azioni concrete, il mondo rischia di non soddisfare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) dell’Onu e l’Accordo di Parigi, e le future generazioni erediteranno un pianeta gravemente danneggiato in cui gran parte della popolazione soffrirà sempre più di malnutrizione e malattie prevenibili». Inizia con questo monito il rapporto preparato dalla Commissione Eat-Lancet su diete sane da sistemi alimentari sostenibili.
Entro il 2050, la popolazione mondiale sarà di 10 miliardi di persone, e con tale crescita aumenterà anche la domanda alimentare senza contare che le regioni più sviluppate del pianeta consumano più cibo di quanto necessitano e molti tipi di alimentazione sono ricchi di prodotti che impattano negativamente sull’ambiente.
Per garantire cibo a sufficienza per le generazioni future e al tempo stesso minimizzarne l’impatto ambientale, è necessario passare a produzioni alimentari più sostenibili e cambiare le nostre abitudini a tavola. È infatti ben noto come le scelte alimentari abbiano un impatto rilevante sul consumo di acqua, l’utilizzo delle terre, produzione di gas impattanti sui cambiamenti climatici, oltre che, naturalmente, su numerosi aspetti sociali, etici ed economici che minacciano la sicurezza alimentare futura.
È ovvio che un tema di tale portata dovrà essere considerato innanzi tutto nelle politiche agricole ed economiche e nelle strategie di intervento sul territorio, ma anche nei programmi di educazione alimentare e nelle linee guida per l’alimentazione con l’intento di aumentare la consapevolezza del consumatore alle problematiche emergenti e a cui tutti siamo chiamati a dare una risposta.
In quest’ottica, per la prima volta in Italia nelle edizioni delle Linee guida per una sana alimentazione, è stata presa in considerazione una direttiva dedicata alla sostenibilità, e questo perché oggi sappiamo che la salute dell’uomo non può prescindere dalla salute dell’ecosistema. Definire l’adeguatezza della dieta anche in termini di sostenibilità è difficile dal momento che devono essere presi in considerazione non solo gli aspetti di carattere squisitamente nutrizionale (es: come assicurare tutti i nutrienti), ma anche quelli alimentari (es: come scegliere gli alimenti in funzione della qualità dei nutrienti), di comodità d’uso e del recupero di tradizioni e tipicità. A tutti questi aspetti si devono però aggiungere anche importanti considerazioni riguardo la sostenibilità.
Secondo una definizione della Fao, «le diete sostenibili sono quelle che hanno un basso impatto ambientale e che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale e a una vita sana per le generazioni presenti e future. Le diete sostenibili sono rispettose della biodiversità e degli ecosistemi, culturalmente accettabili, accessibili, economicamente eque e convenienti, nutrizionalmente adeguate, sicure e salutari, favorendo allo stesso modo l’ottimizzazione delle risorse naturali e umane».
Quali comportamenti e quali scelte alimentari può fare il consumatore in relazione all’impatto ambientale?
Il consumatore può fare molto per la propria salute e per la tutela dell’ambiente attraverso le proprie scelte alimentari come ad esempio consumare meno cibo, sprecarne di meno e ridurre il consumo di prodotti alimentari di origine animale, optando per alternative di origine vegetale. In particolare, la tendenza al sovraconsumo alimentare è molto diffusa nel mondo occidentale estendendosi ai Paesi in via di sviluppo, soprattutto in economie emergenti come Cina e Brasile. La conseguenza di una alimentazione eccessiva non è solo quella di provocare un aumento del sovrappeso e dell’obesità ma al tempo stesso determina una superflua domanda alimentare che fa aumentare coltivazioni e allevamenti e il loro conseguente impatto ambientale. Tutto questo a discapito di molte regioni del pianeta dove è ancora alto il numero di persone denutrite.
Altro tema dominante è quello dello “spreco alimentare”, termine che si riferisce comunemente al cibo non consumato, che dunque si trasforma in rifiuto e in dispersione di risorse. Secondo la Direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea, la fase del sistema agroalimentare in cui vi sono maggiori sprechi e perdite è quella del consumo casalingo (43%). Questo dato è confermato anche dalle stime italiane secondo cui il 53% dello spreco alimentare si realizza lungo la filiera di produzione e distribuzione e il restante 47% è responsabilità dei consumatori. A livello internazionale si sta ponendo sempre maggiore attenzione alle misure di prevenzione volte al recupero delle eccedenze alimentari. Molti Paesi, tra cui l’Italia, stanno adottando formalmente impegni di riduzione degli sprechi e delle perdite alimentari. In Italia nel 2016 è stata approvata una legge finalizzata proprio alla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La legge prevede la promozione di campagne informative per incentivare la riduzione dei rifiuti alimentari con specifica attenzione alle pratiche virtuose nelle attività della ristorazione per sensibilizzare consumatori e produttori.
Mangiare meno scegliendo alimenti vegetali
I motivi che devono spingerci a una tale scelta sono da una parte legati al fatto che la produzione di alimenti di origine animale determina un maggiore impatto ambientale in termini di sfruttamento delle risorse agricole e idriche e emissioni di CO2 per tonnellata di proteine consumate rispetto a quelle di origine vegetale. D’altro canto il maggior consumo di alimenti di origine vegetale determina un maggior beneficio per la salute in quanto è associato ad un minor rischio di ipertensione, ictus, diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro. A tale scopo per comprendere meglio il modello della dieta sostenibile, il gruppo di lavoro di Eat-Lancet, ha ideato il piatto sano e sostenibile.
Come indicato in figura circa metà del piatto dovrebbe essere composto da verdura e frutta, seguono le fonti di carboidrati rappresentati dai cereali integrali e da un piccolo spicchio di vegetali amidacei, come le patate.
Per quanto riguarda gli alimenti fonte di proteine, la preferenza dovrebbe essere data soprattutto a quelle di origine vegetale come legumi e frutta a guscio, seguono i formaggi magri, pesce, uova, carni bianche e carne rossa. Tra i grassi preferire quelli che sono fonte di grassi insaturi come olio extravergine d’oliva e altri oli vegetali. Infine, una piccola porzione del piatto è coperta dagli zuccheri aggiunti. Questi ultimi devono essere, infatti, limitati il più possibile, un eccesso può favorire le condizioni di sovrappeso e obesità, che a loro volta sono un fattore di rischio per le patologie più diffuse nei Paesi occidentali.
L’analisi dell’impatto ambientale dei diversi modelli alimentari, da quelli a forte componente vegetale a quelli con elevati contenuti di carne, risulta molto importante sia in termini di emissione di CO2 (impronta del carbonio) che di consumo di risorse idriche (impronta idrica) e di utilizzo del suolo (impronta ecologica). Diversi studi hanno dimostrato come un aumento della quantità di carne nella dieta contribuisca in modo significativo ad un aumento della richiesta di terreno agricolo, dell’emissione di gas serra e del consumo d’acqua.
La dieta mediterranea, esempio di sostenibilità
Riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, la dieta mediterranea è uno stile di vita che enfatizza una serie di valori, i cui vantaggi abbracciano molteplici aree, tra cui l’ambiente. Dal punto di vista alimentare il modello alimentare mediterraneo predilige il consumo di verdura, frutta, cereali (preferibilmente integrali), fonti di proteine vegetali (legumi), frutta secca e l’utilizzo di olio di oliva, mentre prevede un consumo moderato o limitato di uova, pesce, carne, latte e i suoi derivati.
Nel 2016, l’International foundation of Mediterranean diet (Ifmed) con la pubblicazione della Met Diet 4.0, ha proposto la Nuova piramide della dieta mediterranea con l’obiettivo di spostare la percezione dei benefici di questo modello da una particolare attenzione per l’uomo, a un focus sui benefici per il pianeta e le sue popolazioni. Il nuovo modello di dieta mediterranea identifica quattro vantaggi come modello alimentare sostenibile: 1. Miglioramento della salute; 2. Minor impatto ambientale e ricchezza della biodiversità; 3. Alto valore socioculturale; 4. Ritorni positivi sull’economia locale. Questa dieta infatti incentiva il consumo stagionale di prodotti freschi e locali, la biodiversità e la varietà di cibi, stimola le attività culinarie tradizionali, la convivialità e la frugalità e inoltre rispetta la territorialità, il che può giovare alle economie locali.
Appare chiaro dalle considerazioni sino ad ora fatte che tutti possiamo (ma soprattutto dobbiamo) contribuire a fare di più per la nostra salute e per la tutela dell’ambiente, ne vale per il nostro futuro ma soprattutto per quello delle generazioni che verranno. Al consumatore non sono richieste grandi azioni se non rivedere le proprie scelte quotidiane motivandole per i benefici che si potranno ottenere sia nel breve termine come miglioramento del proprio stato di salute, che nel lungo termine a vantaggio di un pianeta più sostenibile.

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE







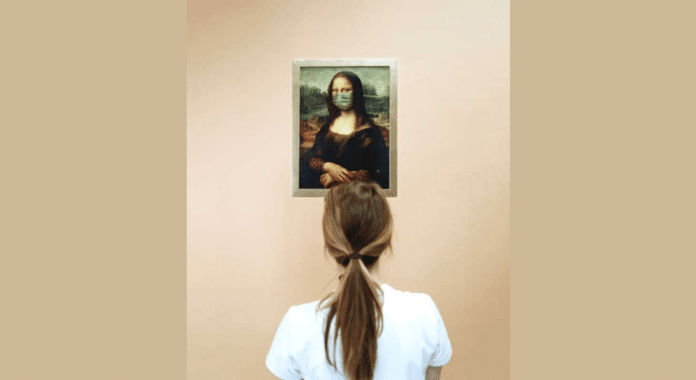




 </a
</a