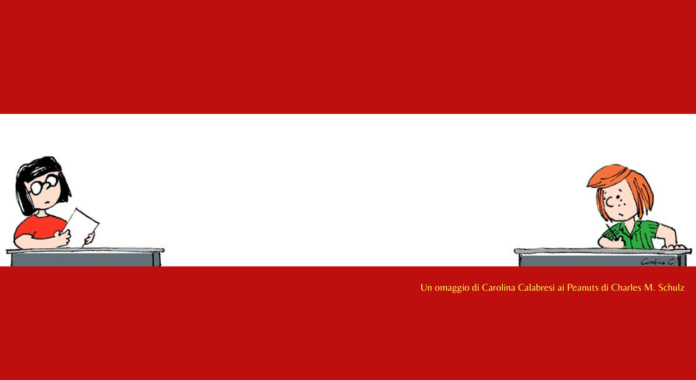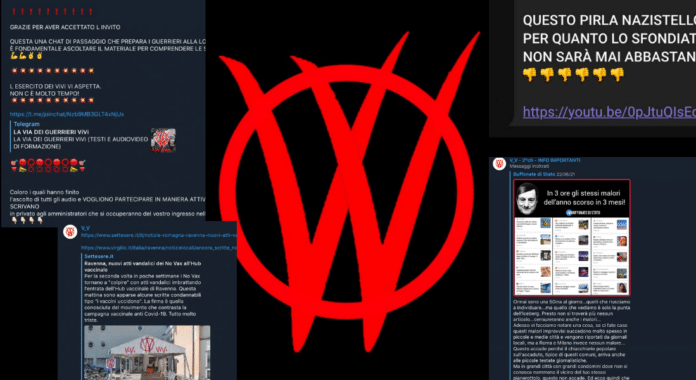Cosa c’è da nascondere? Viene da rifare e da rifarsi la stessa domanda che – in assenza di cambiamenti – ci si faceva purtroppo in pochi circa dieci anni fa. Allora, governo Berlusconi, al Viminale Roberto Maroni, venne diramata una circolare inquietante che sorprese tanto il mondo antirazzista quanto l’Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa. Con questa si faceva espressamente divieto di accesso a quelle strutture di detenzione per “migranti da rimpatriare”, gli allora Cie (Centri di identificazione ed espulsione), oggi Cpr (Centri permanenti per il rimpatrio) per giornalisti ed esponenti di organizzazioni, anche umanitarie, non comprese in un ristretto elenco stilato ovviamente dal ministero dell’Interno. Gli unici ad aver garantito l’accesso, in nome del proprio mandato ispettivo, restavano i parlamentari nazionali ed europei e l’ufficio del Garante per i detenuti. Da tale abuso nacque una campagna nazionale “LasciateCIEntrare”, composta da giornalisti e attivisti del cui operato Left ha dato spesso notizia. La circolare venne “sospesa” dopo la caduta del governo, eppure i suoi effetti nefasti non sono mai cessati.
Dieci anni dopo, infatti, la situazione ahimè non è migliorata e oggi accedere ai Cpr, complici le misure adottate durante la pandemia, è spesso una mission impossible. Proprio per questo motivo, lo scorso luglio, la sezione italiana dell’agenzia Pressenza, ha lanciato l’idea di proporre per il 15 settembre prossimo la richiesta di numerosi giornalisti di poter entrare nei centri e in molti hanno aderito presentando anzitempo regolare domanda di visita, fornendo tutta la documentazione necessaria. Si sono intanto ricostruite piccole reti di attivisti soprattutto a Milano, in Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna ma con connessioni nelle altre città che ospitano tali strutture chiedendo di accedervi.
Nel frattempo, un piccolo ma interessante gruppo di deputati e senatori ha cominciato ad interessarsi a centri e di portare con se propri consulenti esperti in una materia affatto semplice. Fra i primi il senatore Gregorio De Falco. Prima un ingresso con una propria consulente – attivista di LasciateCIEntrare al Cpr di Ponte Galeria a Roma, poi un successivo tentativo andato a vuoto in quanto era stato impedito l’accesso alla consulente. A detta dei responsabili della vigilanza del centro la suddetta non risultava fra i collaboratori del senatore e in quanto tale non poteva entrare. De Falco è poi andato nel Cpr di Milano, restandoci, con due esperte in materia, in un week end ad inizio giugno. Dalle complessive 13 ore di visita è scaturito un dossier dal titolo Delle pene senza delitti, estremamente puntuale di cui si sta curando la distribuzione. Il titolo è in riferimento al famoso testo di Cesare Beccaria, con l’aggravante che, nel caso della detenzione amministrativa, si privano le persone della libertà personale senza che queste abbiano commesso reati. Si tratta di un testo corposo, 90 pagine, pieno di dati, storie e che offre uno spaccato analitico di quelle che sono le criticità del centro. Il testo è stato presentato ufficialmente in Senato, nella Sala Nassirya, giovedì 9 settembre.
Due giorni prima, martedì 7, si è tenuta una conferenza stampa alla Camera organizzata da Rifondazione comunista che ha visto la presenza del senatore De Falco e della collega Paola Nugnes e delle parlamentari del gruppo misto Doriana Sarli e Yana Ehm. L’onorevole Ehm ad inizio agosto, preavvisando con anticipo, era andata in visita nell’altro nuovo Cpr, quello realizzato utilizzando l’ex carcere mandamentale di Macomer (Nu). La situazione che ha visto e descritto, estesa all’intero sistema è netta: «I problemi sono chiari, limpidi, agghiaccianti. Li conosciamo, li sappiamo? Fin troppo bene, sapendo altresì che non abbiamo creato una soluzione. E non lo dico io, ma lo stesso garante nazionale, che in un rapporto dettagliato sui Cpr ne mostra le immense lacune, le inefficienze del sistema, i rischi sui diritti degli “ospiti” detenuti. […] Un sistema insostenibile dal punto di vista umano, sociale, ma anche economico. Le spese di gestione, per queste carceri del Terzo millennio, sono ingenti, ma i risultati sotto i nostri occhi. Il mio giudizio non può che essere complessivamente negativo e, aggiungo, chi sostiene un simile sistema dovrebbe solo vergognarsi». Mentre scriviamo dalla prefettura di Gorizia è giunto il divieto di ingresso ad un giornalista che intendeva entrare nel Cpr di Gradisca D’Isonzo. La motivazione addotta sono le restrizioni dovute alla pandemia. Attendiamo risposte da Torino, Roma, Macomer e Milano e se le istituzioni non intendono porre l’ennesimo divieto ci auguriamo che i parlamentari che si sono dimostrati sensibili al tema facciano risuonare la propria voce.
Ma quella dei diritti violati nei Cpr, come dicevamo, è una questione annosa. Nei dieci anni trascorsi dalla circolare del governo Berlusconi che ne limitava l’accesso a giornalisti ed attivisti, la possibilità di entrare in tali strutture – per loro natura irriformabili – è stata costantemente limitata da decisioni prese da prefetture e dal ministero competente. Per una fase sembrava che i centri dovessero essere destinati a sparire in quanto dimostratisi fallimentari anche per gli stessi scopi che ne avevano determinato la realizzazione: espulsione degli “irregolari” e limitazioni alle libertà di spostamento nell’area Schengen. Alcuni erano stati chiusi in seguito a rivolte o a casi di gestione indifendibili col risultato che già quando nel 2017 hanno cambiato nome (decisione del ministro Minniti), erano arrivati a contenere complessivamente meno di 500 persone. Negli ultimi anni si è rinvigorita la necessità – tutta propagandistica – di riaprire centri chiusi se non crearne nuovi. È tornato ad essere Cpr (dopo essere stato hotspot) il centro di Trapani, hanno riaperto quelli di Milano, Caltanissetta, Palazzo San Gervasio (Pz), ne è stato inaugurato uno “tutto nuovo” a Macomer, nel nuorese e altri sono in progettazione. In tutto questo percorso la politica è stata pressoché assente. Sono morte nei centri persone (Bari, Torino, Gradisca D’Isonzo) eppure poca o scarsa attenzione è stata riversata sul funzionamento di queste strutture detentive. La pandemia ha poi contribuito a far finire nel dimenticatoio la loro esistenza. Entrare nei centri era diventato pressoché impossibile per evitare i contagi, non solo a chi voleva rendersi conto della situazione ma anche a parenti e avvocati dei trattenuti.
🆙 Bastano pochi click!
🔴 Clicca sull’immagine oppure segui questo link > https://left.it/abbonamenti
—> Se vuoi regalare un abbonamento digitale, vai sull’opzione da 117 euro e inserisci, oltre ai tuoi dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <—