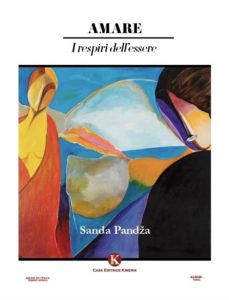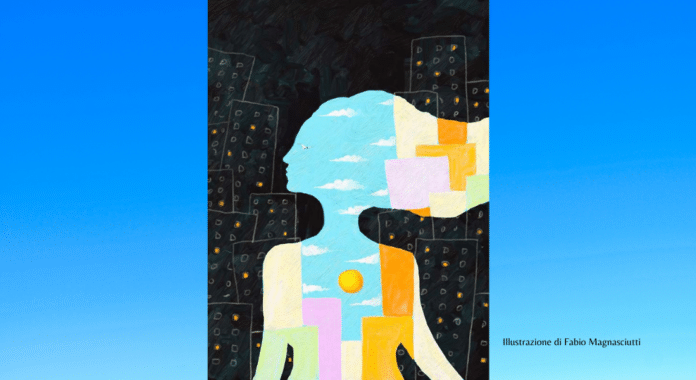Direttore dal 2019 dell’ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (Unar, in precedenza guidato da Luigi Manconi) Triantafillos Loukarelis sta facendo battaglie concrete e quotidiane in collaborazione con associazioni ed enti locali per contrastare le varie e molte forme di discriminazione che ancora segnano l’Italia di oggi. Alla luce di questo lavoro capillare e costante di studio e di monitoraggio dei territori gli abbiamo chiesto di aiutarci a tracciare un quadro della situazione attuale nella Penisola.Loukarelis come è cambiata la mappa in questo anno e mezzo di pandemia? Con il distanziamento fisico immaginiamo sia stato più difficile individuare e raggiungere le persone discriminate, è così?
La dura lezione che ci ha inferto la pandemia purtroppo non è stata recepita come auspicavamo. Si è infranta la speranza iniziale di un comune obiettivo: “siamo tutti sulla stessa barca”, l’inno nazionale dei balconi…
La realtà è che non ne stiamo uscendo migliori. Questo è ciò che emerge dal nostro osservatorio. Riavvolgendo i fili della storia dobbiamo ricordare che fin all’inizio della pandemia c’è stata una forte ostilità verso la comunità orientale, stigmatizzata quasi come se geneticamente fosse predisposta al Covid-19 mentre noi, chissà per quale trovata intelligente, ne saremmo stati esenti. Poi però per la quantità di contagi che ci sono stati in Italia siamo diventati noi gli untori agli occhi del mondo. A dimostrazione del fatto che bisogna sempre stare attenti a discriminare perché oggi tocca a un altro e domani potremmo essere noi i discriminati. Intanto, va sottolineato, sono ancora una volta i migranti ad essere indicati come il capro espiatorio di tutti i mali; vengono additati in questo modo ingiusto da un certo tipo di cultura che purtroppo c’è nel nostro Paese, una “cultura” politica che cerca sempre di dividere le persone.
C’è stata e c’è una forte disparità di possibilità di accesso al vaccino: i senzatetto, le persone che non hanno un domicilio sono state in gran parte escluse. È mancata quella responsabilità pubblica che doveva andare loro incontro?
Le persone più vulnerabili, quelle più esposte e meno in grado di difendersi sono state abbandonate quando invece dovevano essere assistite, non solo perché è giusto, non solo perché è previsto dalla Costituzione, ma anche per salvaguardare la salute pubblica. Di fatto abbiamo emarginato ulteriormente i senzatetto, gli homeless, le persone rom e sinti, i migranti. Invece di farcene carico abbiamo fatto finta di niente. Basti dire che quando è stata avviata la distribuzione di beni alimentari e di buoni pasto con ordinanze della Protezione civile, ma anche con un investimento rilevante di 400 milioni di euro da parte dei Comuni, spesso sono stati stilati regolamenti e ordinanze che escludevano proprio le persone più fragili. Venivano richieste la residenza, il permesso di soggiorno di lungo periodo e una serie di condizioni che alla fine “dimenticavano” proprio quelli che anche secondo la Protezione civile avrebbero dovuto essere i primi beneficiari.
Questo ha portato, peraltro, a numerosi ricorsi al Tar. È di pochi giorni fa la notizia che la Regione Abruzzo è stata condannata per la discriminazione degli stranieri nella vicenda dei buoni spesa.
Diversi tribunali hanno dato ragione a questi ricorsi, ma ci è voluto del tempo, proprio perché sono stati intasati di richieste. In un momento in cui tanto si parla di semplificazione della giustizia abbiamo la dimostrazione di quanto lo Stato e le sue molteplici realtà territoriali vadano in direzioni opposte. Questi regolamenti e ordinanze escludenti molto spesso sono il frutto di incompetenza amministrativa da parte dei Comuni che non hanno personale esperto nell’elaborazione di tali specifici atti. Alcuni amministratori locali hanno fatto propaganda dicendo “prima gli autoctoni”. Come se un sindaco non dovesse occuparsi di tutta la cittadinanza, ma solo di una parte, quella maggioritaria che poi incide elettoralmente. Questa è una considerazione amara da fare. Stiamo parlando di discriminazioni istituzionali che forse sono quelle più gravi in assoluto.
Avete riscontrato discriminazioni anche nel reclutamento del personale sanitario?
Sono state fatte delle selezioni per la ricerca di personale sanitario per sopperire a carenze a livello territoriale. Ma i bandi sono stati rivolti soltanto a cittadini italiani. Questo la dice lunga su quanto siamo arretrati mentalmente. Anche di fronte al bisogno, ci viene come riflesso condizionato l’esclusione dello straniero.
E qui torniamo al tema della campagna vaccini che purtroppo non ha raggiunto tutti.
Qui va fatto un discorso che dovrebbe essere evidente alla gran parte della popolazione: banalmente se non siamo in grado di vaccinare le persone, tutti rischiamo. Le varianti da dove provengono? Da persone che non vengono vaccinate. È una logica che vale sia a livello macro che micro. Bisogna vaccinare tutti, e per farlo si deve mettere in piedi un sistema in grado di non escludere nessuno. Dobbiamo riuscire ad identificare tutte le persone, fornire tutto quello che serve perché siano protette le singole persone ma anche le intere comunità. Per fortuna ultimamente le Regioni stanno provvedendo a correggere almeno in parte i sistemi che in un primo momento prevedevano le prenotazioni solo tramite tessera sanitaria e codice fiscale.
Lei ha toccato un tema molto delicato e centrale quello della discriminazione istituzionale. Quando era ministro Marco Minniti fu negato ai richiedenti asilo un secondo grado di giudizio della loro istanza. Similmente in Europa ora viene proposto di esternalizzare le richieste negli hotspot sbrigandole in poco tempo. Ma sappiamo bene che persone che sono state torturate, che hanno subito un trauma, difficilmente riescono ad aprirsi in pochi minuti.
Questa è l’ennesima ipocrisia se vogliamo dire come stanno davvero le cose. Prima di tutto bisogna stabilire modalità precise e organizzate per fornire le informazioni che sono necessarie alle persone migranti. Lo ripetiamo una volta di più, rappresentano un fenomeno limitato. Non c’è nessuna “sostituzione etnica”. Non esiste alcuna invasione. È un fenomeno sulla carta perfettamente gestibile da una macchina come quella della Unione europea. La commissione Ue che riesce ad essere efficace in tanti ambiti in questo caso non interviene per non scontentare i Paesi del gruppo di Visegrád, come la Polonia o l’Ungheria, la Serbia e altri Paesi dell’ex blocco sovietico. Sono entrati nel circuito dei finanziamenti europei sviluppando un’economia solida, ma quando si tratta di riconoscere diritti, loro non si sentono più europei. Naturalmente la ragione è sempre economica, dunque se si decidesse finalmente di condizionare i finanziamenti europei al rispetto dei diritti umani e della legislazione democratica qualche miglioramento lo avremmo. Altrimenti se non condividono i nostri sentimenti democratici europei potrebbero andarsene, sarebbe più coerente.
A proposito di negazione di diritti nei Paesi del blocco di Visegrád dobbiamo menzionare la recente legge dichiaratamente omofoba imposta da Orbán in Ungheria e provvedimenti misogini imposti dal governo polacco. Come vede la situazione?
Quella legge ungherese è inaccettabile. È una norma che nasce come contrasto alla pedofilia ma proibisce di parlare di omosessualità di fronte a minorenni. È insultante ed è grave che una parte della nostra classe politica non condanni tutto questo, specialmente se questi partiti poi si dicono dialoganti rispetto a una legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia.
Perché secondo lei il ddl Zan non è ancora legge?
Rispetto al ddl Zan vorrei ricordare che alla Camera ci furono moltissime mediazioni. In particolare l’articolo 4 fu inserito proprio per accontentare chi sosteneva che il ddl sarebbe stato in contrasto con la libertà di espressione. Poi al Senato ci sono stati dei cambiamenti. Non spetta al mio ruolo entrare nella valutazione del ddl Zan, ma posso dire che l’omo-lesbo-bi-transfobia esiste e non va minimizzata come purtroppo spesso viene fatto; le persone Lgbt, in assenza di una legge come questa hanno timore a denunciare, spesso non lo fanno. E quando lo fanno il loro caso non viene registrato come caso omo-lesbo-bi-transfobia ma come aggressione generica. Ma non possiamo chiudere gli occhi: su 46 Paesi analizzati nella mappa di The Europe rispetto ai diritti umani delle persone Lgbt l’Italia è allo stesso livello dell’Ungheria. Dunque non si fa nulla per rispettare i diritti delle persone Lgbt. L’Italia ha bisogno di una legge contro l’omo-lesbo-bi-transofobia che però sia efficace. Servono delle definizioni chiare perché poi i giudici devono trovare una definizione giuridica di cosa sia l’identità di genere altrimenti faremmo l’ennesima legge inefficace.
Le destre si oppongono alla giornata contro l’omo-lesbo-bi-transfobia nelle scuole. Cosa ne pensa?
C’è l’autonomia scolastica, lo sanno tutti, anche se molti fanno finta di non saperlo. Nulla può essere imposto ai genitori e alle scuole. È un dibattito a mio avviso strumentale quello che si fa rispetto all’articolo 7: ribadisco, una legge serve, speriamo che l’Italia presto la abbia perché altrimenti saremmo gli ultimi rispetto ai diritti umani delle persone Lgbt. Non è accettabile che nel nostro Paese ci siano persone che non possono esprimere un proprio sentimento rispetto al proprio partner per paura di essere picchiati, insultati, di essere vittime di violenza. Il Parlamento si deve prendere carico di tutto questo. Mi lasci dire anche che io sono molto ottimista considerando le nuove generazioni. Loro al contrario di noi sono molto più aperte alle diversità, hanno un senso di solidarietà e di attenzione e di protezione verso le persone nella loro specifica realtà, qualunque essa sia, e questo fa ben sperare per il futuro.
Alcune femministe storiche sono contrarie al ddl Zan. Mi domando: come donna cosa mi toglie un’altra persona che per motivi suoi, privati, abbia deciso di cambiare genere? Proprio noi donne che abbiamo subito millenni di discriminazioni e annullamento come possiamo discriminare esseri umani che si trovano in una situazione di transizione così difficile e vulnerabile?
Rispetto alle posizioni del femminismo storico a cui lei accenna ricordiamoci che c’è una divisione molto forte nel mondo femminista quindi non riscontriamo una posizione unitaria. Anzi, la posizione prelevante è a favore del ddl Zan. Ricordiamoci che questa legge è volta anche a contrastare la misoginia e ricordiamoci che le persone più colpite dall’hate speech, dalla violenza verbale e fisica, sono proprio le donne.
È un provvedimento che condanna l’abilismo di cui si parla troppo poco. È inaccettabile che si possa offendere una persona perché in carrozzina, perché rallenta il nostro percorso. Eppure accade ogni giorno. Come si cambia tutto questo? Bene una legge, ma ci vuole anche una radicale svolta culturale?
Serve un cambiamento culturale ma anche il superamento di un individualismo che porta a una mancanza di empatia, una mancanza di comprensione della persona disabile e dei familiari che per non essere vittima di aggressioni verbali e fisiche si limitano a non uscire di casa. È una realtà che purtroppo viviamo anche perché ci troviamo in contesti urbani troppo spesso ostili a ogni tipo di disabilità. Il nostro Paese è molto indietro rispetto a tutto questo. Si parla molto di sensibilità nel mondo politico, ma quello che viene fatto in concreto è molto poco.
Veniamo ad altre violazioni dei diritti inaccettabili come quelle che avvengono ogni giorno in carcere. Pensiamo al caso di Santa Maria Capua Vetere di cui molto abbiamo scritto. Non solo per gli inaccettabili pestaggi dei detenuti ma anche per le condizioni materiali di vita: in quel carcere, denunciano i familiari, manca anche l’acqua potabile. A venti anni dalla mattanza alla Diaz e nonostante la legge contro il reato di tortura passata nel 2017, il lavoro è ancora tutto da fare?
Sembra che vent’anni siano passati invano. Denunciamo la violenza e la tortura rispetto a quel che succede in altri Paesi ma in realtà ce l’abbiamo in casa anche noi. Vorrei parlare anche dei Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio, ovvero di gravi limitazioni di libertà personale.
Le persone che sono detenute nei Cpr non hanno compiuto nessun reato come abbiamo denunciato nel nostro libro inchiesta Mai più. Che ne pensa?
Ricordiamo il recente caso del giovane Moussa Balde che si è suicidato nel Cpr di Torino nel quale era stato rinchiuso dopo aver subito un brutale pestaggio. Abbiamo la testimonianza di chi è andato a fare delle ispezioni, in particolare quella del garante Mauro Palma. I Cpr sono delle piccole Libie che abbiamo in Italia. Noi non dobbiamo avere neanche l’ipocrisia di sentirci superiori poiché noi in Italia tolleriamo tali sacche di disumanità e violazioni dei diritti umani. Ci sono circa 600 persone rinchiuse in questi luoghi in Italia dove il rispetto della democrazia e dei diritti umani sembrano un optional. Dobbiamo attrezzarci come Paese e meritarci il titolo di Paese democratico. Non solo dirlo a parole. La storia di Moussa Balde è stata per me uno choc, per tutto il percorso che ha dovuto fare questo ragazzo, per ciò che ha dovuto sopportare: la violenza, le sprangate da tre persone. Non so per quale motivo nei suoi riguardi è stato escluso il motivo di odio razziale dal processo. Abbiamo avuto pochissime informazioni rispetto a tutto questo. Moussa si sentiva una vittima, era stato picchiato a sangue da sconosciuti e dopo questa lesione si era ritrovato rinchiuso nel Cpr di Torino. Non riusciva a capire perché lui, che era la vittima, si trovava lì recluso in quell’inferno che è il Cpr di Torino. La sua psiche non ha retto. Aveva problemi psicologici che erano stati certificati da un medico ma è stato ignorato e questo è stato per lui impossibile da reggere. È inaccettabile quel che gli è accaduto. Non lo dimenticheremo, a lui dedicheremo la prossima settimana contro il razzismo che si terrà nel marzo 2022 proprio per ricordare il suo caso e per parlare di molti altri come lui che rischiano lo stesso trattamento che ha dovuto subire Moussa Balde.

L’articolo prosegue su Left del 6-26 agosto 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO