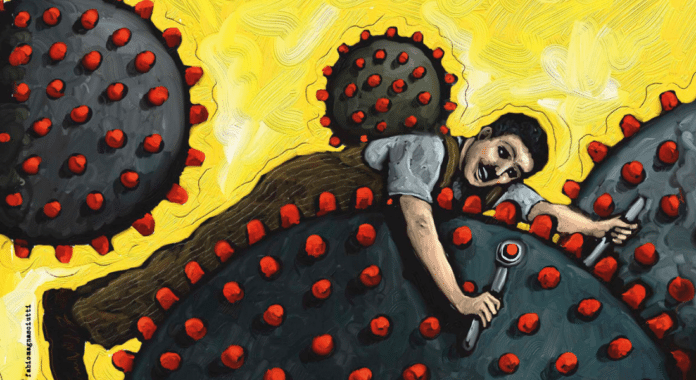Infinite riunioni su Zoom, fino a tarda ora (perché in smartworking non si stimbra mai), che magari sarebbero potute essere qualche mail. Turni estenuanti nelle corsie dei supermercati, o negli altri avamposti produttivi e distributivi, a continuo rischio di contagio. Niente svago quando si stacca, negato dal combinato lockdown-coprifuoco che ha azzerato anzitutto la nostra dimensione culturale e ricreativa. Poche possibilità di spostarsi per una vacanza, per coloro che se lo potevano permettere. Relazioni interpersonali perlopiù congelate.
Per oltre un anno, al di là di qualche tregua concessa dal virus, è stato questo il copione delle esistenze di milioni di persone. Una condizione che ha portato molti individui a porsi interrogativi sulla propria vita lavorativa, specie per chi ha un impiego poco soddisfacente, oppure del tutto inutile, privo di senso. Quei bullshit jobs, fondamento del capitalismo globale contemporaneo, che l’antropologo radicale David Graeber ha saputo identificare e descrivere con schiettezza e ironia.
«Abbiamo avuto tutti un anno per valutare se la vita che stiamo vivendo è quella che vogliamo vivere» ha sintetizzato Christina M. Wallace, docente alla Harvard business school, a Kevin Roose del New York times, in un articolo che ha fatto discutere in tutto il mondo, dedicato alla Yolo economy. L’acronimo sta per you only live once, “si vive una volta sola”. Il neologismo coniato dal Nyt indica l’atteggiamento post pandemico adottato da molti giovani millennial che, incoraggiati da un mercato del lavoro in ripresa e dalla crescita delle vaccinazioni (malgrado le indecenti parate no vax tenutesi in varie parti del mondo) e forti dei risparmi raggranellati durante mesi di sopravvivenza casalinga, mostrano una più elevata propensione a rinunciare al “mito della carriera”, a rifiutare impieghi anche stabili ma poco flessibili oppure poco soddisfacenti, per ricercare un’attività che restituisca maggior senso alla propria vita.
Più in generale, il punto è che, dopo 17 mesi di emergenza sanitaria, milioni lavoratrici e lavoratori di ogni età sono sfiniti. Diverse grandi aziende, in particolare fra quelle più moderne e a più alto valore aggiunto, si sono attivate per alleviare la sofferenza psicologica dei propri dipendenti e prevenire il burnout. Solo per fare alcuni esempi: LinkedIn ha concesso nei mesi scorsi alla maggior parte dei propri lavoratori una settimana retribuita, mentre ai dipendenti di Twitter è stato concesso un giorno libero in più al mese per riposarsi nell’ambito di un programma chiamato #DayofRest.
Ma – per fortuna – la prospettiva di incrementare il tempo libero, riducendo la settimana lavorativa senza toccare il salario, non rappresenta solo una cortesia aziendale: in varie parti del globo si sta concretizzando come diritto per iniziativa dei governi, grazie alle lotte di sindacati e partiti di sinistra.
In Islanda, tra il 2015 e il 2019, l’esecutivo e il Comune di Reykjavik hanno condotto un esperimento per valutare gli effetti di una settimana lavorativa di quattro giorni. I test hanno riguardato una platea di 2.500 lavoratori pubblici (uffici, servizi sociali, scuole materne, ospedali) che rappresentano l’1,3% della forza lavoro del Paese. I lavoratori coinvolti hanno visto le proprie ore lavorative ridursi da 40 a 36 oppure 35 a settimana, mentre la loro retribuzione è rimasta invariata. I risultati della prova? I ricercatori del think tank britannico Autonomy e dell’Associazione islandese per la democrazia sostenibile li hanno raccolti di recente in un rapporto. Nel testo, di oltre 80 pagine, parlano di un «successo travolgente». La produttività e la fornitura di servizi sono ovunque cresciute o rimaste invariate. Mentre è aumentato in modo considerevole il benessere dei lavoratori, come segnalano i vari indicatori: dallo stress percepito, alla salute, al bilanciamento tra vita e lavoro.
I sindacati islandesi, che hanno svolto un ruolo da protagonisti in questa sperimentazione, hanno saputo capitalizzare subito i primi risultati positivi emersi negli anni scorsi. Senza perdere tempo, grazie ad una serie di contratti negoziati tra il 2019 e il 2021, sono riusciti a strappare per l’86% dei lavoratori del Paese (la popolazione islandese conta circa 350mila abitanti, quelli che lavorano sono meno di 200mila) una riduzione dell’orario di lavoro o la facoltà di negoziarla in futuro. Per chiarire meglio la dinamica di questa vittoria, va ricordato che i Paesi del nord Europa vantano la più alta densità sindacale del mondo – sebbene negli ultimi anni sia in calo.
Will Stronge, direttore della ricerca ad Autonomy, ha dichiarato alla Bbc: «Questo studio mostra che il più grande esperimento al mondo di lavoro su una settimana corta nel settore pubblico è stato un grande successo. Mostra che il settore pubblico può essere pioniere per un sistema di lavoro con meno giorni lavorativi in settimana e può essere di esempio per altri governi».
Per riuscire a mantenere il medesimo livello di servizi e ridurre le ore lavorate, le realtà che hanno partecipato ai test islandesi hanno dovuto ripensare la propria organizzazione interna. Tra le innovazioni più frequenti: taglio dei compiti inutili, ottimizzazione dei turni, abbreviamento delle riunioni. Certo, in alcuni casi il nuovo modello lavorativo ha comportato costi in più. In particolare nel settore ospedaliero, il governo islandese ha dovuto assumere più dipendenti per compensare le ore perse.
Quello islandese, comunque, è solo uno dei vari esperimenti di questo genere. In Spagna lo scorso marzo il partito di sinistra Más País ha raggiunto un accordo col governo per un progetto pilota che testerà la riduzione della settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, da 40 ore a 32. La sperimentazione si spalmerà in un periodo di tre anni, coinvolgendo circa 200 imprese di media dimensione. Vi parteciperanno tra i 3mila e i 6mila lavoratori. Lo Stato si farà carico di tutti i costi della transizione nel primo anno, della metà nel secondo e di un terzo nell’ultimo anno di test, utilizzando fondi europei. Requisiti per usufruire degli aiuti: non tagliare il personale e non ridurre gli stipendi. L’obiettivo, di nuovo, è ripristinare una quotidianità più umana per lavoratrici e lavoratori. Perché «la quarta ondata sarà quella della salute mentale», ha dichiarato il leader di Más País Íñigo Errejón, aprendo il dibattito in Parlamento. In Giappone, per citare un altro esempio, proprio nelle scorse settimane il governo ha inserito nelle linee guida del Piano economico annuale un’indicazione per le aziende affinché lascino scegliere ai propri dipendenti se lavorare 4 o 5 giorni alla settimana.
E in Italia? In base a dati elaborati dall’Ocse nel 2019 risulta che il Belpaese sia medaglia di bronzo dell’area Euro nel triste campionato delle ore lavorate per settimana, 33, tre ore in più rispetto alla media di 30 ore. Peggio di noi fanno solo Grecia ed Estonia. In Germania si lavora ben sette ore in meno alla settimana. Sopra alla media europea si posizionano anche Irlanda, Portogallo, Slovacchia, Lettonia, Slovenia e Lituania, e appunto Spagna.
Alla luce di questi dati, sarebbe dunque importante che si avviasse un dibattito sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario anche nel nostro Paese. Ma così non è. L’ultima iniziativa di questo tipo realmente discussa in Parlamento è stata quella di Rifondazione comunista, nel 1997 (l’anno successivo una storica legge di questo tipo veniva introdotta in Francia, con esiti tra luci e ombre). Poi, nel 2019, Sinistra italiana ha presentato assieme al sociologo Domenico De Masi una nuova proposta di legge, per lavorare meno, lavorare tutti, a parità di salario. Il progetto si sarebbe dovuto finanziare, almeno in parte, con una tassa patrimoniale. Infine, nel maggio 2020, a pandemia inoltrata, è stata la task force istituita dal ministero dell’Innovazione a riportare in auge il tema. In una relazione sull’impatto economico della crisi sanitaria si leggeva: «La necessità di garantire il distanziamento assieme alla difficoltà di svolgere il lavoro utilizzando protezioni (guanti, mascherine, etc.) suggeriscono una riduzione sostanziale dell’orario di lavoro… Tale riduzione dovrebbe avvenire a salario invariato con un contributo dello Stato (si noti che costa allo Stato meno della cig a zero ore)». Entrambe le proposte, però, sono state rapidamente accantonate dalla politica (mentre Renzi addirittura blatera di abrogare via referendum il reddito di cittadinanza, affiancandosi alle destre che non l’hanno mai voluto) e anche dai sindacati.
Perché? Simone Fana, autore di Tempo rubato, ha interpretato così la motivazione del disinteresse nei confronti di questa lotta: «Non è stato più un argomento perché sostanzialmente, per trent’anni, l’idea dominante è stata quella della produttività a tutti i costi. Bisognava lavorare di più per produrre di più, e questo ha ispirato tutte le politiche economiche del lavoro degli ultimi anni. La riduzione degli orari veniva vista come qualcosa che avrebbe ridotto la produttività e che avrebbe compromesso sostanzialmente la crescita. Non è stata considerata una politica efficace perché si è martellato costantemente sul fatto che lavorando di più il reddito da distribuire fosse più ampio, e fosse quindi più utile aumentare gli orari di lavoro piuttosto che ridurli».
Ora, però, una nuova consapevolezza di sé dettata dalla pandemia – uno dei pochi, forse l’unico lascito positivo di questa epocale tragedia – potrebbe ridare linfa alla lotta per una esistenza più dignitosa in cui il lavoro non debba assorbire per forza tutte le proprie energie e in cui meno persone si trovino prive di reddito. Sta alla sinistra accorgersene e trasformarla in una rivendicazione concreta.

L’articolo è tratto da Left del 30 luglio – 5 agosto 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO