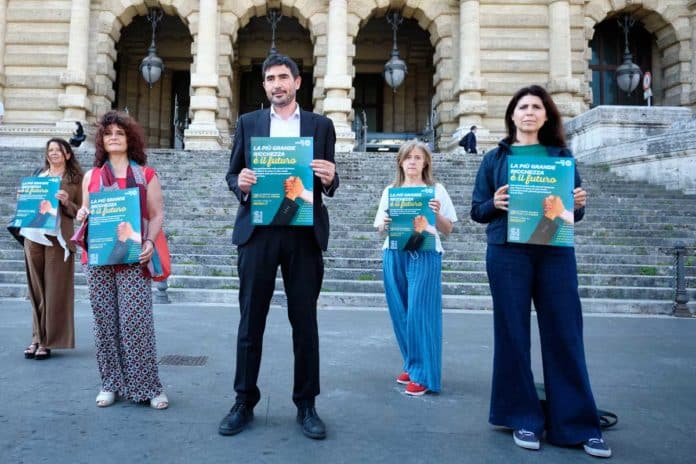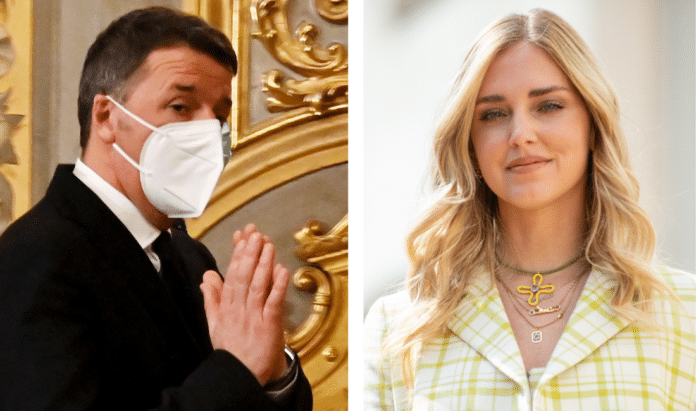A tremila metri di altitudine, in una striscia di terra tra Pakistan e Tagikistan, si estende il corridoio di Wakhan. Un territorio ai margini della vivibilità, solcato solo da animali selvatici e qualche rara carovana dei nomadi del Pamir. Quella stessa terra la attraversò Marco Polo per raggiungere la Cina. Fu raffigurata con colori surreali dal pittore russo Nicholas Roerich, suggestionato dalle visioni evocative delle sue vette remote. Il Wakhan è da secoli una delle porte d’accesso terrestri tra occidente e oriente. L’antica via della seta passava anche di qui, nonostante l’altitudine, le montagne, le basse temperature e le grandi distese disabitate.
Sebbene ancora oggi il corridoio del Wakhan resti un territorio difficilmente accessibile, si sente in lontananza il roboare della Belt and road, che sopraggiunge ad aprire una via d’accesso per gli interessi cinesi in Afghanistan, ora che le truppe Usa e Nato cominciano ad abbandonare il territorio. Perché i progetti economici cinesi possano avere successo, però, al ritiro delle truppe straniere non deve corrispondere un aumento dei tumulti interni.
Per questo la diplomazia cinese si è attivata presso i protagonisti del conflitto interno afghano, ovvero governo e talebani, proponendo dialoghi di pace tra le due parti e convocando un incontro con i ministri degli Esteri di Afghanistan e Pakistan. Dopo venti anni di «guerra eterna», nella quale hanno perso la vita più di 200mila persone, l’impegno militare di Usa e alleati è giunto al termine. Un primo barlume di pace era stato scorto già nel 2014 con la presidenza Obama, cresciuto poi con Trump e ora giunto al suo massimo bagliore con Biden, assolutamente intenzionato a non protrarre oltre questa guerra.
Davanti al ritiro del contingente statunitense, la Cina ha sollevato le sue preoccupazioni e allertato la comunità internazionale che un rientro troppo precipitoso e poco organizzato delle truppe potrebbe lasciare ampio spazio di intervento ai talebani che potrebbero sovvertire il governo di Ashraf Ghani, presidente afghano recentemente confermato per il suo secondo mandato. Il timore di una ricaduta bellica nasce dal mancato raggiungimento, ad oggi, di un dialogo di pace fra le due fazioni in lotta, ma anche dall’eco degli eventi che seguirono la guerra in Afghanistan terminata nel 1989, quando i mujaheddin, nell’arco di tre anni, riuscirono a rovesciare il governo di Najibullah.
Consapevole delle difficoltà politiche della missione, ma altamente interessata all’Afghanistan per il suo posizionamento strategico e le sue risorse minerarie, la Cina ha già avanzato proposte di dialogo per portare il governo di Kabul e talebani su un terreno di confronto. Negli scorsi anni, già a partire dal 2017, Cina, Pakistan e Afghanistan si sono incontrati in diverse occasioni per discutere delle prospettive economiche e industriali dei tre Paesi, sotto l’egida del progetto cinese Belt and road. Pakistan e Cina inoltre cooperano ormai da più di otto anni all’interno del Cpec, “China-Pakistan economic corridor”, un progetto dal valore di 62 miliardi di dollari, incentrato soprattutto sulla realizzazione di infrastrutture dedicate al trasporto e alla produzione energetica. Tuttavia, al momento, la Cina attribuisce grande importanza al porto di Gwadar, nel Pakistan sud-occidentale, molto vicino all’Iran e all’Afganistan, fondamentale per il commercio cinese con l’Asia centrale e l’Africa orientale.
L’incontro trilaterale tra Cina, Pakistan e Afghanistan si è svolto agli inizi del mese di giugno in video conferenza ed è stato condotto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il quale ha sintetizzato in otto punti gli elementi centrali di questo rapporto di cooperazione. Le tematiche principali sono state il processo di pace, di ricostruzione e di stabilizzazione dell’Afghanistan successivamente alla partenza delle forze straniere, lo sviluppo del dialogo e dei rapporti economici, in particolare della Belt and road, e il contrasto al terrorismo del Turkistan islamic party. Nessuna delle potenze impegnate nel pacificare l’Afghanistan si batte per l’Afghanistan in sé, ma per i propri interessi, parafrasando Thomas Rutting, co-fondatore dell’Afghanistan analysts network. Con questo gesto di altruismo, infatti, la Cina nasconde la sua vera agenda.
Lo dimostra, ad esempio, il suo interesse per la lotta contro il Turikistan islamic party, precedentemente noto col nome di Etim, East turkestan islamic movement, una frangia estremista all’interno della quale militano un gran numero di uiguri fuggiti dalla Cina utilizzando passaporti turchi falsi. Siegfried Wolf, direttore di ricerca presso il South Asia democratic forum, racconta al Deutsche welle in un’intervista che gli uiguri in fuga dalla Cina vengono accolti tra i movimenti terroristici islamici presenti in Afghanistan e mandati a combattere contro le truppe Nato, addirittura alcuni di essi avrebbero partecipato ad attacchi terroristici in Siria e Kyrgyzstan.
Tra i gruppi con cui gli uiguri avrebbero militato sono inclusi anche Al-Qaeda e i talebani, protagonisti della guerra in Afghanistan. Sul fronte islamico tuttavia la Cina non ha una politica univoca, poiché tende a mutare il suo approccio a seconda del contesto. Basti pensare alla discrepanza del rapporto che essa intrattiene con gli uiguri e con i talebani: mentre i primi sono oggetto di una politica di segregazione e rieducazione, i secondi invece sono legati alla Cina in una relazione di cooperazione già dal 2001, quando la Cina firmò un rapporto di collaborazione economica con il gruppo, che ora si sta rafforzando in occasione del Belt and road, attraverso dei progetti stradali che connetterebbero le città sotto il dominio talebano, in cambio di collaborazione nel processo di pace.
Lo stesso Pakistan ha lavorato molto nell’intessere un dialogo tra Cina e talebani, i quali sono largamente presenti sul suolo pakistano. Rendere l’Afghanistan una zona sicura e prevenire qualunque forma di terrorismo è per Pechino un tema pressante, considerato poi che il Paese dell’Asia centrale confina con lo Xinjiang per un tratto di 75 km nella zona del corridoio di Wakhan. Molti sono gli accordi che la Cina ha stipulato con i Paesi del Centro oriente, Afghanistan incluso, tuttavia i conflitti che soffocano la regione da decenni ne rendono impossibile l’attuazione. Ad esempio, la miniera di rame di Mes Aynak, quaranta chilometri a sudest di Kabul, presa in concessione dalla Cina nel 2007 per un totale di 3,4 miliardi di dollari, è ad oggi ancora in attesa di poter essere sfruttata a causa delle tensioni tra terroristi e governo afghano.
Se la Cina riuscisse a far riconciliare i due attori, governo nazionale e talebani, avrebbe tutto il modo di poter avviare i progetti di connessione della Belt and road tra Pakistan, Afghanistan e Iran, nonché poter tenere sotto controllo il formarsi e l’insorgere di movimenti estremisti islamici legati all’etnia uigura. L’attenzione della Cina si focalizza quindi proprio su quella porzione di terra così ostile da non ospitare alcun presidio umano, il corridoio del Wakhan. Pechino attende dal 2009 che i lavori accordati nel Memorandum of understanding firmato da Cina e Afghanistan abbiano inizio e che l’asfalto apra la strada tra le montagne del passo di Wakhjir. A quel punto la Cina non sarà soltanto in grado di collegarsi anche agli altri enormi lavori stradali come la superstrada che connette Kashgar, Xinjiang, e Islamabad, e alle infrastrutture realizzate grazie alle relazioni afghano-iraniane come la ferrovia Khaf-Herat, ma anche di poter pattugliare liberamente le zone di confine dello Xinjiang, senza correre il rischio di incorrere in inchieste scomode, come quella pubblicata dalla stampa indiana che presentava in esclusiva immagini ritraenti convogli cinesi all’interno del confine afghano.
Il governo cinese si propone quindi come mediatore diplomatico tra Kabul e i talebani. Dal suo operato dipendono le sorti di decenni di diplomazia fra Pechino e i Paesi del centro Asia, di miliardi di dollari già investiti nei progetti economici specifici e, conseguentemente, del progetto Belt and road. Tutte le potenze coinvolte sono ben disposte a seguire la leadership cinese, certe che ne trarranno un grande guadagno politico ed economico. L’unico fattore a non essere ancora sotto il controllo cinese è la moltitudine di gruppi estremisti che popolano l’area, tutti diversi fra loro, sia per natura che per obiettivi.
La Cina ha ampiamente dimostrato di essere disposta a scendere anche al dialogo con questi gruppi pur di raggiungere il proprio obiettivo, tuttavia il Partito resta all’oscuro delle modalità con cui le forze Nato abbandoneranno il suolo afghano e ciò che ne conseguirà, quindi non può fare altro che tenersi pronto a tutto.
*
💥 Porta Left sempre con te!
Regalati un abbonamento digitale e potremo regalarti altre articoli come questo
🆙 Bastano pochi click!
🆒 Qui > https://left.it/abbonamenti
—> Per regalare un abbonamento digitale cliccare sull’opzione da 117 euro e inserire, oltre ai propri dati, nome, cognome e indirizzo mail del destinatario <— ⏱
🔴 Left, un pensiero nuovo a sinistra

L’articolo è stato pubblicato su Left del 9-15 luglio 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO







 Chiediamo ad Aleida Guavara di parlarci della politica sanitaria cubana. Lo spunto viene dall’incontro che si è svolto a Cosenza, dal titolo “Sanità a confronto, alla luce della pandemia”, con medici e studiosi che hanno parlato del sistema medico e psichiatrico cubano in rapporto a quello italiano che durante l’emergenza ha messo a nudo tutte le carenze dovute alle privatizzazioni e ai tagli di risorse, specie alla medicina territoriale. «La salute pubblica cubana si basa su principi molto importanti. In primo luogo è completamente gratuita, è un diritto della popolazione cubana. Tu non puoi fare soldi con il dolore e con la sofferenza di un essere umano», sottolinea con forza. Un altro principio importante è che «la medicina cubana è integrale, pertanto una persona è sana non solo dal punto di vista fisico, ma anche per quanto riguarda la salute mentale. E per noi una persona è sana quando è felice».
Chiediamo ad Aleida Guavara di parlarci della politica sanitaria cubana. Lo spunto viene dall’incontro che si è svolto a Cosenza, dal titolo “Sanità a confronto, alla luce della pandemia”, con medici e studiosi che hanno parlato del sistema medico e psichiatrico cubano in rapporto a quello italiano che durante l’emergenza ha messo a nudo tutte le carenze dovute alle privatizzazioni e ai tagli di risorse, specie alla medicina territoriale. «La salute pubblica cubana si basa su principi molto importanti. In primo luogo è completamente gratuita, è un diritto della popolazione cubana. Tu non puoi fare soldi con il dolore e con la sofferenza di un essere umano», sottolinea con forza. Un altro principio importante è che «la medicina cubana è integrale, pertanto una persona è sana non solo dal punto di vista fisico, ma anche per quanto riguarda la salute mentale. E per noi una persona è sana quando è felice».