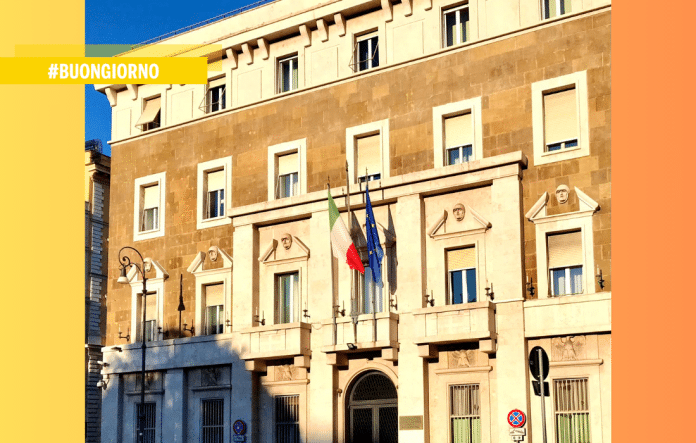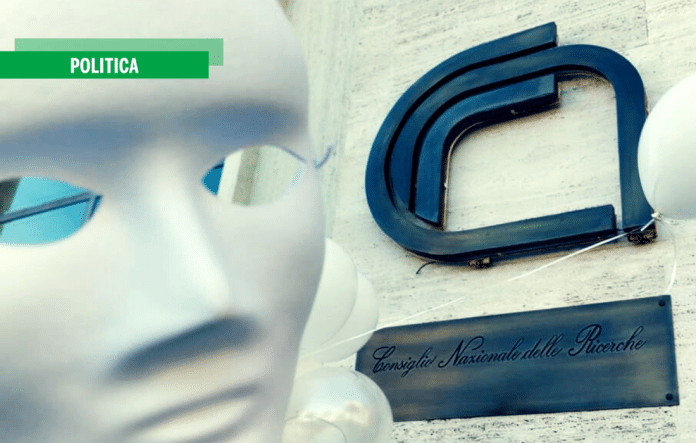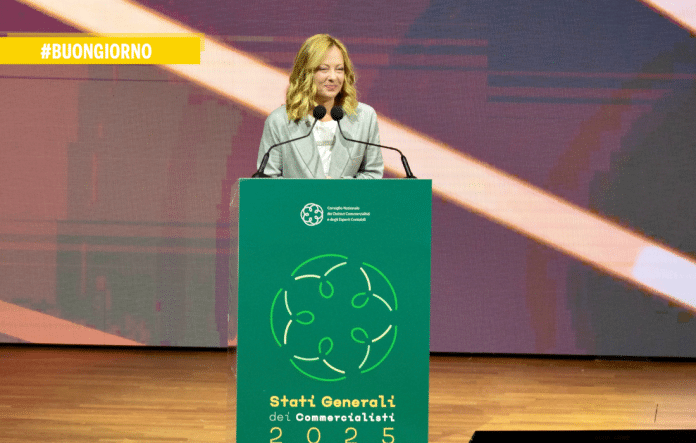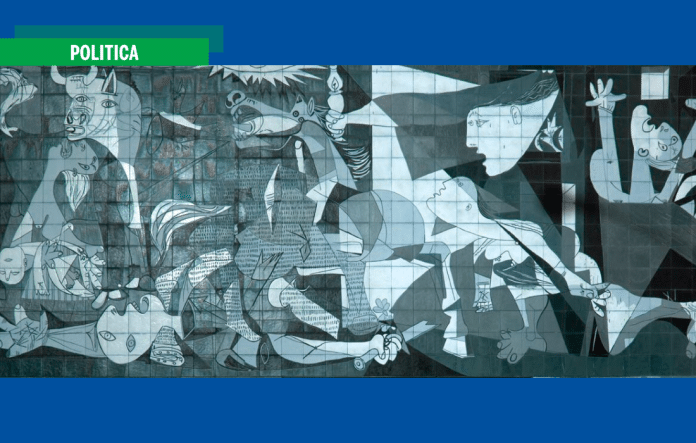Ci sono tre questioni che il risultato referendario ha riportato in primo piano. La prima la possiamo chiamare questione democratica. Maurizio Landini ha parlato di «crisi democratica», con ragione. Un voto cui partecipano solo 15 milioni di elettori, il 30,6%, mostra la lontananza sempre più drammatica tra la società politica e quella civile.
Un referendum, pur voluto dal sindacato sui temi del lavoro, che non riesce a mobilitare quell’elettorato a cui si rivolge evidenzia che c’è una parte del corpo sociale che è decisamente lontana, separata, che non partecipa e si chiama fuori. Non è forse corretto dire che sia “disinteressata”, ma forse che è totalmente sfiduciata nella possibilità di cambiare qualcosa votando.
La seconda la possiamo chiamare questione sociale, o di classe. In Italia vi sono quasi 24 milioni di occupati, 18,9 milioni dei quali sono lavoratori dipendenti (di cui 16,68 italiani e 2,77 stranieri). Ora, la condizione professionale, lavorativa e contrattuale di questi varia molto, a seconda dei settori, dell’età e dei livelli di qualificazione. E la normativa sui contratti e il mercato del lavoro, negli ultimi trent’anni, ha moltiplicato le posizioni lavorative, rendendo le condizioni dei meno “garantiti” più precarie. I lavoratori assunti a tempo determinato, ad esempio, sono 2,77 milioni (con 450mila stranieri). Di questi, 815mila sono a tempo parziale, mentre i part-time tra gli assunti a tempo indeterminato sono 2,55 milioni. Il tempo parziale è una condizione che colpisce soprattutto le donne. I contratti a tempo determinato e a tempo parziale, com’è ovvio, sono le due forme che più influiscono sulla precarietà dell’occupazione e sui bassi livelli di salario. E sono quei 5,3 milioni di titolari di quei contratti ai quali i quesiti oggetto dei referendum erano rivolti, in primis.
Se poi consideriamo la collocazione professionale secondo i livelli di qualificazione, partendo dal basso, abbiamo che 3,7 milioni di salariati hanno un lavoro non qualificato o semi-qualificato, 3,3 milioni sono dipendenti del commercio o dei servizi e quasi 3 milioni sono impiegati esecutivi, cui si aggiungono altri 3 milioni di impiegati tecnici o amministrativi a media qualificazione. Le categorie del lavoro salariato, in ogni caso, assommano al 40% dell’occupazione totale, cui si aggiunge un 25% di impiegati a bassa o media qualificazione e un 8,5% di lavoratori autonomi a bassa o media qualificazione. Quote enormi, che descrivono una composizione sociale molto polarizzata, in cui le professioni con redditi alti raccolgono non più di un quarto dell’occupazione. Se a ciò aggiungiamo che i livelli retributivi per le occupazioni a bassa o media qualificazione sono rimasti stagnanti negli ultimi due decenni, mentre i redditi alti hanno continuato a crescere, possiamo concludere che in Italia esiste una questione sociale, di classe, che origina da una condizione del lavoro particolarmente divaricata.
La terza è la questione politica, che interroga la natura e le prospettive della sinistra. Le classi popolari, in Italia, rappresentano ancora una fetta ben consistente del corpo sociale, in cui i ceti bassi e medio bassi del lavoro salariato e impiegatizio assommano a due terzi del totale. In una situazione in cui la mobilità sociale si è ridotta, l’economia langue e sono i settori a più basso valore aggiunto e a bassa produttività che vedono aumentare l’occupazione – in condizioni di sempre maggiore precarietà – le classi popolari, tuttavia, hanno trovato sempre meno rappresentanza anche tra le forze di sinistra, che hanno teso a privilegiare il ceto medio. E non sorprende che tanto il sostegno a quelle forze che la partecipazione elettorale stessa da parte dei ceti bassi e medio-bassi siano andati diminuendo vistosamente negli ultimi anni.
Al lavoro, negli ultimi trent’anni, sono stati tolti diritti, anche con il concorso della sinistra liberal che, accettando il credo neoliberista, diceva che era l’impresa che andava messa al centro, perché «crea ricchezza». La sinistra liberal ha promosso politiche che, di fatto, hanno portato ad un impoverimento del lavoro, nelle sue fasce meno qualificate, favorendo l’aumento della precarietà, spesso in nome della flessibilità. Nel contempo, il capitale è stato favorito e i redditi alti hanno preso a crescere, anche a svantaggio del ceto medio. Le disuguaglianze sono aumentate, così come la povertà.
Promuovere i referendum sui Jobs act e altri provvedimenti, per ridare al lavoro diritti e tutele, è stata quindi una decisione che ha risposto all’esigenza di «rimettere il lavoro al centro», una decisione che la Cgil ha preso coraggiosamente e che pone comunque una questione politica rilevante, quella di ridare voce alle fasce più deboli e meno rappresentate. Una questione che interroga in primo luogo il Pd, e la sua adesione al neoliberismo mercatista, e tutto il fronte progressista.
Ora, se guardiamo al voto si possono cogliere elementi di speranza, che indicano soluzioni per le tre questioni sopra esposte, a partire dalla questione democratica.
L’astensione di quasi il 70% dell’elettorato confermerebbe che vi sono larghe fasce di popolazione che si sentono escluse, non rappresentate e non ne vogliono sapere, non ci credono più. E, tuttavia, dalla conta dei voti emerge anche un’altra tendenza. Alle elezioni politiche del 2022, su 46,1 milioni di elettori i voti valido furono 28,2 milioni, il 61%. Alle elezioni europee di un anno fa su 51,2 milioni di elettori, i voti validi furono poco più di 23,4 milioni, il 45,7%. A questa tornata di referendum su 51,3 milioni di aventi diritto, in 14,1 milioni si sono espressi (in Italia), il 30,6%, mentre nelle circoscrizioni estere sono stati 1,1 milioni, il 21,3%. I Sì al primo referendum (quello con la percentuale più alta) sono stati 13.031.443. Ora, i tre partiti del “campo largo” – Pd, AVS e M5S – più UP o PTD totalizzarono 11,6 milioni di voti nel 2022 e 10,1 milioni nel 2024. Il che significa che i Sì sono stati 2,94 milioni in più dei voti di quei partiti nel 2024 e quasi un milione e mezzo in più del 2022.
Ora, possibilmente, non tutti gli elettori Pd hanno votato Sì – come da dichiarazioni di vari leader – e hanno votato No con Renzi e Calenda. È però vero che questi avevano 2,19 milioni di voti, nel 2022, mentre i No sono stati 1,85 milioni, il che fa ritenere che buona parte di quell’elettorato “centrista” si sia astenuto. Assumendo che tutti gli elettori del centro-destra non abbiano votato, assieme a gran parte di quelli del centro, possiamo concludere che parte dei No fossero originariamente elettori del centro-sinistra. E che, quindi, la partecipazione non sia stata davvero così inferiore. Se poi ipotizziamo che molti elettori del Movimento 5 Stelle non hanno votato (soprattutto al Sud), ciò implica che un certo bacino di elettori “delusi” è stato mobilitato, che può essere quantificato in (almeno) 3 milioni e forse più. Insomma, tre milioni di elettori sono stati catturati, fuori dal perimetro del campo “larghissimo” PD+AVS+M5S più Rifondazione comunista. C’è quindi una crisi democratica, non c’è dubbio, ma il «popolo della sinistra», forse, ha cominciato a rispondere all’appello.
La questione sociale e la questione politica. Chi è andato a votare? Senz’altro chi vota sempre – quella parte che è “inclusa” e “garantita” – e che vota per il centro-sinistra. Non a caso l’affluenza è maggiore nei centri delle grandi città, nelle zone ex rosse, e dove maggiori sono le quote di laureati, ovvero le zone abitate dai ceti medi, più colti, progressisti. Molto meno le zone operaie e del lavoro salariato, le periferie, le cinture urbane, le aree interne. Alta affluenza nei capoluoghi, bassa in provincia, più alta al Nord, bassissima in quasi tutto il Sud.
Si è detto che una parte del corpo sociale – sempre maggiore – non si sente più rappresentata e si sente esclusa. Il lavoro, che doveva essere un tema “coinvolgente”, non ha mobilitato le masse, soprattutto quelle avrebbero dovuto essere più coinvolte. Perché il ceto politico – nella sua accezione più ampia, includendo il sindacato – ha perso credibilità agli occhi delle fasce del lavoro più deboli ed esposte. Il referendum è stata un’occasione per invertire la rotta e – con due soli mesi di una campagna elettorale fatta in sordina, con il boicottaggio dei media – il risultato non è stato disprezzabile. Certo, dai partiti sono arrivati messaggi poco convinti, come il «non può essere un’abiura», in luogo di un «abbiamo sbagliato, abbiamo cambiato idea perché quelle politiche hanno provocato danni». Ma è un punto di partenza, che sarà tanto più credibile nel dare rappresentanza ai lavoratori se si vorrà davvero cambiare registro e gettare alle ortiche le prescrizioni neoliberiste.
Ora, se è vero che quei 13 milioni di Sì sono stati più dei 12,3 milioni presi dalla coalizione di centro-destra nel 2022, è però anche vero che non sono tutti necessariamente voti che andrebbero al “campo larghissimo” alle prossime elezioni. Certo, ad essere mobilitato è stato soprattutto il vasto elettorato attivo del centro-sinistra allargato ma il “recinto”, forse, è stato abbattuto, coinvolgendo elettori al di fuori di quello: si può per questo ritenere che si è aperta una breccia nel loro astensionismo? Il voto resta una prerogativa di quell’elettorato che dal punto di vista del lavoro, dei contratti e dei diritti è il più “garantito”. Il vasto mondo dei non garantiti, dei lavoratori precari delle periferie e delle aree interne, degli esclusi e degli abbandonati non si è recato alle urne, ma non in toto. Tuttavia, lavoratori, giovani ed elettori più sensibilizzati, altrimenti non aderenti al centro-sinistra, si sono espressi, il che può essere un tenue elemento di speranza. Per un insieme di forze progressiste che voglia rimettere il lavoro al centro e far ripartire l’Italia c’è dunque motivo di guardare al futuro con fiducia, se la sinistra «tornerà a fare la sinistra».
L’autore: Pier Giorgio Ardeni è professore ordinario all’Università di Bologna. Insegna Economia dello sviluppo ed Economia dello sviluppo internazionale. Il suo nuovo libro s’intitola Le classi sociali in italia oggi (Laterza)
foto Adobe stock