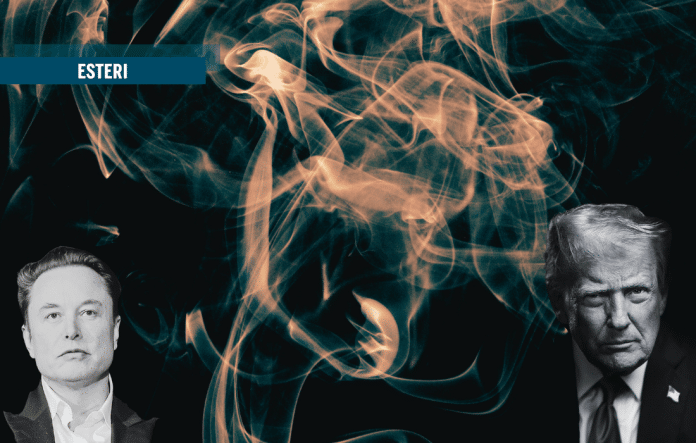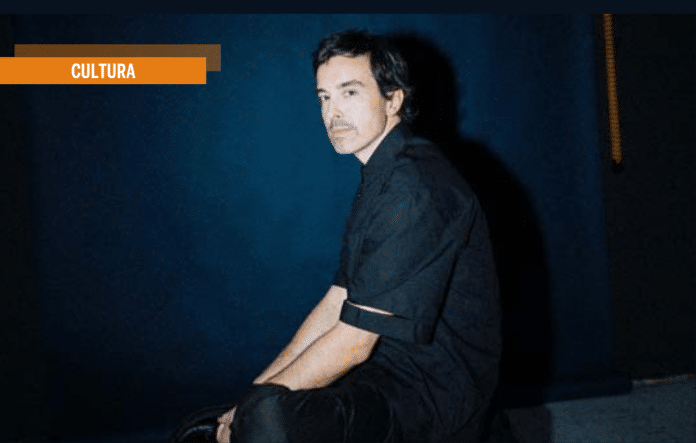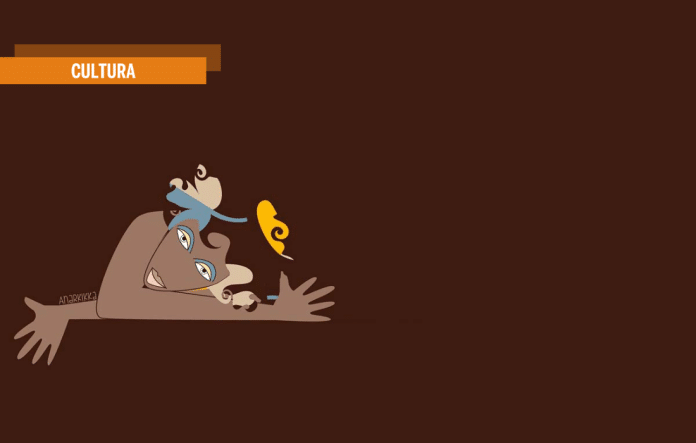10 gennaio 2025, nelle prime ore del pomeriggio, una fuga di ammoniaca alla FrigoCaserta di Gricignano d’Aversa (CE) uccide Patrizio Spasiano.
Patrizio ha soli 19 anni ed è il primo morto del nuovo anno in Campania. Patrizio, in realtà, è solo un tirocinante. Pagato 500€ al mese per quello che dovrebbe essere un percorso di “orientamento e formazione”. Il tirocinio è stato stipulato dalla Cofrin di Villaricca (NA), una piccola azienda attiva nel campo della refrigerazione industriale.
Se quel 10 gennaio Patrizio è al lavoro alla FrigoCaserta è perché la FrigoCaserta ha affidato alcuni lavori in appalto alla Cofrin.
A cinque mesi da questo omidicio sul lavoro, il processo non è ancora iniziato. I giudici dovranno verificare le responsabilità delle due ditte coinvolte, la committente FrigoCaserta e la società in appalto, la Cofrin.
Se i giudici dovessero riscontrare che la morte di Patrizio è esclusivamente “conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici” (cioè della Cofrin), la FrigoCaserta potrà lavarsene le mani (diverso se i giudici accerteranno responsabilità della stessa FrigoCaserta).
Funziona così perché è la legge a prevedere questo meccanismo. Ed è proprio questa la norma che il quarto quesito del referendum dell’8 e 9 giugno vuole cambiare. Se vincessero i “sì”, infatti, il committente – in questo caso la FrigoCaserta – sarebbe d’ora in poi “responsabile in solido”, così che il lavoratore o i suoi cari potranno chiedere il risarcimento sia al datore di lavoro diretto che al committente.
Nel mirino, quindi, c’è il sistema di appalti e subappalti che costituisce la giungla in cui si producono numerosissimi incidenti e morti sul lavoro.
La stessa in cui si è prodotta la strage di Brandizzo quando, tra il 30 e il 31 agosto 2023, cinque operai della Sigifer, impresa che aveva l’appalto dalla committente Rfi, furono investiti e uccisi da un convoglio fuori servizio.
La stessa in cui si è prodotta la strage del cantiere Esselunga a Firenze, quando, il 16 febbraio 2024, cinque operai furono travolti da un crollo e morirono. Su quell’unico cantiere c’era una giungla di decine di aziende in appalto, che rende intricata la strada dell’individuazione delle responsabilità.
È il segreto di Pulcinella che le lunghe catene di appalti e subappalti servono alle imprese più in alto a risparmiare quanto più possibile. Più scendiamo nella catena degli appalti, più emerge un inferno di bassi salari, precarietà e assenza di misure di sicurezza. Perché ogni impresa cerca di massimizzare quanto più possibile i profitti e lo fa spesso in ogni modo possibile, compreso il risparmio su salute e sicurezza.
Quello che per loro è un costo da abbattere per chi sta dall’altra parte, lavoratori e lavoratrici, è invece letteralmente la possibilità di non farsi male, di non morire.
Votare “sì” al quarto quesito referendario è quindi un’arma nelle mani di lavoratori e lavoratrici per difendere sé stessi, i propri colleghi, i propri cari.
Perché se un’azienda committenta saprà di poter essere considerata responsabile in solido per gli incidenti prodotti dalla negligenza o dalle azioni sconsiderate di un’azienda in appalto, avrà maggior interesse a verificare che lungo la catena degli appalti siano rispettate le misure di sicurezza. Non per amore dei lavoratori e delle lavoratrici, ma per amore del proprio portafogli, l’unica cosa che pare interessare loro.
Non si tratterebbe dunque di una vittoria per “punire”, ma per “prevenire”. Costruire la giusta deterrenza contro gli imprenditori delinquenti che per il profitto mettono a repentaglio le nostre vite è interesse della maggioranza della nostra gente.
Votare “sì” al referendum non significa fare qualcosa di concreto per noi stesse e stessi. Senza delegare a nessuno. Un esercizio di democrazia diretta, che sarebbe anche uno schiaffo in faccia a un’intera classe dirigente – compresa quella che oggi promuove i referendum ma che negli ultimi 30 anni ha contribuito a portarci nel baratro in cui ci troviamo – e un importante segnale di presa
di coscienza e di voglia di trasformazioni profonde in quel mondo del lavoro devastato da decenni di liberismo di destra e di sinistra.
Votare “sì” significa impiegare qualche minuto del proprio tempo, domenica 8 o lunedì 9 giugno, per chi è uscito di casa per andare a guadagnarsi il pane col lavoro e non è più rientrato.
E per contrastare concretamente questa strage che ogni anno produce almeno 500mila infortuni e nel solo 2024, stando ai dati pubblicati dall’Osservatorio Nazionale di Bologna Morti sul Lavoro, ha causato ben 1.482 morti.
Che si vinca o che si perda, però, la guerra sarà ancora tutta da combattere. E questa contro gli “operaicidi”, come li ha definiti l’ex Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è l’unica guerra da combattere. Per vincerla non basta un referendum né un post sui social, serve l’organizzazione politica e sindacale di lavoratori e lavoratrici.
Perché solo conquistando più potere potremo difendere le nostre vite e quelle dei nostri cari.