Una delle prime mosse stravaganti di Donald Trump, nella fase iniziale della pandemia, conquistò le prime pagine della stampa internazionale quando il presidente degli Stati Uniti tentò di acquistare in anticipo, sborsando un miliardo di dollari, il brevetto del vaccino di una promettente biotech tedesca per conto della amministrazione nordamericana. Era il mese di marzo. Il governo tedesco intercettò prontamente la manovra, che fallì clamorosamente: «La vendita esclusiva di un possibile vaccino agli Stati Uniti deve essere bloccata in tutti i modi. Il capitalismo ha dei limiti», aveva chiosato in un tweet il politico tedesco Karl Lauterback. Ma CureVac, l’azienda coinvolta nel pasticcio di Trump, una biotech specializzata nella tecnologia Rna alla base di molti programmi di ricerca sul vaccino contro Covid-19, da allora ha fatto il botto. Lanciatasi sul mercato finanziario a metà agosto, i suoi titoli sono svettati del 249,4% in 24 ore, del 400% in due giorni di borsa. E sapete chi è uno dei principali investitori di CureVac? La onnipresente Fondazione Bill e Melinda Gates, naturalmente. In estate, Bill Gates ha irrobustito la partecipazione finanziaria nella ormai prestigiosa azienda tedesca con altri 40 milioni di dollari.
CureVac non è la sola gallina dalle uova d’oro di Bill e Melinda. Stando alle più recenti informazioni della Securities and exchange commission (Sec) americana, la Fondazione Gates ha un portafoglio di investimenti di oltre 250 milioni di dollari in una dozzina di aziende impegnate nella ricerca contro Covid-19 – vaccini, medicinali, diagnostici o altre produzioni medicali. La Fondazione ha inoltre annunciato di voler utilizzare una parte cospicua del suo Fondo di investimento strategico (Strategic investment fund) di 2,5 miliardi di dollari per far avanzare il programma di impegno contro Sars-Cov-2.
Soldi, soldi, soldi. Come spiega accuratamente l’Institute for policy studies, il 2020 è un anno del Ringraziamento per i miliardari americani. Da marzo a oggi, mentre nel mondo divampa una pandemia sociale ed economica senza precedenti, costoro sono riusciti a incamerare profitti dell’ordine di un miliardo di miliardi. Un incremento della ricchezza da capogiro (+34%), per questi “approfittatori della pandemia” che nessuno sembra in grado di controllare. I Gates cominciarono a espandere i loro tradizionali investimenti nel settore farmaceutico dopo che la comunità scientifica, convocata a Seattle nel 2015 per una discussione sugli scenari futuri, lanciò l’allarme su un nuovo patogeno respiratorio destinato a sconvolgere il pianeta. Non era un’eventualità di scuola, ma una questione di tempo, confermarono gli scienziati convinti dell’imminente spillover. Le proiezioni che aveva commissionato restituivano a Gates lo scenario di un contagio che avrebbe colpito i centri urbani in tutto il pianeta; nel giro di mesi, milioni di persone avrebbero perso la vita. Così Bill Gates, gli va dato atto, fece di tutto per lanciare l’allarme. Raccontò la macabra profezia in una Ted Talk divenuta ormai famosa, rilasciò interviste e scrisse articoli sulla stampa scientifica, formulò…

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE



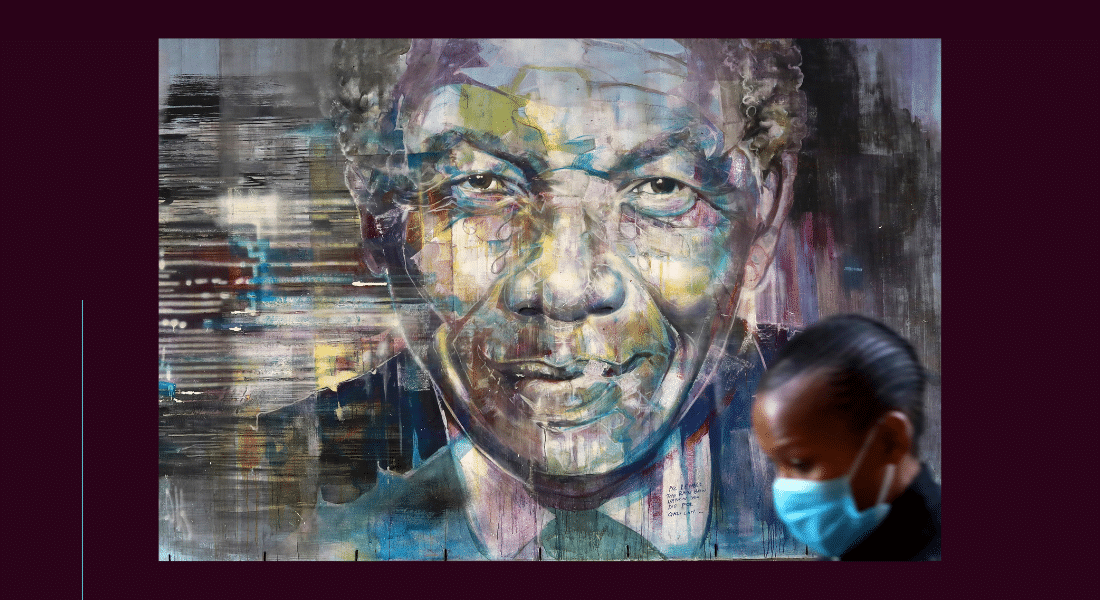







 Öcalan a Roma ci spiegava, con calma e determinazione, che i volti, gli sguardi, le vite delle curde e dei curdi reclamavano visibilità ed il riconoscimento storico di un processo di rivoluzione e di liberazione. Disegnando una cooperazione internazionale che non fosse schiava di sistemi mercantili, di geopolitica, di egemonismi militari. Ma l’Unione europea ed il governo italiano non vollero comprendere la grandezza e la generosità storica del messaggio di Öcalan. Fu tradito. Fu consegnato dall’Europa vigliacca nelle mani dei suoi carcerieri. Prevalse la logica degli affari. La Confindustria italiana fece pressione sul pavido governo italiano affinché si liberasse della presenza di Öcalan; temeva per i suoi affari con la Turchia. Prevalsero gli equilibri militari della Nato. Prevalse l’egemonismo del governo israeliano come struttura di comando dell’intera area mediorientale e mediterranea. Ora vogliamo, rilanciando la campagna per la libertà di Öcalan, riaprire il tema anche sul piano giuridico e giurisdizionale. Il primo ottobre del 1999, infatti, la seconda sessione civile del Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di Öcalan all’asilo politico ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana. Il governo italiano, con atto grave, si oppose alla richiesta di Öcalan. Nel procedimento, non a caso, era intervenuta anche la Turchia che, come il governo italiano, contestava la fondatezza della domanda di asilo. Il provvedimento giudiziale del 1999 puntualmente descriveva la negazione, per i Curdi, dei diritti fondamentali e delle libertà, che caratterizzava lo stato di assoluta discriminazione di un intero popolo, rappresentato, per l’appunto, da Öcalan. L’articolo 10 della Costituzione stabilisce che…
Öcalan a Roma ci spiegava, con calma e determinazione, che i volti, gli sguardi, le vite delle curde e dei curdi reclamavano visibilità ed il riconoscimento storico di un processo di rivoluzione e di liberazione. Disegnando una cooperazione internazionale che non fosse schiava di sistemi mercantili, di geopolitica, di egemonismi militari. Ma l’Unione europea ed il governo italiano non vollero comprendere la grandezza e la generosità storica del messaggio di Öcalan. Fu tradito. Fu consegnato dall’Europa vigliacca nelle mani dei suoi carcerieri. Prevalse la logica degli affari. La Confindustria italiana fece pressione sul pavido governo italiano affinché si liberasse della presenza di Öcalan; temeva per i suoi affari con la Turchia. Prevalsero gli equilibri militari della Nato. Prevalse l’egemonismo del governo israeliano come struttura di comando dell’intera area mediorientale e mediterranea. Ora vogliamo, rilanciando la campagna per la libertà di Öcalan, riaprire il tema anche sul piano giuridico e giurisdizionale. Il primo ottobre del 1999, infatti, la seconda sessione civile del Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di Öcalan all’asilo politico ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana. Il governo italiano, con atto grave, si oppose alla richiesta di Öcalan. Nel procedimento, non a caso, era intervenuta anche la Turchia che, come il governo italiano, contestava la fondatezza della domanda di asilo. Il provvedimento giudiziale del 1999 puntualmente descriveva la negazione, per i Curdi, dei diritti fondamentali e delle libertà, che caratterizzava lo stato di assoluta discriminazione di un intero popolo, rappresentato, per l’appunto, da Öcalan. L’articolo 10 della Costituzione stabilisce che…

