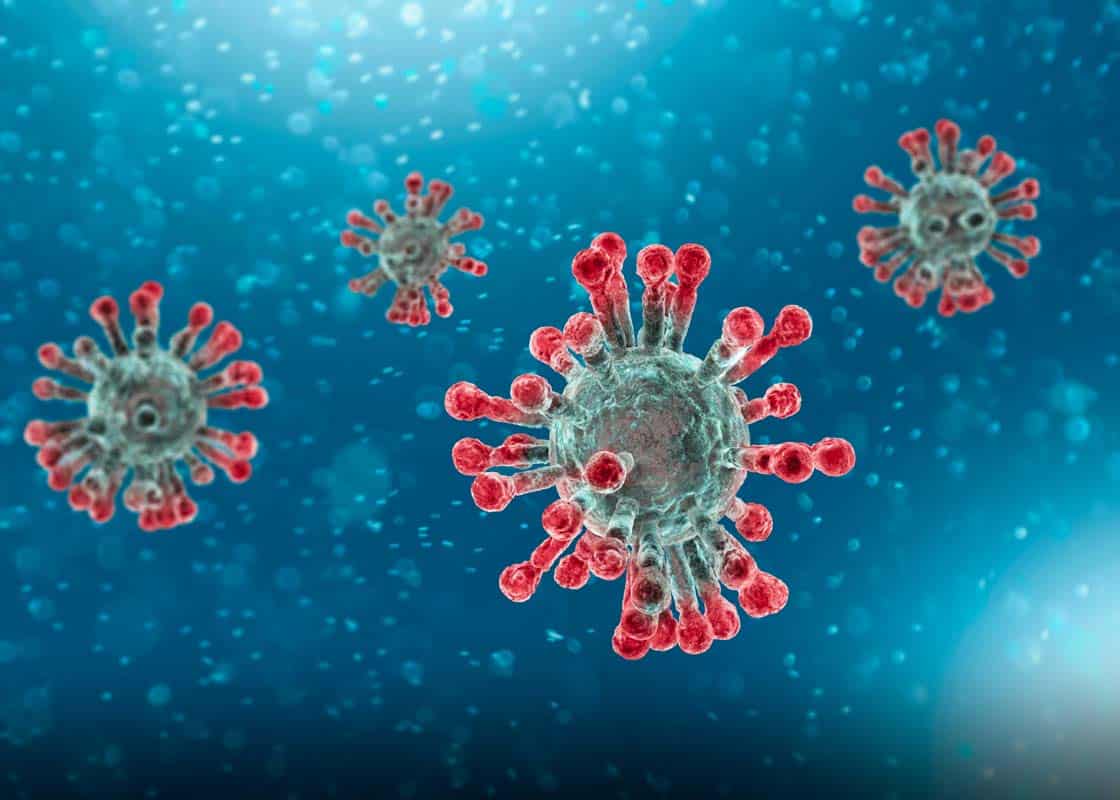Nella settimana in cui la stampa italiana, laica e meno laica, ha esaltato la notizia delle due ricche donazioni alla Caritas – una da 100mila euro e l’altra da ben 10 milioni di euro, rispettivamente da parte di papa Francesco e della Conferenza episcopale – ci sembra doveroso ripubblicare la notizia che troverete nei due seguenti articoli. Risale a poche settimane fa, stranamente oltre a Left ne ha parlato solo un quotidiano romano. Tutti in fila invece per celebrare le offerte opportunistiche e chiaramente mirate a rafforzare un’immagine da “papa buono” e da Chiesa altrettanto buona. Come dice il segretario UAAR Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, Roberto Grendene, autore per Left del primo dei due articoli che leggerete qui sotto, nessun giornale ha avuto il coraggio di descrivere i fatti per quello che sono: «UN MERO GIROCONTO». Nel caso della Cei, effettuato in gran parte con soldi di contribuenti italiani prelevati dal fondo dell’8permille. Ci pare doveroso ricordare, infine, che lo Stato italiano ancora non si è mosso per pretendere il versamento di 4-5 miliardi di Ici-Imu che la Chiesa non ha mai versato dal 2005. Una vicenda che Left segue con attenzione sin dall’inizio.
*
Un Paese riceve su un piatto d’argento la possibilità di incassare tra i quattro e i cinque miliardi di imposte non versate. È un Paese da anni sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea per il rischio di violare le regole di bilancio. Un Paese costantemente alla ricerca di fondi per investimenti e per ripianare un deficit alle stelle. E cosa fa questo Paese? Nulla.
Se il Paese è l’Italia e l’organizzazione che deve pagare gli arretrati è la Chiesa cattolica un tale epilogo non stupisce più di tanto. Nessun governo, anche quelli che promettono di eliminare privilegi, ridurre il cuneo fiscale e in generale di fare il bene dei contribuenti italiani, ha mai intaccato l’aggravio sui conti pubblici causato dalla Chiesa, stimato in maniera dettagliata e tuttavia prudenziale in oltre sei miliardi l’anno nell’inchiesta icostidellachiesa.it realizzata dalla Uaar-Unione degli atei e degli agnostici razionalisti. Figuriamoci un esecutivo che recupera in una volta sola quattro miliardi di arretrati Ici non versati.
Ricostruiamo brevemente la vicenda, che stavolta ha aspetti più paradossali del solito. Nel 2005 Berlusconi fa sì che alberghi, cliniche e altre proprietà ecclesiastiche non paghino l’Ici: bastava anche una piccola porzione della struttura dedicata al culto per esentarla per intero. Nel 2011 l’Imu prende il posto dell’Ici, e Mario Monti escogita un cavillo più sofisticato: l’esenzione – valida anche per le onlus, ma quante onlus possiedono alberghi, scuole o cliniche? – scatta se le tariffe praticate dalla struttura di proprietà ecclesiastica sono “simboliche”, o in ogni caso non superiori a certi parametri spesso di non facile determinazione. Un esempio? Per una scuola dell’infanzia fissare rette annue appena sotto i 6mila euro garantisce l’esenzione Imu. Nel 2012 la Commissione Ue conclude un’inchiesta aperta su segnalazione del fiscalista Carlo Pontesilli che, come Partito radicale, nel lontano 2006 insieme a Marco Pannella e Maurizio Turco (oggi segretario del Partito radicale) denunciò lo Stato italiano alla Commissione Ue perché le esenzioni Ici violano la direttiva sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Bruxelles stabilisce che l’esenzione Ici era sì un indebito aiuto di Stato, ma che l’Italia può chiudere un occhio in quanto sarebbe troppo complicato calcolare il dovuto. La questione passa alla Corte di giustizia Ue che in prima istanza, nel 2016, conferma incredibilmente che quei miliardi non versati possono sul serio passare in cavalleria. Ma nel novembre 2018 la sentenza di primo grado viene ribaltata e si arriva finalmente a stabilire l’ovvio: gli arretrati Ici non versati tra il 2006 e il 2011 vanno pagati (v. Left del 28 giugno 2019, ndr).
Non ci sono più santi che tengano. Ecco spiegato il piatto d’argento contenente una cifra superiore ai quattro miliardi di euro (la stima è dell’Anci). Arduo invece spiegare perché le istituzioni della Repubblica non fanno nulla per incassarli. I governi Conte non ci hanno neppure provato. Anzi, l’allora ministro Tria arrivò addirittura a sostenere che trattenere in acconto parte del gettito dell’otto per mille destinato ogni anno alla Chiesa cattolica – si badi, la quota aggiuntiva rispetto a quella derivante dalle esplicite scelte compiute in sede di dichiarazione dei redditi – sarebbe stato “lesivo delle scelte dei contribuenti”. Proprio così, lesivo di scelte non espresse. Ma se il governo semplicemente non agisce e, beffa oltre al danno, tale inerzia può causare all’Italia una procedura d’infrazione, c’è chi fa forse peggio, facendo lavorare per anni funzionari e società partecipate senza cavare un ragno dal buco. O meglio, senza incassare un euro da un malloppo di 200 milioni. Ricorderete infatti che in campagna elettorale Virginia Raggi aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe chiesto le tasse sugli immobili della Chiesa. “Incasseremo 200 milioni l’anno”, era il convincente slogan elettorale.
Niente da fare, lo scorso 21 gennaio Il Messaggero ha dato notizia che l’esito di anni di lavoro da parte di pool di tecnici dell’Ufficio Bilancio di Roma Capitale e poi degli ispettori di Æqua Roma S.p.A., società che ha tra i propri obiettivi “attività di contrasto all’evasione ed elusione fiscale”, si concretizza in un nulla di fatto. Secondo quanto emerge dai dossier riservati del Campidoglio di cui è venuto in possesso il quotidiano Il Messaggero, sarebbe infatti troppo difficile fare il conteggio dei beni della Chiesa su cui far pagare sia gli arretrati Ici 2006-2011, come impone la Corte di giustizia europea, sia l’Imu dovuta per le strutture che non rispettano i parametri previsti per l’esenzione. Una resa inaccettabile. Sarebbe come dire che la Guardia di finanza alza bandiera bianca nella lotta all’evasione fiscale, giustificandosi con il fatto che è dannatamente difficile individuare tutti gli evasori e tutte le forme di evasione. Certo che lo è, ma proprio per questo è importante andare a fondo, caso per caso, ordine religioso per ordine religioso.
Da quanto trapelato sembra quasi che non si voglia muovere un passo, che si attenda all’infinito per fare un conto unico da presentare non si sa bene a chi. E nel frattempo non solo mancano fondi per investimenti di cui Roma ha urgente bisogno, ma c’è chi paga l’Imu sull’albergo o il bed&breakfast che possiede mentre la Chiesa, che di strutture ricettive ne ha a bizzeffe, continua a essere esonerata dal pagamento. Di dati ne sono stati sicuramente raccolti se i tecnici hanno stimato che sono circa diecimila gli immobili su cui chiedere l’imposta e che gli enti non commerciali che svolgono attività alberghiera a Roma sono al 90% di proprietà della Chiesa cattolica. Cosa aspetta la giunta Raggi a smentire quanto riportato dal Messaggero, a rispettare le promesse elettorali e a far partire la prima cartella esattoriale indirizzata al più grande immobiliarista del mercato?
Roberto Grendene è il segretario nazionale della Uaar
*
Lo strano caso delle case del Vaticano
di Federico Tulli
Mons. Nunzio Galantino dice che l’Apsa sta completando il primo conteggio mai fatto degli immobili di proprietà della Santa sede. Ma esiste già una stima fatta 4 anni fa dal Gruppo RE
Il giorno dopo l’uscita dell’inchiesta sul Messaggero (21 gennaio 2020), il quotidiano romano ha pubblicato una nuova puntata riportando le parole di Nunzio Galantino, a capo dell’Apsa (Amministrazione patrimonio sede apostolica), l’ente finanziario al quale fa capo il patrimonio immobiliare della Santa Sede. Secondo mons. Galatino, il Vaticano ha fatto e sta facendo la sua parte, non solo pagando regolarmente le tasse dovute al Comune e sborsando ogni anno oltre 9 milioni di euro per l’Imu, ma ultimando il primo conteggio degli immobili vaticani che sia mai stato fatto. In pratica, stando alle parole del capo dell’Apsa, entro qualche mese sarà finita la mappatura finale di tutte le proprietà che il Vaticano possiede a Roma e in tutta Italia. «Noi non abbiamo nessun motivo per essere opachi» dice ancora Galatino nell’articolo del Messaggero, precisando che questa ricerca innovativa ha richiesto tante energie e tempo. Tuttavia, precisa il quotidiano romano, il problema della classificazione e della composizione del patrimonio ecclesiastico – appartamenti, edifici, stabili, negozi, capannoni, palazzi, terreni, centri commerciali, ostelli – resta purtroppo aperta e non per colpa del Vaticano ma degli ordini religiosi. Monsignor Galantino spiega che ogni ente religioso avendo una propria personalità giuridica, di conseguenza, è indipendente nella gestione economica. «Il che significa, per farla breve, che non vengono a comunicare i bilanci a noi. Non sappiamo nulla di quello che fanno. Sono autonomi in tutto e per tutto, e non li possiamo nemmeno controllare».
Difatti, diciamo noi di Left, non essendo gli enti religiosi enti extraterritoriali ma soggetti giuridici italiani, il “controllo” dovrebbe essere di competenza delle istituzioni italiane. Tanto più che l’inchiesta del Messaggero allude anche a beni «che fanno capo a prelati», cioè persone fisiche. Ma, appunto, fino a ora nessuno si è mai preso la briga di attuarlo quel controllo. Per velocizzare il lavoro e aiutare, volendo, la sindaca Raggi, suggeriamo a mons. Galatino di leggere Left del 16 febbraio 2018. Scoprirà che esistono già una mappatura e una stima risalenti alla metà del 2016, elaborate dal Gruppo RE, società che per lungo tempo ha fornito consulenze al Vaticano in ambito immobiliare. Nel mondo, lo Stato d’oltretevere – chiese comprese – possiede circa un milione di immobili per un valore di duemila miliardi. Una ricchezza enorme suddivisa in ospizi, orfanotrofi, pii alberghi per turisti e pellegrini, terreni e abitazioni date in locazione. Di questi beni immobili, circa il 70 per cento si troverebbero all’estero. Il 30 per cento è in Italia e comprende oltre quanto detto oltre a 9mila scuole e 4mila ospedali o centri di cura. Dislocati soprattutto a Roma, in Lombardia e nel Veneto. In base alla stima del Gruppo RE (che afferma di operare sul mercato immobiliare «adottando canoni di comportamento deontologico rispettosi dell’Etica, interpretata secondo la morale cattolica»), un immobile su cinque in Italia è di proprietà della Chiesa. In totale fanno circa 115mila fabbricati, di cui 25mila a Roma la cui gestione è affidata a due istituti: Propaganda Fide e, appunto, l’Apsa.
In valore sono stati stimati appartamenti di lusso per circa 9 miliardi di euro. Le case di proprietà sono poco meno di un migliaio (957 nel 2016 di cui 725 a Roma) e vengono date in affitto a persone fidate, oppure, vendute a prezzi non sempre di mercato. Stando a un report della commissione vaticana Cosea, gli appartamenti sono riconducibili a 26 diverse istituzioni riconducibili alla Santa sede. Mentre fanno capo all’Apsa 5.050 appartamenti affittati a prezzo di mercato a gente comune oppure a canone zero a laici che hanno servito la Chiesa: giuristi, letterati e direttori sanitari. Poi ci sono 860 locazioni gratuite, comprese le case-reggia di una quarantina di cardinali nei dintorni di San Pietro.
A tutto questo si devono sommare vecchi monasteri, abbazie ed altri immobili trasformati in hotel e bed and breakfast, per un totale di circa 200mila posti letto corrispondenti e un fatturato annuo che oscilla intorno ai 4,5 miliardi di euro.

Gli articoli sono tratti da Left del 7 febbraio 2020
SOMMARIO
Leggi e sfoglia online o con la nostra App
ACQUISTA L’EDIZIONE DIGITALE