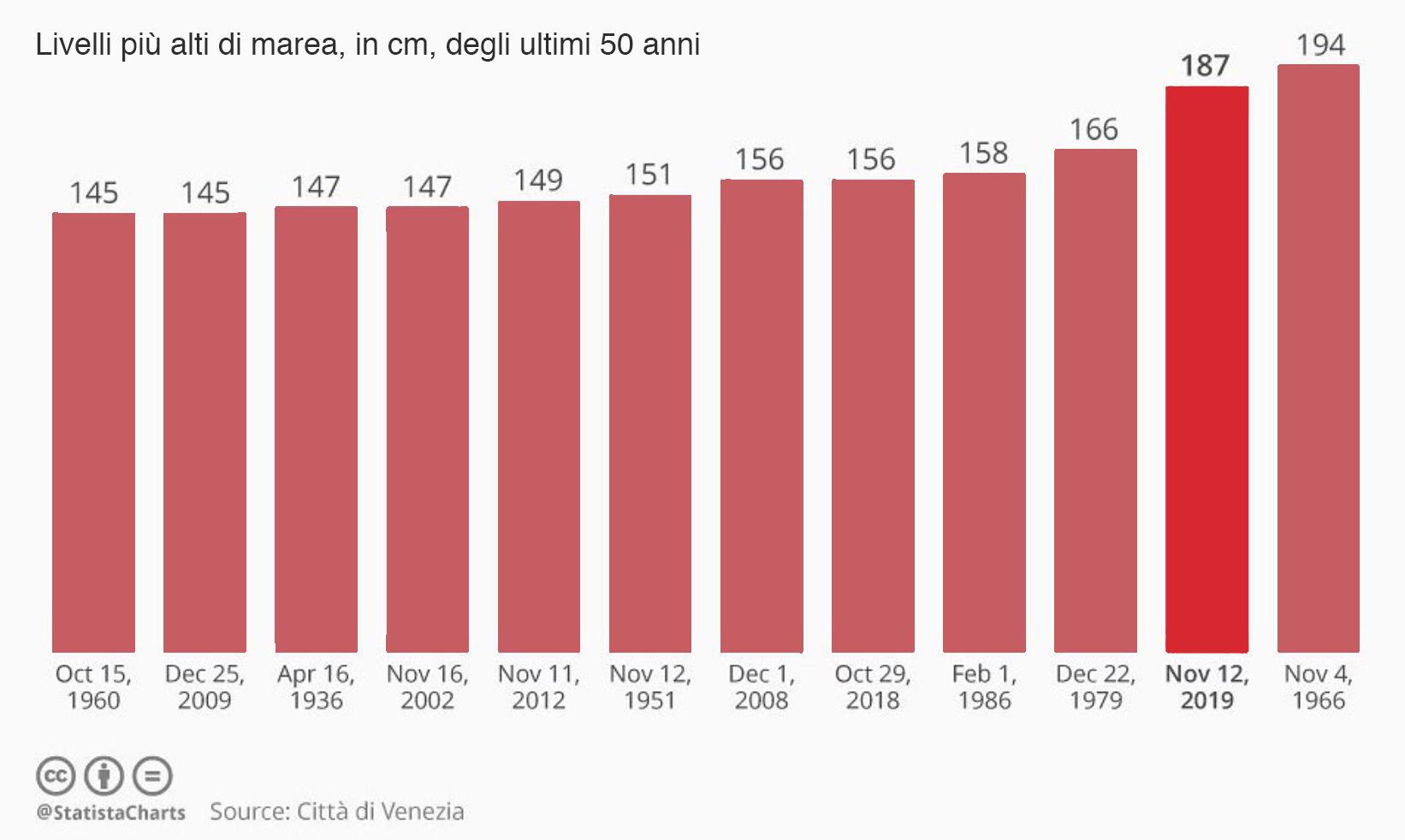Alle 22 del 20 ottobre 2019 gli orologi del Cile, in un paranoico viaggio a ritroso nel tempo, hanno iniziato a segnare la stessa ora illegale del 1973: quella del coprifuoco. Il più grande poeta cileno vivente, Raúl Zurita, di famiglia italiana, voce indomita ed essenziale per capire ogni società ispanoamericana dalle dittature a oggi, definisce il proprio Paese «arrivista, egoista, insolidale, culturalmente sottomesso». Perché l’Italia non sa nulla e non dice nulla del Cile odierno, di quella terra in cui vive quasi un milione di discendenti italiani dei nostri emigrati di fine Ottocento? Perché il Parlamento europeo boccia la proposta di dibattito su quanto sta accadendo a Santiago? Probabilmente perché in quell’arrivismo, egoismo, insolidarietà e sottomissione culturale ci riconosciamo, e quando ci si specchia nell’incontenibile esasperazione dell’altro è meglio distogliere lo sguardo, ché magari ci si contagia. E così del frenetico succedersi di avvenimenti a Santiago e nel resto del Paese da inizio ottobre, in Europa arriva solo il debole eco della tiritera dei luoghi comuni della violenza, e ci si limita a fare da cassa di risonanza ai media allineati col governo di destra del presidente Sebastián Piñera: «Siamo in guerra». Una guerra inesistente. Una guerra dell’esecutivo contro se stesso, semmai, contro la propria incapacità assoluta di comprensione e gestione delle proteste: «Piñera non riconosce, non capisce la portata di quel che è successo al Paese, e lo crede controllato da Cambridge Analytica o da un nemico oscuro e poderoso», dice lo scrittore e regista Diego del Pozo.
La moglie del presidente, Cecilia Morel, in un audio a un’amica filtrato sui social attribuisce la responsabilità delle proteste addirittura all’intervento di forze extraterrestri: «Tutto ciò ci supera completamente, è come un’invasione di alieni e non abbiamo gli strumenti per combatterla. Ci toccherà limitare i nostri privilegi». E proprio dai privilegi dei pochi, anzi, di pochissimi, bisogna partire per arrivare a quel salto di massa dei tornelli della metro da parte di studenti universitari e del liceo, dopo che il 4 ottobre il ministro dei Trasporti annunciò il rincaro dei biglietti, invitando la popolazione ad «alzarsi dal letto prima, per godere della tariffa agevolata». «Non pagare è un modo di lottare», rispondono per la prima volta, all’unisono, gli abitanti di un Paese presentato finora come prospero e stabile dagli indicatori internazionali del capitalismo selvaggio che in realtà lo tiene asservito. Galo Ghigliotto, scrittore, editore e sceneggiatore, scrive che «il 33% dell’utile generato dall’economia cilena finisce nelle mani dell’1% della popolazione e, a sua volta, il 19,5% di quell’utile va a parare nelle tasche dello 0,1% dei ricchi più ricchi». Funziona così da trent’anni. «Iniquità e violenza sono eredità della dittatura e hanno trovato terreno fertile nel trattamento che il governo di destra di Piñera riserva ai cittadini. La Costituzione del 1980 è stata fatta per implementare il modello neoliberale e per proteggerlo, per favorire e tutelare con l’uso della forza i privilegi della classe politica e imprenditoriale», aggiunge Ghigliotto.
In Cile si è privatizzato tutto il privatizzabile: educazione, sanità, pensioni, settore minerario (maggiore produttore di rame del mondo, il Cile ha anche grandi risorse di litio, solo per citare due minerali fondamentali al nostro sviluppo tecnologico e industriale); l’affitto di un bilocale a Santiago costa in media 495 euro, ma lo stipendio minimo è di 373; ben il 30% del salario dei meno abbienti, in una città enorme come Santiago, viene destinato alle spese di trasporto, e quest’anno ci sono già stati rincari per elettricità, acqua e gas; la settimana lavorativa è di 44 ore; Wallmapu, il territorio Mapuche, è stato completamente militarizzato e qualsiasi scusa è buona per incriminare i nativi; la legge sull’aborto continua, tra mille altre costrizioni, a privare di libertà le donne; l’indice di suicidi tra adolescenti e anziani è molto alto: impossibile resistere a tanta spaventosa precarietà, a tanta violenza. È stata questa la spinta sociale a far saltare i tornelli e provocare «un’esplosione inorganica e del tutto cittadina, priva di direzione politica: nessuno l’ha organizzata», racconta Nona Fernández, scrittrice molto apprezzata in Italia e autrice de La dimensione oscura (Gran vìa) un capolavoro del XXI secolo che rianalizza e ricostruisce la dittatura attraverso i gesti e i pensieri di un torturatore.
Limitarsi a guardare le immagini della violenza nelle strade «generata in gran parte dai militari e attribuita al “lumpen”- continua Fernández – significa non rendersi conto che il “lumpen” è scaturito da anni e anni di liberalismo. Il “lumpen” non va assolto dalle proprie responsabilità ma è anch’esso vittima di questo sistema schifoso in cui siamo immersi e che ci obbliga a volere sempre qualcosa, e poi qualcos’altro e qualcos’altro ancora». Sotto la tensione sociale sanguina la memoria storica: non sempre è vero che le ferite si curano lasciandole aperte. «Della dittatura non c’è stata riparazione sufficiente; Pinochet è morto da senatore a vita e il suo feretro è stato vegliato come ex comandante in capo nella Escuela Militar de Chile, mentre migliaia di famiglie ancora oggi non sanno nulla di dove si trovino i resti dei loro cari, oppure se li vedono recapitare a pezzi e in consegne successive, come nel caso del giornalista Carlos Berger», aggiunge Ghigliotto.
La disunione della sinistra ha favorito il ritorno di Piñera alla guida del Paese; i media cileni, inoltre, sono in maggioranza controllati da gruppi economici affini al governo, e anziché dar conto onesto delle cause dell’esacerbazione sociale hanno puntato il dito e le telecamere sui saccheggi ai supermercati, alle farmacie e alle casse automatiche delle banche, quando la protesta è dilagata: nessuno ha detto che, nel mentre, la polizia era impegnata a proteggere i quartieri ricchi della città. L’esercito nelle strade, il coprifuoco, la dichiarazione dello stato di emergenza sono i simboli del madornale errore di Piñera, la molla che nei ricordi dei cileni ha riportato indietro di trent’anni le lancette dell’orologio della memoria e ha inasprito gli animi. D’altra parte questo è un governo di parentame e di saldi legami con la dittatura del ’73: sono parenti il presidente Piñera e il ministro dell’Interno Chadwick (lui e altri membri dell’esecutivo furono collaboratori di Pinochet) e a loro volta hanno parenti che si cibano della prelibata torta delle privatizzazioni. Un 49% dei cittadini non votò per la destra alle ultime elezioni e Piñera riuscì a intercettare il voto delle fasce della popolazione meno politicizzata agitando il fantasma del “Cilezuela”. «Tutto è più trasparente, ora, in Cile», dice la scrittrice María José Ferrada, della quale è uscito da poco in Italia Kramp (Edicola Ediciones) una storia di ribellione agli schemi che trova nuovo vigore alla luce delle proteste di questi giorni. «È saltata per aria l’immagine di Paese stabile che finora si proiettava fuori dai nostri confini. Continuare ad accettare le cose come abbiamo fatto finora ci faceva più male dei lacrimogeni».
La rete e i social sono stati fondamentali per raschiare via la patina della perfezione; il motore della macchina del fango in questo caso erano i giornali, la televisione e la radio vicini al potere. In un ultimo, pindarico ed estremamente ridicolo tentativo di appropriarsi della protesta che ha unito un milione e mezzo di persone solo a Santiago, Piñera ha dichiarato «vogliamo tutti un cambiamento», ed ha annunciato un tardivo rimpasto di governo e il blocco degli aumenti, che verrà compensato da una redistribuzione delle risorse. Non toccherà gli imprenditori quindi, lascerà tranquille le élites e, di conseguenza, nelle strade non cambierà nulla, dice ancora Nona Fernández: «Nessuno vuole fermarsi né recuperare alcun tipo di normalità, perché ora abbiamo un’opportunità storica: cambiare la Costituzione, averne finalmente una che garantisca i diritti di tutti i cittadini, non solo quelli delle aziende e dei loro proprietari. Vogliamo cambiare l’intera scacchiera su cui si sta giocando da trent’anni».
Non possiamo dimenticare i morti causati dalla brutalità della repressione della protesta; le stime ufficiali parlano, al momento, di 19 persone, ma altri dati elevano il numero a oltre 200. Si stanno verificando inoltre un gran numero di incendi apparentemente incontrollati, e tra quelle macerie appaiono cadaveri che si sospetta l’esercito scaraventi lì per sbarazzarsene. Secondo il dossier elaborato dall’Istituto nazionale dei diritti umani, il 25 ottobre i detenuti erano 3.162, dei quali ben 545 donne e 343 bambini, bambine e adolescenti. Quindici le denunce presentate per violenza sessuale. La repressione in provincia sembra sia stata molto più feroce che a Santiago. Cosa si fa, cosa possiamo fare, tutti, ora? «La protesta rappresenta il ritorno alla consapevolezza dell’importanza del senso di comunità», spiega Paolo Primavera di Edicola Ediciones, una casa editrice con radici sia in Italia che in Cile. «Questa è una lezione per molte società: cancellando l’egoismo possiamo essere il motore di ogni cambiamento auspicabile», aggiunge. «Quel che succede là fuori, a Hong Kong, a Beirut, in Siria, a Caracas, ci riguarda e ci tocca da vicino, perché siamo tutti collegati. La fragilità e la vulnerabilità ci hanno reso più forti, ci hanno risvegliati», conclude la scrittrice Lola Larra. È senz’altro il momento di girare la frittata, come cantavano i Quilapayun negli anni 60, «que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda»; e magari di smentire perfino il grande Zurita, contrastare la disinformazione e fare in modo che né l’Italia né l’Europa distolgano lo sguardo dal Cile e da se stesse.