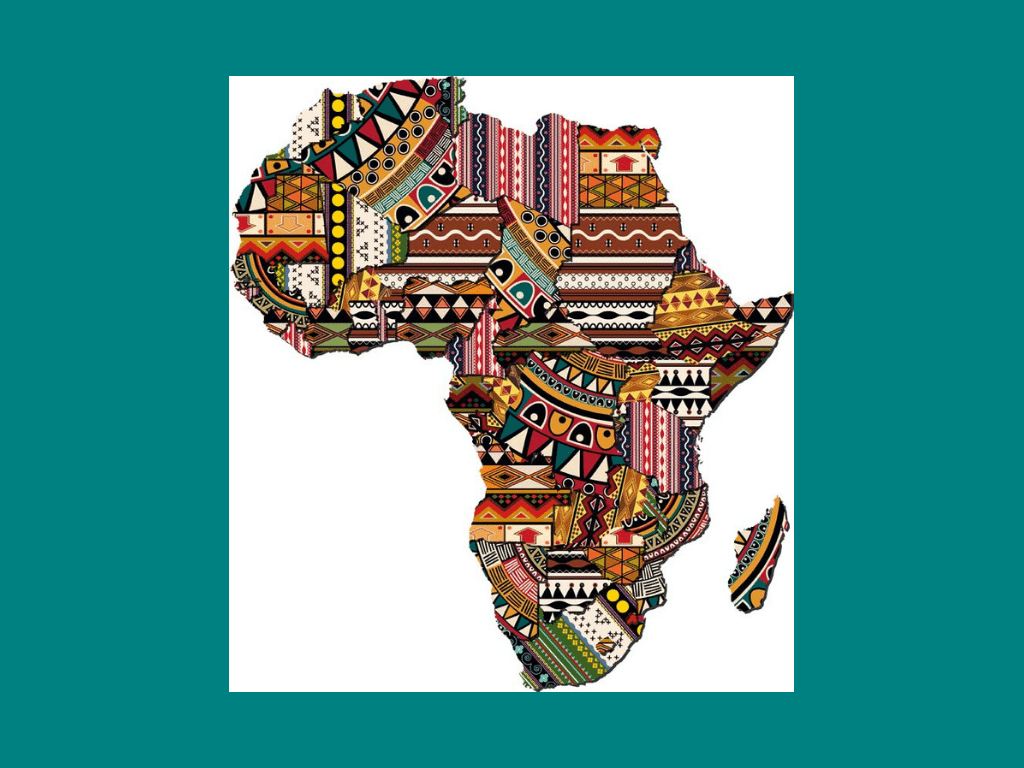Oggi non c’è più nulla. Addirittura il civico 34 di via Patriarcato a Padova è stato cancellato, si passa direttamente dal 32 al 36. Una via lunga, in parte con porticati, a poco più di duecento metri da piazza dei Signori, in pieno centro. Eppure lì, al 34, un tempo c’era una libreria, aperta solo al giovedì dalle 22 alle 24, con al posto della vetrina una saracinesca sempre abbassata. Sul campanello la scritta “Ar”. Ad avviarla, il 9 dicembre 1963, Franco Freda, che prese in affitto i locali di un’ex rimessa. Assunse il nome di Libreria Ezzelino, in onore del signore e condottiero ghibellino del 1200, di origini germaniche, feroce e terribile. Dante Alighieri lo collocò, non a caso, all’Inferno, immerso in un fiume di sangue. Il termine “Ar”, da cui le edizioni omonime fondate dallo stesso Freda, non era altro che la radice di “ariano”, Ares o aristocrazia, a indicare guerra e razza superiore. Alle vicende che ruotarono attorno a questa libreria e alla figura di Franco Freda, lo scrittore padovano Ferdinando Camon, nel 1975, dedicò uno dei suoi romanzi, Occidente.
Quando parliamo della strategia della tensione, dell’escalation degli attentati che si susseguirono in Italia dalla primavera del 1969 fino alla strage di piazza Fontana, è da qui che dobbiamo partire. Era in questi locali, infatti, che si riuniva la cellula di Ordine nuovo capitanata da Franco Freda e Giovanni Ventura. A raccontarlo con dovizia di particolari furono più d’uno.
Martino Siciliano di Ordine nuovo di Mestre parlò della riunione in cui «Freda annunciò il programma degli attentati ai treni», poi compiuti nell’agosto successivo, una decina di bombe, di cui otto scoppiate, dodici i feriti. A sua volta Gianni Casalini, uno dei suoi frequentatori – poi reclutato come informatore dal Sid – nome in codice “Turco”, nel maggio 2000 a Milano, durante il primo grado dell’ultimo processo sulla strage di piazza Fontana, in un difficile quanto tormentato interrogatorio, fece cenno alla sua partecipazione agli attentati proprio sui treni. Una deposizione letteralmente caduta nel vuoto, senza che nessuno si ponesse neanche il problema di risentirlo successivamente. Sarà solo nel settembre 2008 che Gianni Casalini chiederà, tramite lettera, di poter conferire con il giudice Guido Salvini che si era occupato delle ultime indagini sulle bombe del 12 dicembre 1969.
Aveva molte altre cose da raccontare. In precedenza, bloccato dalla paura di ritorsioni da parte degli ex camerati, si era lasciato andare solo a qualche timida ammissione. Prima al giudice Salvini, poi un paio di mesi dopo, di fronte a un sostituto procuratore, Gianni Casalini disse con una grande quantità di dettagli del suo operato alla stazione Centrale di Milano nella notte dell’8 agosto 1969. Di come collocò due bombe su altrettanti treni in partenza, il numero del binario di uno dei due, la carta da regalo con cui erano stati avvolti gli ordigni per mascherarli. Riferì l’identità di chi era stato a reclutarlo alla Libreria Ezzelino. Fece anche il nome di uno dei principali collaboratori di Franco Freda, Ivano Toniolo, membro di Ordine nuovo ed esponente di una delle correnti più radicali dell’Msi, che dopo l’inizio delle prime indagini sulla «pista nera», annusando il pericolo, era fuggito all’estero, prima in Spagna, poi in Mozambico. Morì nel 2015 a Luanda in Angola senza che alcun magistrato, nonostante le sollecitazioni dei familiari delle vittime, lo avesse mai cercato.
La Libreria Ezzelino fu fatta perquisire il 23 giugno 1971 dal Giudice istruttore di Treviso Giancarlo Stitz nell’ambito delle indagini sulla “pista nera” per la strage di piazza Fontana. Nelle carte sequestrate furono reperite molte missive scambiate da Freda con esponenti importanti del neonazismo, tra loro Adriano Romualdi e Pio Filippani Ronconi, arruolatosi nelle Waffen-Ss italiane, poi figura di riferimento centrale del neofascismo degli anni Sessanta e Settanta.
Ben ventidue furono gli attentati compiuti in Italia dal 13 aprile al 12 dicembre 1969. Il primo fu allo studio del rettore di Padova, Enrico Opocher, antifascista e partigiano, di origine ebraica, con cui Freda discusse la propria tesi per la laurea in giurisprudenza. Di lui Opocher dirà: «È un uomo fanatico su posizioni antisemite». L’ordigno in un involucro di metallo devastò i locali, che presero fuoco, distrusse carte e documenti, scardinò porte e infissi.
I processi hanno riconosciuto che tutti gli attentati furono compiuti da Ordine nuovo attraverso il suo braccio armato veneto, ovvero la cellula padovana di Freda e Ventura. Per quelli prima di piazza Fontana, Freda e Ventura furono ritenuti colpevoli e condannati a 15 anni di reclusione per associazione sovversiva. Per la strage del 12 dicembre 1969, nel 2005, la Cassazione scrisse che «il giudizio circa la responsabilità di Freda e Ventura in ordine alla strage di piazza Fontana non può che essere uno: la risposta è positiva». Ma la responsabilità non poté tradursi in condanna. Erano già stati assolti nei processi precedenti.
*
Saverio Ferrari dal 2000 dirige l’Osservatorio democratico sulle nuove destre