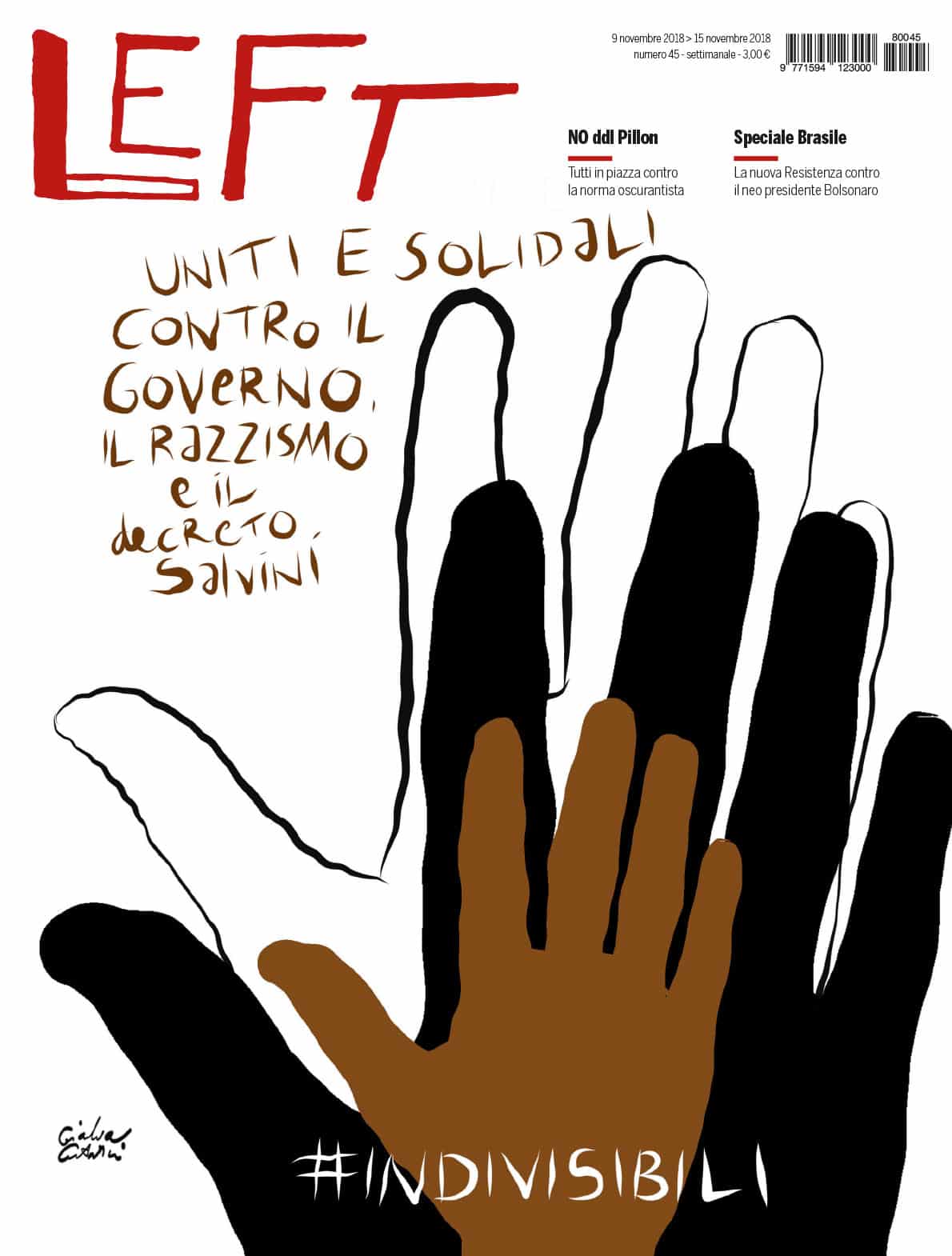Luigi Fabbrini, docente alla Luiss, nel suo “Il populismo e i pericoli dei movimenti «contro»” pubblicato sul Sole24 Ore ha innescato un interessante dibattito. Molti altri si sono cimentati su questi temi ed argomenti.
L’articolo di Fabbrini, a mio avviso, ha il merito di mettere al centro del dibattito un tema quanto mai di attualità. Bisogna evidenziare alcune “carenze” – per non dire dell’origine, e della storia del populismo, nato in Russia, народничество, a cavallo tra XIX e XX secolo, ad opera di intellettuali e studenti che combatterono contro la dittatura zarista a favore delle masse rurali -, comprensibili, perché quello di Fabbrini non è un articolo storico-culturale, ma strettamente politico, riferito al solo oggi e alla sola Italia. E un certo grado di “populismo” è presente in ogni forza politica, italiana e non (perfino Obama è stato “accusato” di populismo).
Ma una rilettura, chessò, di McCormick Sulla distinzione tra democrazia e populismo, o una ripassata a Massa e potere, grande saggio di Elias Canetti, non avrebbero fatto male all’estensore del pezzo sul Sole 24 Ore, autorevole accademico della Luiss, peraltro, come dicevo. O anche solo la rilettura di qualche commento, in questi ultimi anni, di Nadia Urbinati. Esiste anche un “populismo democratico” o un “populismo di sinistra” (Rousseau e poi i giacobini; i movimenti e partiti “nazionali” in moltissimi paesi dell’America latina; il movimento degli indignados, sfociato poi in Podemos; France insoumise;…).
Da noi, dal lontano “uomo qualunque” degli anni Cinquanta, siamo arrivati al M5s e alla Lega nord, passando anche, però, per il movimento di Di Pietro; situazioni complesse, sostanzialmente (in alcuni casi oggettivamente e dichiaratamente) di “destra”; insomma, oltre al merito di cui dicevo sopra, l’articolo, pur denunciando reali pericoli e pessime prospettive per noi, è un tentativo, neanche tanto nascosto, di riportare in carreggiata («rafforzare i guardrails», scrive l’autore) il sistema politico e di potere in Italia: condivisibile, ma solo in parte, se questa carreggiata è gestita, poi, dalla Confindustria, così come sembra di fatto augurarsi l’autore del pezzo.
Un successivo intervento Alessandro Zampella “Può esserci anche un populismo di sinistra: una sfida da accettare” è “discutibile”, nel senso che si può e deve discutere, “accettare la sfida”, come brillantemente e sinteticamente suggerisce il titolo. Recente sviluppo ed esempi di populismo chiamano in causa il mutamento delle basi sociali della democrazia, della cittadinanza nazionale e della rappresentanza politica; la scomparsa dei cosiddetti corpi intermedi; la sfiducia che i sondaggi misurano ormai ogni giorno, ossessivamente, nel modo di gestire le istituzioni e nello stesso pluralismo e “democrazia” dei e nei partiti.
A mio avviso, pur non condividendone alcune conclusioni, ritengo l’intervento di Zampella interessante ed importante perché spinge comunque (pro o contro che sia) ad analizzare il populismo, non utilizzando esclusivamente categorie manichee o catastrofiste. Pur evitando di avventurarsi in un saggio politologico e sociologico, occorre precisare che tratto caratteristico dei populismi sembra essere, in genere, un’idiosincrasia per forme di rappresentanza elettorale, contrapponendo loro la volontà unitaria e collettiva del popolo.
Importante e decisiva, in questo caso, l’identificazione con un leader, la personalizzazione della politica. Il leader deve essere capace, questo è lo scopo della sua “creazione”, di mettere a tacere i conflitti dei vari partiti che escono fuori da elezioni; un leader ha bisogno della “fede” del suo popolo, non di una sua richiesta di rendiconto a fine mandato. In questo modo, le elezioni devono diventare uno strumento per “celebrare” il leader, per incoronarlo, ma, attraverso di esso, celebrare ed incoronare “il popolo”. A differenza di una democrazia rappresentativa, allora, il leader non si rivolge ad un intermediario, il parlamento, ma direttamente al popolo (tipico, ad esempio, l’uso preferenziale di referendum popolari, invece che di “elezioni”)
Ecco, già queste sole considerazioni suggerirebbero, dal mio punto di vista, “da che parte stare”. Però. Però io stesso dicevo di un certo populismo di sinistra; tralasciando i primissimi tentativi filosofico-moral-politici alla Rousseau (il filosofo, non la piattaforma software!), i primi esempi si sono avuti in America Latina, fin dallo stesso Peron, in certa misura. E più recentemente, una vera e propria stagione “progressista”, Chavez in Venezuela, Lula e poi Rousseff in Brasile, Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, che dapprima contrapposti ai gruppi neoliberisti e conservatori dei rispettivi paesi, hanno poi trasformato i loro “movimenti” in vere e proprie forze di governo. Tutti hanno realizzato una straordinaria mobilitazione sociale e originali e specifiche forme di partecipazione politica, consentendo a milioni di cittadini di “tornare” a poter dire la loro nella vita politica dei rispettivi paesi. Uno dei caratteri principali dei “populismi”, il sovranismo, in questi casi è sfociato in un sovranismo molto allargato, fino a favorire incontri e alleanze con paesi con un orientamento simile, una sorta di pensiero transnazionale pan-sudamericano, in opposizione al pensiero filo-statunitense dominante dei precedenti governi. E tutti hanno inteso, in diverse forme e con diverse fortune, ed esplicitamente tentato, di affermare una società socialista, ovviamente di tipo nuovo, moderno, adattata alle loro “abitudini mentali”. Un “latin-american socialism”. Ad ogni modo, il loro “traguardo” è stata una democrazia partecipativa piuttosto che rappresentativa, alla quale invece noi guardiamo con più “abitudine”. Ma pur sempre di democrazia si tratta (anche se alcuni parlano di soft authoritarism per questi tipi di “regimi”).
In Europa, l’esempio che viene subito in mente è quello di Syriza e di Tsipras, e alle nostre latitudini il populismo si intreccia fortemente con un sentimento euroscettico. Syriza esprime ribellione nei confronti di un neoliberalismo europeo, e mira ad un ampliamento del welfare e della solidarietà europea, mentre movimenti dichiaratamente ed oggettivamente di destra predicano un ritorno alla sovranità nazionale e alla diminuzione di prerogative e poteri della Ue, e quindi del welfare e della solidarietà europea. Non c’è niente da fare, hanno voglia i cantori di “destra e sinistra” a sgolarsi per dimostrare che queste categorie sono obsolete e di fatto non esistono più (ormai consolidato, anche nell’immaginario collettivo italiano, il Renzi-pensiero, la requisitoria di Renzi, quasi una sorta di manifesto politico, in cui, discutendo del saggio di Bobbio Destra e Sinistra affermava che la “linea di demarcazione” ormai è tra conservazione, i vecchi della sinistra, e cambiamento, lui, e non più tra destra e sinistra. Cambiamento non è sinonimo di progresso e miglioramento, anche tra populisti ed euroscettici passa una demarcazione destra-sinistra.
Da un lato la critica economica, sviluppata dalle forze di sinistra, che denuncia la gestione ultraliberale, liberista addirittura per certi aspetti, dei problemi economici (e politici) europei, l’austerità, a senso unico naturalmente, la connivenza con “i più forti”. Chi “predica” queste cose spinge a mantenere alto il livello e le strutture di welfare nazionale e a sviluppare la solidarietà tra tutti gli stati ed i cittadini europei.
Da un’altra parte, i movimenti di destra puntano sul riscatto del sentimento di nazione, che stabilisca chiari confini, geografici, etnici, sociali. Non facciamo finta di non capire quale sia il pericolo.
In Europa ci dobbiamo stare, puntando a rafforzare in senso solidaristico le strutture istituzionali sovranazionali, combattendo invece le forze che in un nome di un populismo tradizionale, potremmo definirlo così, mirano alla conservazione delle differenze economiche e sociali tra gruppi socialmente o anche etnicamente diversi.
Bisogna riorganizzare una proposta credibilmente alternativa che riarticoli, in Italia e in Europa, le forze del socialismo, con una proposta di governo che sposti gli equilibri e gli interessi verso il Mediterraneo, che ponga quindi nuovamente il Mezzogiorno d’Italia, per portare acqua al mio mulino, al centro di una politica di sviluppo, che coltivi gli interessi generali non lasciando mai indietro chi più ha bisogno di aiuto e sostegno.
Ma, aggiungerei per essere chiaro, non limitarsi a ragionare di Pse o di gruppo al Parlamento europeo S&D, ma allargare lo sguardo all’Internazionale socialista. E a tutti i movimenti democratici, di democrazia partecipata, alle esperienze “socialiste” diversificate, in ogni parte del mondo. Nelle recentissime elezioni di midterm negli Usa, ad esempio, sono stati eletti molti giovani appartenenti ai Democratic socialists of America, gruppo che si muove nell’orbita del partito democratico, che vedono Bernie Sanders come leader e ispiratore, e Alexandria Ocasio-Cortez come punta di diamante.
Tornando a noi, sono necessarie, in buona sostanza, nuove politiche pubbliche, un programma di governo che segni discontinuità netta con il presente e con il recente passato, rilanciando nel contempo un progetto europeista che cambi di 180 gradi la rotta della attuale governance continentale, costruendo una Europa davvero sovrana, con istituzioni democratiche, e che abbia a cuore la felicità ed il benessere dei suoi cittadini. Tutti. Per governare i grandi processi sovranazionali, garantire solidarietà e redistribuzione, contrastare le degenerazioni e gli egoismi localistici, retrivi, antidemocratici e, alla fine, pericolosissimi per i popoli d’Europa e del mondo intero.
Veniamo al contingente, le nostre disadorne cose. Per raccattare qualche voto in più non dobbiamo neanche pensare di snaturare le nostre idee di fondo, i nostri principi, per andare corrivamente insieme con un malinteso ’o popolo ‘o ‘vvo’. Ritirarsi sdegnosamente in uno sterile Aventino? Ma neanche per sogno. Rimboccarsi le maniche, ripartire a mio avviso da un sano principio (che ormai sembra talmente obsoleto e inutile), quello di studiare, nel senso di ascoltare richieste e problemi, e proporre soluzioni che abbiano l’obiettivo, lo scrivono ormai in molti, di proteggere ed emancipare i più deboli, in tutti i sensi, rendendo possibile una crescita complessiva di tutti i cittadini, consentendo loro di poter esigere in maniera consapevole e partecipata diritti, civili, sociali, economici; di far crescere la democrazia e la libertà, oltre che la giustizia sociale, rendendo possibile il realizzarsi di necessità, ambizioni, aspirazioni di tanti ragazzi, tante donne, tanti cittadini che non chiedono altro che poter vivere dignitosamente, potendo davvero contare nelle grandi scelte nazionali e sovranazionali, nei modi e nei limiti previsti dalla Costituzione.
Nazionalisti e sovranisti? Nazionalisti e sovranisti anche nelle singole Regioni? O, essendo quello “regionale” un concetto storicamente mai attecchito nel nostro paese, un sovranismo “comunale”, cittadino? La Lega ci prova (e, temo, riuscirà): parlo della richiesta di autonomia delle regioni Veneto e Lombardia. Se ne discuterà a breve nelle sedi deputate. Il docente di Economia all’università di Bari Gianfranco Viesti ha lanciato una petizione, No alla secessione dei ricchi, che invito a sottoscrivere. Deputati di Mdp, di M5s (nessuno del Pd, fin’ora) hanno aderito. Ha aderito anche Susanna Camusso, leader della Cgil. E molti accademici e professori universitari, quelli che conosco di più, me compreso.
Per la stima delle risorse che lo Stato dovrebbe trasferire alle Regioni per le nuove competenze, la Regione Veneto propone di calcolare i “fabbisogni standard” in modo inaccettabile, tenendo conto non solo dei bisogni specifici della popolazione e dei territori (quanti bambini da istruire, quanti disabili da assistere, quante frane da mettere in sicurezza) ma anche del gettito fiscale e cioè della ricchezza dei cittadini. In pratica i diritti (quanta e quale istruzione, quanta e quale protezione civile, quanta e quale tutela della salute) saranno come beni di cui le Regioni potranno disporre a seconda del reddito dei loro residenti. Quindi, per averne tanti e di qualità, non basta essere cittadini italiani, ma cittadini italiani che abitano in una regione ricca. Vogliamo impedire, per quanto possibile, questo attacco alla unità dello Stato italiano, alla solidarietà “costituzionale”? Anche questo è sovranismo. Parliamone, facciamolo sapere.
Il petrolio si estrae in Basilicata; le società interessate hanno sede in Lombardia; pagano tasse in Lombardia; vogliono tenersi il gettito fiscale prodotto da risorse del Mezzogiorno. Ecco, in soldoni, cosa potrebbe succedere! Un ulteriore moderno depredamento del Mezzogiorno. Dopo quello, storico e inconfutabile, del post-unità, dal 1861 in poi. Anticostituzionale, peraltro.
Anche questo è “sovranismo”. Lo ripeto. Se non si coniugano le necessità delle popolazioni di un territorio con la necessaria solidarietà, sociale, economica, civile, politica, democratica, di un territorio più vasto, pensando all’Italia unitaria, pensando ad una Europa solidale e democratica, non si fanno passi avanti per la realizzazione di un posto in cui vivere meglio, ma, al contrario, si lavora, coscientemente o inavvertitamente, ad uno stato di cose pre-moderno, in cui vige la legge del più forte, del più feroce. Ed in tale situazione milioni di cittadini, la parte più debole dell’Italia e dell’Europa, rischiano di andare a fondo.
Se “recuperare sovranità nazionale significa puntare a realizzare una vera Europa dei popoli, fondata sui valori di uguaglianza e solidarietà internazionale e su una piena legittimità democratica”; e, aggiungo, dotata di organismi democraticamente eletti, ai quali risponde un “governo europeo”, allora ci siamo. In questo caso, pour épater les bourgeois può anche essere accattivante dirsi populista e sovranista, ma non si è contro l’Europa. Con i suoi popoli, i suoi rappresentanti eletti, il suo governo, che scaturisce da libere e democratiche elezioni.
Giuliano Laccetti è ordinario Università degli Studi di Napoli Federico II e fa parte della segreteria regionale Articolo Uno-Mdp Campania. Inoltre è presidente del Comitato Scientifico dell’associazione e-Laborazione