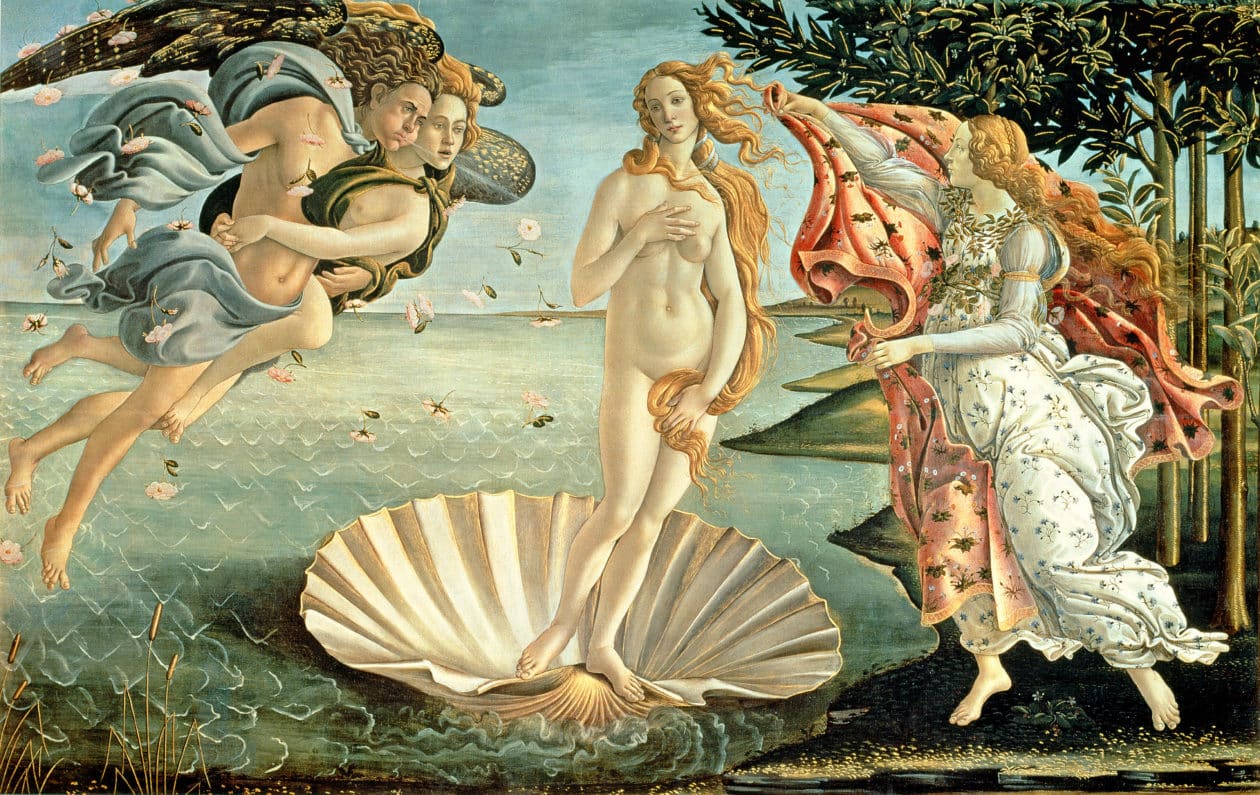Ho letto recentemente un’intervista a Alessio Figalli, vincitore della medaglia Fields, il premio che viene definito il “Nobel della matematica”. La domanda dell’intervistatore era “Perché non hai pensato di restare in Italia?”. La risposta di Figalli è stata decisamente spiazzante. Perché non ne ha fatto una questione di minori o maggiori possibilità che si hanno in Italia rispetto all’estero. Semplicemente ha raccontato come sia capitato che partecipasse alle olimpiadi di matematica mentre frequentava il liceo classico a Roma e poi è capitato che si informasse sulla Normale di Pisa e decidesse di fare il concorso e poi è capitato che facesse un dottorato su un campo di studi che lo aveva affascinato e poi che vincesse una borsa per il Texas dove poi è diventato professore. Da dove poi è stato chiamato per diventare professore all’Università di Zurigo.
La cosa interessante è proprio questa mancanza di polemica con la realtà italiana dove peraltro si è formato. Figalli è un talento della matematica. Ma è anche un cittadino del mondo, come la gran parte degli scienziati dei nostri giorni.
Non esiste per loro una sola nazione in cui formarsi e vivere così come non esiste una sola lingua in cui esprimersi. La lingua franca della scienza è l’inglese ma conosco molti amici ricercatori e professori che sono in grado di esprimersi in almeno un’altra lingua oltre all’italiano. Non esistono frontiere e non esistono razze. Esiste un’unica umanità. E non c’è alcun bisogno di affermarlo, è così e basta. Ecco quindi che Figalli risponde in maniera sorpresa ad una domanda che in effetti non ha molto senso. È giusto e sano che chi si forma per fare ricerca in Italia vada a specializzarsi e a studiare all’estero. Deve farlo. È qualcosa che serve per comprendere meglio di quanto si possa fare nel corso di studi universitario che il mondo è uno solo così come è una sola l’umanità ed è una sola la scienza. Non esiste una scienza italiana o americana. Esistono senz’altro centri di ricerca, università, scuole di specializzazione e di alti studi nei vari paesi del mondo.
Ma la scienza, intesa come conoscenza della realtà, è una sola. Ed è universale. Tutti gli scienziati lo sanno. La politica no (o fa finta di non saperlo). D’altra parte la scienza ha ricadute tecnologiche che possono diventare molto importanti per lo sviluppo economico delle nazioni. La politica lo sa (anche se in Italia non sembra così) e fa di tutto per agevolare queste possibilità di movimento nel mondo degli scienziati. Gli scienziati sono il meglio, l’espressione massima dell’umanità. Vengono coccolati e cercati in tutto il mondo e gli viene concessa assoluta libertà di movimento e di residenza.
La nostra piccola politica italiana è indietro su una semplice verità. Non comprende che attrarre scienziati e ricercatori e finanziare la ricerca cosiddetta di base, quella che apparentemente non serve a nulla, è il migliore investimento che si può fare, quello che sulla distanza rende di più in termini di economia reale perché ha delle enormi ricadute tecnologiche e culturali.
Il problema non è tanto quindi la fuga di cervelli, che come abbiamo scritto su Left 30 del 27 luglio scorso è in realtà la fuga di tanti giovani in cerca di un lavoro “normale”.
Andrebbe incentivata la possibilità di viaggiare dei ragazzi, di fare esperienze di studio e di ricerca all’estero, magari anche durante il corso di studi secondario così come accade con l’Erasmus per l’Università. E anche, perché no, le possibilità di lavoro all’estero magari con delle strutture di accompagnamento e di facilitazione da parte degli stati europei.
E poi andrebbe certamente finanziata in maniera massiccia l’Università e la ricerca per poter attrarre talenti dall’estero, persone che possano venire a studiare e fare ricerca in Italia. Andrebbe data a tutti la possibilità di muoversi nel mondo come gli scienziati, la possibilità di fare ricerca nel proprio ambito di interesse, anche al limite nella ricerca di lavoro a livello europeo.
Gli scienziati come Figalli si muovono nel mondo per fare la loro ricerca e se ne infischiano delle questioni politiche. Vanno là dove ci sono possibilità, economiche, di ricerca e di conoscenza di cose nuove. Mostrano a tutti quella che può essere la realtà di tutti i popoli del mondo. Quella di muoversi nel mondo senza i confini politici che sono solo delle linee tracciate sulla carta geografica.
Il problema non è quello di far restare le persone e gli scienziati in Italia ma quello di promuovere gli spostamenti di tutti gli scienziati nel mondo, quindi anche verso l’Italia.
Ognuno deve essere libero di scegliere dove vivere e studiare. Senza limitazioni.
Sarebbe ora che la sinistra comprendesse questa realtà e ne facesse una sua battaglia, anche se oggi sembra un’utopia.

L’editoriale di Matteo Fago è tratto da Left in edicola