Hanno cominciato i metalmeccanici e questo è pazzesco, perché tra i firmatari di quel contratto c’è anche la Fiom che consideravamo tutti come un’avanguardia nella difesa dei diritti dei lavoratori» denuncia, fuori dai denti, il medico e attivista Vittorio Agnoletto. «Il pericolo è che venga seppellito nei fatti il Servizio sanitario nazionale (Ssn)» rincara la dose Luca Benci, giurista esperto in diritto sanitario, autore di Tutela la salute (Imprimatur, 2017), lanciando un vero e proprio allarme. La minaccia a cui fanno riferimento è un fenomeno in forte crescita, caratterizzata da nomi all’apparenza tutt’altro che spaventosi: viene detta sanità integrativa, o welfare contrattuale. Si tratta di fondi di assistenza sanitaria per i lavoratori che hanno bisogno di cure, garantendo l’accesso a terapie e servizi – in teoria – non «passati dalla mutua», che si possono fruire anche in strutture private convenzionate.
Non sono polizze opzionali, bensì assicurazioni obbligatorie stipulate per contratto da tutti gli occupati di un particolare settore. Questi strumenti infatti, sempre più spesso, vengono inseriti direttamente in numerosi accordi collettivi nazionali, a spese dei datori di lavoro. La Cgil, in un documento del 2017 stilato dall’Area contrattazione e welfare, ne ha censiti circa 40, per una platea di sei milioni di lavoratori iscritti. «Dopo il caso dei metalmeccanici di due anni fa, adesso i fondi sanitari sono stati aggiunti praticamente in tutti gli accordi in fase di rinnovo», spiega Benci. Dalle Poste al commercio, dal turismo ai chimici. Strumenti del genere sono chiamati anche «secondo pilastro del welfare» (dando per scontato che il primo sia quello pubblico), ormai uno dei mantra dei giornali economici house organ del neoliberismo, e vengono presentati come la soluzione al dramma delle liste d’attesa infinite. «Alleggerisce il peso sugli ospedali pubblici e rende l’accesso alle cure più efficiente», si dice, giustificando l’esistenza dei fondi.
E allora, perché tanta preoccupazione per un sistema che sembra tutto sommato agevolare la vita quotidiana di milioni di italiani? Per capirlo, è necessario rimuovere la patina di propaganda che avvolge questi dispositivi, e tuffarsi nelle loro contraddizioni. «Prendiamo il caso degli operai metalmeccanici: si parla di fondi sanitari integrativi», chiarisce Benci. «Ma in realtà, informandosi sulle caratteristiche del fondo in questione chiamato MetaSalute, più che di sanità integrativa si scopre la presenza di tanta sanità sostitutiva. Se uno cerca quali sono le cure offerte, difatti, c’è ad esempio il ricovero, poi il parto cesareo e la procreazione medicalmente assistita: tutte prestazioni già coperte dal Ssn!».
«Possiamo dunque dedurre che tali fondi assicurativi siano concorrenti rispetto alla sanità pubblica. Non forniscono infatti solo odontoiatria, per dire, realtà martoriata e messa in un angolo dal Ssn. Stiamo parlando di trapianti, eco color doppler, tutto», gli fa eco Agnoletto. Sulla carta, però, questi fondi non escludono la libera scelta di rivolgersi alle strutture pubbliche, di pagare il ticket, e poi richiedere il rimborso. Ma perché aspettare fino – talvolta – a qualche mese per farsi rendere una cifra che viene direttamente anticipata dai fondi se ci si rivolge al privato convenzionato (il quale, per giunta, ha tempi di erogazione dei servizi generalmente più brevi)?
«La stessa Fiom, che ha presentato questi strumenti come una conquista portata a casa al momento della firma dell’accordo, li difende a spada tratta – spiega Agnoletto -. Sostiene che siano una cosa positiva per lavoratori e famiglie, e ribadisce l’impegno a fare in modo che i fondi indirizzino i pazienti verso le strutture pubbliche. Ma la situazione, al momento, è esattamente opposta. Nel programma che conduco (37.2, su Radio popolare, ndr) abbiamo ricevuto in diretta la testimonianza di un operaio, che in buona sostanza diceva: “Io dovevo fare delle visite, potevo farle nel pubblico, ma avrei dovuto attendere tre mesi per il rimborso, mentre nel privato non dovevo sborsare nulla; scusate, ma ho scelto il privato”». Fino a qui, dunque, sono chiari gli interessi per i big della sanità privata italiana, che in questo modo mettono in tasca un gigantesco portafoglio di clienti, che assai difficilmente (per usare un eufemismo) si sarebbero riusciti a procurare, in modo autonomo, sul mercato. Invece, per lavoratori ed imprese, come stanno realmente le cose?
«I sindacati si sono trovati stretti sull’offerta di trasferire 100 (una cifra del tutto simbolica, ndr) di aumento salariale in termini di welfare contrattuale, piuttosto che in termini di retribuzione», puntualizza con cura Marco Geddes da Filicaia, oncologo ed ex vice presidente del Consiglio superiore della sanità. «Ma in questo modo – prosegue -, i vantaggi più consistenti sono per i datori di lavoro, perché se avessero dovuto aggiungere quei 100 in busta paga, a quella cifra avrebbero dovuto sommare la quota per le trattenute, i contributi per la pensione, ecc. Mentre dall’altro lato, per il lavoratore, l’agevolazione è soltanto apparente. Perché se quei soldi li ricevesse nella forma di un semplice aumento, oltre ad avere 100 in più in tasca, otterrebbe maggiori oneri riflessi che si sarebbero poi riversati nella liquidazione e nella pensione». «Senza considerare inoltre – insiste il medico, autore de La salute sostenibile (Pensiero scientifico editore, 2018) – che di questo 100 versati al fondo, una buona parte finisce speso per l’intermediazione amministrativa di questi fondi, e poi che il mancato aumento salariale si traduce in un minor gettito fiscale. Risultato? Il dipendente vedrà la sanità pubblica restringersi ulteriormente».
Le carte in mano ai giocatori della partita, a questo punto, sono scoperte. «È chiaro – riprende Benci – che, col definanziamento del Ssn, non si riesca a fornire adeguate risposte di salute. Chi paga (di fatto, col prezzo di un mancato aumento, ndr) un fondo sanitario trova sì una alternativa nel privato, ma in tal modo egli paga due volte, perché continuerà con la fiscalità generale a sostenere il diritto a ricevere cure prestate dalle strutture pubbliche». E in tutto questo lo Stato, oltre a fare tagli, come si muove? Per averne una idea, è necessario aggiungere un elemento. A fianco di questi fondi sanitari, negoziati a livello nazionale, esiste una lunga fila di enti, casse e società di mutuo soccorso. Sono circa 300 in tutto, stando alle stime dell’anagrafe del ministero della Salute, comunicate l’anno scorso alla Cgil. Una parte dei quali figli di una contrattazione di secondo livello, cioè quella fatta in azienda. Per la quale, l’erario, riserva un «trattamento di cortesia».
«Io ho coniato un termine, lo chiamo welfare contrattuale a partecipazione statale – ironizza amaramente Franco Martini, segretario confederale della Cgil -, perché questi strumenti godono dal 2008 di una detassazione e, più recentemente, dal 2016 di una decontribuzione». All’interno del più antico sindacato italiano, si percepisce una diffusa consapevolezza dei rischi di questo trasferimento soft di utenti verso il privato. Consapevolezza che non porta però ad una inversione di rotta, visto che Cgil, Cisl e Uil stanno continuando a firmare contratti che prevedono questi strumenti. «È vero, le prestazioni previste dai singoli fondi, hanno iniziato ad invadere l’ambito dei livelli essenziali di assistenza», ammette Martini. «Noi su questo non siamo molto d’accordo».
Ma, prosegue, «è chiaro che il welfare contrattuale e la sanità integrativa non li puoi più fermare, ormai esiste una spesa privata per la salute che è notevolissima». Per questo, il sindacalista rilancia l’urgenza di mettere in pratica almeno alcuni correttivi: «Chiedere il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, una battaglia tutta da rimettere in piedi», dopodiché, aggiunge, «convenzionare il “secondo pilastro” col pubblico» e poi fare attenzione alle prestazioni assicurate, perché «lampada abbronzante e buono per la benzina, per fare alcuni esempi, non sono welfare contrattuale, sono benefit, e non possono essere sostenuti dallo Stato».
Correttivi, questi, che il sindacato propone nella speranza di scongiurare ciò che considera come «il rischio più grande». Ossia che la popolazione italiana si spacchi ancora di più, tra pazienti coperti dalle assicurazioni e gli altri, precari o lavoratori che non hanno polizze in contratto, sempre meno tutelati. «Il pericolo – chiosa Martini – è che se non governiamo questo processo, allarghiamo le disuguaglianze tra chi potrà difendersi e chi non potrà difendersi dalla crisi». Nel frattempo, la sanità integrativa va a gonfie vele. E la sensazione è il pericolo in questione sia già realtà. Se i confederali, finalmente, avessero voglia di opporsi con serietà e coraggio a questo business, dovrebbero sbrigarsi.

L’inchiesta di Leonardo Filippi è tratta da Left n. 19 dell’11 maggio 2018
SOMMARIO ACQUISTA


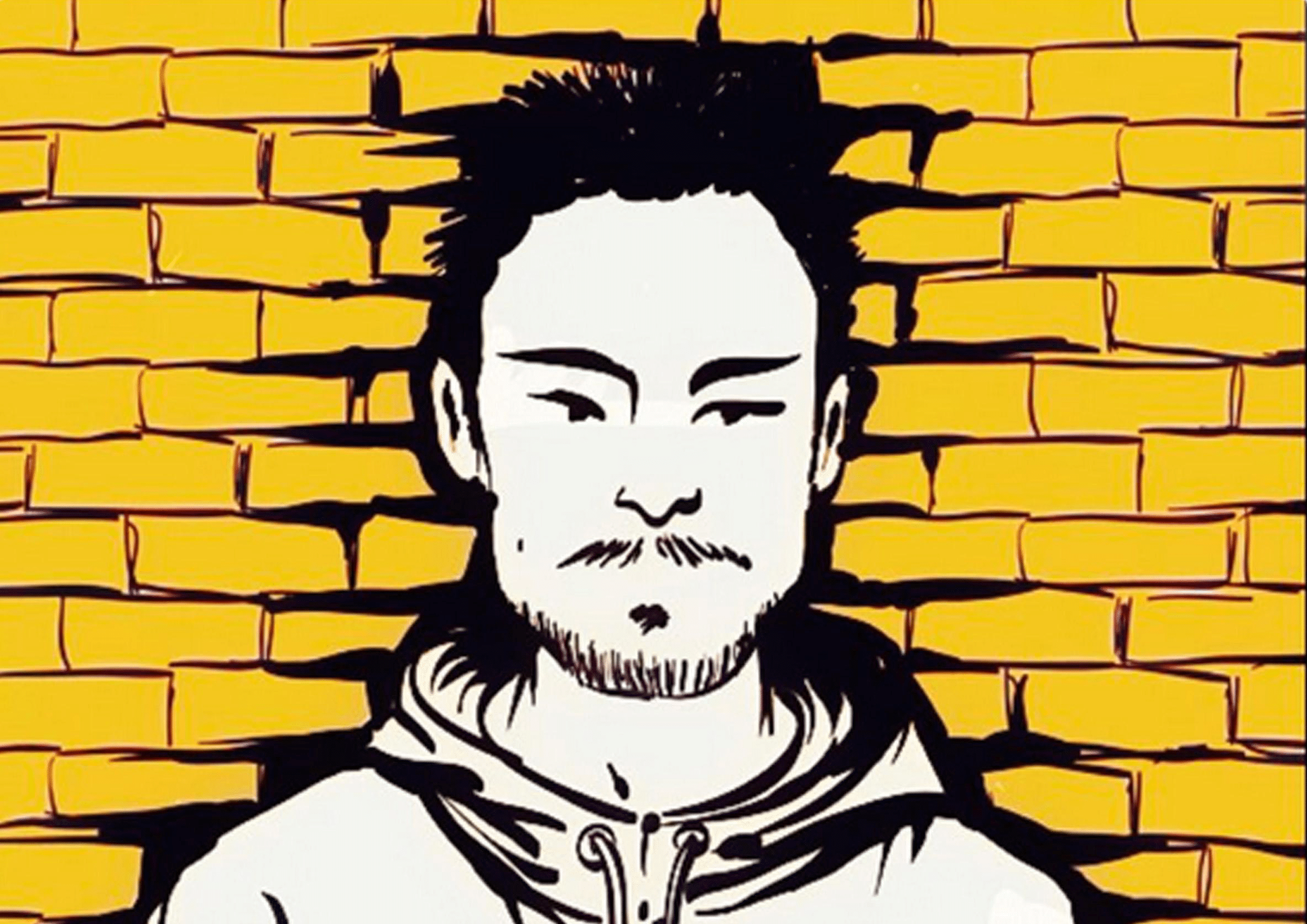



 Con Galli e Ventura alla libreria Odradek di Milano c’è anche l’economista Ernesto Longobardi di fronte a un pubblico attento e coinvolto. La conversazione con l’autore ruota intorno al quesito su come uscire, appunto, dal «flagello del neoliberismo» che ha, ovunque in Europa, prodotto diseguaglianze economiche e sociali, impoverimento, non solo materiale, delle persone e crollo di ogni possibile speranza per il futuro, in particolare per giovani e millenials.
Con Galli e Ventura alla libreria Odradek di Milano c’è anche l’economista Ernesto Longobardi di fronte a un pubblico attento e coinvolto. La conversazione con l’autore ruota intorno al quesito su come uscire, appunto, dal «flagello del neoliberismo» che ha, ovunque in Europa, prodotto diseguaglianze economiche e sociali, impoverimento, non solo materiale, delle persone e crollo di ogni possibile speranza per il futuro, in particolare per giovani e millenials. 






